

Parco dei Monti Livornesi (mappa) info a seguire .......SEGNALATECI I COLLEGAMENTI CHE FOSSERO INTERROTTI per poter aggiornare la pagina ove possibile
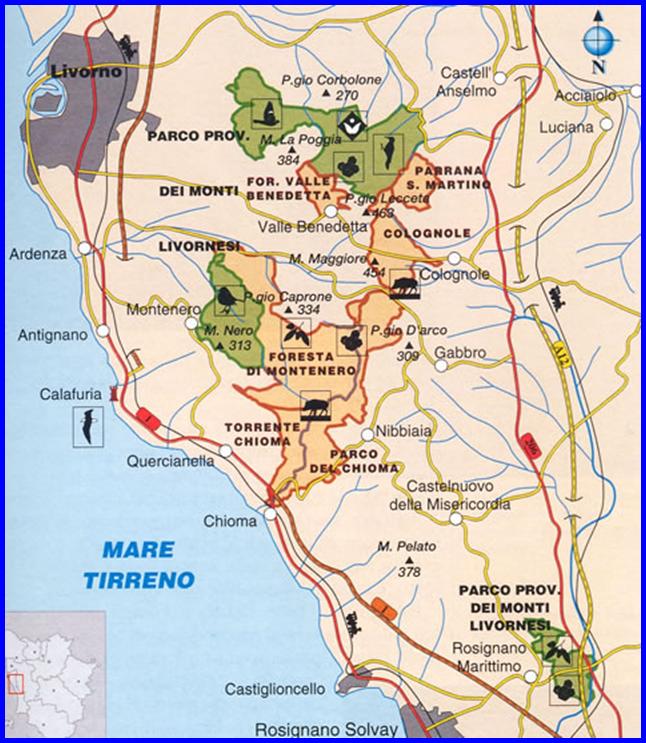
in verde il Parco, come previsto dal Piano, in giallo le aree A.N.P.I.L (tratta da guida Ceccolini e Cenerini)
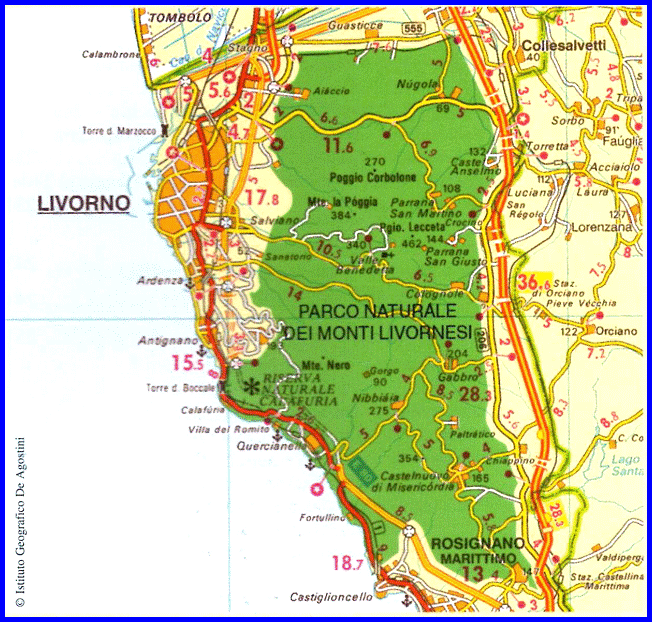
in verde l'area del Parco naturale dei Monti livornesi, come era inteso in origine
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
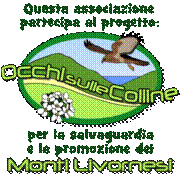 per gli aggiornamenti
sull'avanzamento del progetto, vi invitiamo ad andare sul sito appositamente
creato e con il quale è possibile interagire:
http://www.occhisullecolline.it/
per gli aggiornamenti
sull'avanzamento del progetto, vi invitiamo ad andare sul sito appositamente
creato e con il quale è possibile interagire:
http://www.occhisullecolline.it/Nel Parco naturale dei monti livornesi (foto)
Verso una mappa di comunità (laboratorio)
Normativa del Piano:
Capo
I – Disposizioni generali
Art. 1 – Finalità,
ambito di applicazione e contenuti del Piano
Art. 2 - Gestione
del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi
Art. 3 - Modalità
di formazione ed approvazione del Piano.
Art. 3 - Efficacia
del Piano
Art. 4 -
Attuazione del Piano
Art. 6 - Elaborati
costitutivi
Art. 7 - Quadro
conoscitivo
Capo II –
Disciplina degli ambiti territoriali
Art. 8 – Sistema
delle Aree Protette dei Monti Livornesi
Art. 9 – Parco
Provinciale
Art. 10 – Aree
Naturali Protette di Interesse Locale
Art. 11 – Aree
esterne al Sistema delle Aree Protette
Capo III –
Indirizzi di tutela delle componenti naturalistiche ed ambientali
Art. 12 –
Indirizzi di tutela delle componenti naturalistiche, ambientali e paesistiche
Art. 13 – Tutela
della flora e della vegetazione naturale
Art. 14 – Tutela
della fauna
Art. 15 – Tutela
delle emergenze geologiche e paleontologiche
Art. 16 – Tutela
del suolo
Art. 17 – Tutela
delle acque
Art. 18 – Tutela
delle componenti di interesse archeologico,
storico,
paesaggistico ed ambientale
Art. 19 –
Recupero del patrimonio edilizio esistente
Capo IV –
Gestione e fruizione del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi
Art. 20 –
Gestione e fruizione del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi
Art. 21 –
Accessi e percorsi
Art. 22 –
Strutture e servizi
Art. 23 – Piani
Attuativi e di settore
Art. 24 –
Progetti specifici
Art. 25 –
Indirizzi per la predisposizione del Regolamento del Parco
e del Piano
Pluriennale Economico e Sociale
Capo IV -
Disposizioni finali
Art. 26 -
Procedure autorizzative
Art. 27 –
Vigilanza
Art. 28 –
Sanzioni
Capo I – Disposizioni generali
Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e contenuti
del Piano
1. Il Piano del Parco dei Monti Livornesi è finalizzato a
garantire la conservazione e la
valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio, del
patrimonio storico culturale e naturalistico
all’interno del Sistema delle Aree Protette dei Monti
Livornesi, ed a promuovere le attività
compatibili nel rispetto dei principi e dei criteri
stabiliti dalla L. 6.12.1991 n. 394 e dalla L.R.
11.4.1995 n. 49, nonché degli indirizzi e delle
prescrizioni del Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia di Livorno.
2. L’ambito territoriale di applicazione del Piano è
costituito dalle aree comprese nel Parco
Provinciale dei Monti Livornesi, istituito in attuazione
del Sistema Provinciale delle Aree
Protette di cui alla del. C. P. n. 346 del 27.09.96. Il
Piano fornisce inoltre direttive ed indirizzi
per la pianificazione unitaria del Sistema delle Aree
Protette dei Monti Livornesi, oggetto di
specifico accordo di programma sottoscritto dalla Provincia
di Livorno e dai Comuni di
Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo.
Il Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi è
costituito:
− dal Parco Provinciale dei Monti Livornesi istituito
dalla Provincia di Livorno con
deliberazione n. 936 del 19.2.1999;
− dalle Aree Naturali Protette di Interesse Locale
dei Comuni di Livorno, Collesalvetti e
Rosignano Marittimo istituite con specifica deliberazione
dalle rispettive
Amministrazioni comunali.
3. Il Piano del Parco dei Monti Livornesi costituisce lo
strumento unitario di riferimento per la
pianificazione e la gestione degli ambiti territoriali
facenti parte del Sistema delle Aree Protette
dei Monti Livornesi, nel rispetto delle competenze
territoriali ed amministrative stabilite dalla
legislazione vigente.
4. Il Piano del Parco, in conformità ai principi stabiliti
all’art. 12 della L. 6.12.1991 n. 394 e nel
rispetto del P.T.C. di cui alla L.R. 16.1.95 n.5, individua
in via definitiva i perimetri del Parco
Provinciale e disciplina:
a) l’organizzazione generale del territorio e la sua
articolazione in funzione delle diverse forme
di uso, di godimento e di tutela;
4
b) i vincoli, le destinazioni d’uso pubblico o privato e
le relative norme di attuazione con
riferimento ai vari ambiti ed aree individuate;
c) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, con
particolare riguardo ai percorsi, agli accessi
ed alle strutture riservate ai disabili, ai portatori di
handicap ed agli anziani;
d) i sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la
funzione sociale del Parco
e) gli indirizzi ed i criteri per gli interventi sulla
flora, sulla fauna e sull’ambiente naturale in
genere
f) gli ambiti territoriali e gli interventi in relazione ai
quali si procede attraverso strumenti
attuativi particolareggiati.
g) le procedure di attuazione del Piano.
5. L’esercizio delle attività consentite entro
l’ambito territoriale di applicazione del Piano è
disciplinato, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi
espressi dal Piano stesso, dal Regolamento di
cui agli artt. 12 e 19 della L.R. 11.4.1995 n. 49. Tale
strumento potrà essere approvato
contestualmente all'approvazione del Piano e comunque non
oltre sei mesi dall'approvazione
del medesimo.
Art. 2 - Gestione del Sistema delle Aree Protette dei
Monti Livornesi
1. In conseguenza dello specifico accordo di programma fra
la Provincia ed i comuni interessati,
gli ambiti territoriali facenti parte del Sistema delle
Aree Protette dei Monti Livornesi di cui al
comma 2 del precedente art. 1 sono oggetto di gestione
unitaria da parte della Provincia che
esercita tale funzione di concerto con i comuni competenti,
direttamente o attraverso la
costituzione di aziende speciali o istituzioni in
attuazione della L. 8.6.1990 n. 142.
2. In via sperimentale, la succitata convenzione individua
l’organismo gestore denominato
“Autorità del Parco” e composto dalla Commissione e
dagli Uffici del Parco, nonché dagli
organismi consultivi di partecipazione e di consulenza
scientifica da nominare con atti
successivi.
3. La Provincia garantisce la partecipazione degli enti
locali alla gestione del Sistema delle Aree
Protette dei Monti Livornesi in applicazione dei contenuti
dell’art.9 della L. 6.12.1991 n. 394,
nonché di quanto stabilito nello specifico accordo di
programma.
Art. 3 - Modalità di formazione ed approvazione del
Piano.
1. La Provincia promuove la formazione del Piano del Parco
quale strumento di tutela dei valori
naturali ed ambientali del Sistema delle Aree Protette dei
Monti Livornesi. Il processo di
formazione del Piano deve garantire la partecipazione degli
enti locali interessati in conformità
ai principi ed alle finalità della L. 6.12.1991 n. 394 e
della L.R. 11.4.1995 n. 49
2. Le disposizioni del Piano inerenti al Parco Provinciale
sono approvate dalla Provincia secondo
le procedure definite dall’art. 11 della LR. 11.4.1995 n.
49. Le eventuali varianti al Piano
seguono le stesse procedure sopra descritte.
3. Le disposizioni del Piano inerenti alle A.N.P.I.L. sono
approvate dai Comuni competenti
secondo le procedure definite dall’art. 19 della LR.
11.4.1995 n. 49. Le eventuali varianti al
Piano seguono le stesse procedure sopra descritte.
Art. 3 - Efficacia del Piano
1. Il Piano del Parco ha valore di Piano Paesistico e di
Piano urbanistico. In conformità con
quanto stabilito dalla LR. 11.4.1995 n. 49, il Piano del
Parco ha effetto di dichiarazione di
pubblico generale interesse, di urgenza e di indifferibilità
per gli interventi in esso previsti e
sostituisce, negli ambiti territoriali oggetto di
disciplina, i piani paesistici, territoriali ed
urbanistici di qualsiasi livello.
Art. 4 - Attuazione del Piano
1. Il Piano si attua attraverso i seguenti strumenti:
a) Piani di Settore o strumenti attuativi particolareggiati
predisposti dall’organismo di
gestione o da altri soggetti competenti in attuazione delle
previsioni del Piano.
b) Interventi diretti da parte dell’organismo di gestione
o di altri soggetti competenti
relativi ad opere o azioni previste dal Piano, quali
interventi di manutenzione o
realizzazione di strutture ed infrastrutture del Parco,
interventi di gestione forestale e
naturalistica, interventi di ripristino ambientale e messa
in sicurezza, ecc.
c) Piani di settore e Piani Attuativi di cui all’art. 31
della L.R. 16.1.95 n.5 (Piani
Particolareggiati, Piani di Recupero, Piani di gestione
forestale, ecc.) di iniziativa
pubblica o privata convenzionata, nei casi e secondo le
modalità specificatamente
previste dal Piano.
d) Interventi diretti da parte di soggetti pubblici e
privati
Gli interventi sopra descritti sono subordinati, nei casi
previsti dalla legislazione vigente, al
preventivo nulla osta dell’organismo di gestione. Al
nulla osta si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 della L. 6.12.1991
n. 394.
2. L’ente gestore provvede inoltre all’ordinaria
gestione del Piano attraverso:
a) L’applicazione della presente normativa, anche
attraverso azione di vigilanza sul
territorio del Parco e segnalazione agli Enti competenti di
eventuali infrazioni;
b) La corresponsione di indennizzi o di incentivi
finanziari a soggetti pubblici e/o privati
nei casi previsti dalla legislazione nazionale e regionale
vigente o dal presente strumento.
Art. 6 - Elaborati costitutivi
1. Il Piano del Parco è costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione generale ed allegati (schede tematiche)
- Norme del Piano ed allegati (schede per le disciplina del
patrimonio edilizio)
- Elaborati grafici:
a) Analisi svolte ad integrazione del quadro conoscitivo
esistente:
- Tav. 1 – Uso del suolo (scala 1:25.000)
- Tav. 2 – Vegetazione (scala 1:25.000)
- Tav. 3 – Densità degli appostamenti fissi di caccia
(scala 1:25.000)
b) Sintesi interpretativa degli elementi del quadro
conoscitivo:
- Tav. 4 – Emergenze storiche, archeologiche ed
architettoniche (scala 1:25.000)
- Tav. 5 – Emergenze naturalistiche (scala 1:25.000)
- Tav. 6 – Sensibilità ambientali (scala 1:25.000)
c) Piano del Parco – proposta progettuale
- Tav. 7 – Relazioni con il sistema territoriale delle
aree protette (scala 1:175.000)
- Tav. 8 – Sistema delle aree protette dei Monti
Livornesi (scala 1:25.000)
- Tav. 9 – Zonazione del Parco e delle A.N.P.I.L. (scala
1:25.000)
- Tav. 10 – Organizzazione degli accessi, dei percorsi,
dei servizi (scala 1:25.000)
- Tav. 11 – Sentieristica (scala 1:25.000)
- Tav. 12 – Dettaglio delle previsioni (scala 1:10.000)
Art. 7 - Quadro conoscitivo
1. Il Quadro Conoscitivo dettagliato delle risorse
essenziali del territorio, così come definite
dall’art.2 della L.R. 16.1.95 n°5, fa parte integrante
del Piano del Parco e costituisce il
riferimento fondamentale per la definizione degli atti di
governo del territorio e per la verifica
dei loro effetti. Il Quadro Conoscitivo costituisce
indirizzo per la formazione del Regolamento
e dei Piani di settore, nonché per le varianti e gli
aggiornamenti dello stesso Piano del Parco.
2. Il Quadro Conoscitivo del Piano del Parco è costituito
da:
a) Quadro conoscitivo delle risorse contenuto nel PTC
provinciale
b) Repertorio degli studi esistenti sul territorio dei
monti livornesi
c) Studi e ricerche svolte preliminarmente alla formazione
del Piano
L’ente gestore dovrà costituire presso la propria sede
un archivio permanente ed aggiornabile
dei documenti sopra descritti, accessibile e consultabile
da tutti i cittadini, secondo le modalità
di legge.
3. Attraverso il Sistema Informativo Territoriale della
Provincia, il Quadro Conoscitivo viene
costantemente aggiornato nel rispetto delle disposizioni
dell’articolo 4 della L.R 16.1.95 n.5.
8
Capo II – Disciplina degli ambiti territoriali
Art. 8 – Sistema delle Aree Protette dei Monti
Livornesi
1. Il Piano del Parco disciplina gli ambiti territoriali
facenti parte del Sistema delle Aree Protette
dei Monti Livornesi mediante la definizione di
prescrizioni, direttive ed indirizzi differenziati
per i singoli ambiti. In relazione alle specifiche valenze
storiche, naturalistiche ed ambientali
individuate nel Quadro Conoscitivo di cui all’art. 7 ed
in funzione degli obiettivi stabiliti dal
Piano, detti ambiti sono ulteriormente articolati in aree
caratterizzate da differenti gradi di
accessibilità, fruizione e tutela.
2. In particolare, il Piano contiene disposizioni ed
indirizzi relativi a:
− Aree ricadenti nel Parco Provinciale dei Monti
Livornesi, al cui interno sono individuate
le “Aree di Particolare Tutela”, caratterizzate da un
maggiore grado di protezione in
relazione ai valori naturalistici ed ambientali presenti.
− Aree ricadenti nelle A.N.P.I.L. dei comuni di
Collesalvetti, Livorno e Rosignano, la cui
disciplina è definita dallo specifico Regolamento di
Gestione ai sensi della L.R. 49/95. Il
Piano individua anche nelle A.N.P.I.L., con valore
propositivo per le Amministrazioni
comunali competenti, alcune “Aree di Particolare
Tutela”, richiedenti un maggiore
grado di protezione in relazione ai valori naturalistici ed
ambientali presenti.
Art. 9 – Parco Provinciale
1. Il Parco Provinciale dei Monti Livornesi, istituito
dalla Provincia di Livorno con deliberazione
n. 936 del 19.2.1999, comprende aree di proprietà pubblica
(Regione Toscana, Comune di
Rosignano Marittimo) e privata. In tali aree il Piano
disciplina le modalità di accesso e fruizione,
la realizzazione di interventi edilizi, l’esercizio delle
attività agricole, ed in generale tutte le
attività suscettibili di avere effetti sull’equilibrio
ecologico e sull’assetto paesaggistico del Parco.
In relazione agli obiettivi di tutela e conservazione
perseguiti dal Piano, all’interno del Parco
Provinciale sono individuate aree caratterizzate da un
maggiore grado di protezione,
denominate Aree a Particolare Tutela. Tali ambiti, la cui
disciplina è definita al successivo
comma 4, sono oggetto di differenti modalità di
accessibilità, fruizione e tutela rispetto al resto
del Parco.
2. Nelle aree ricadenti all’interno del Parco Provinciale
valgono le disposizioni di cui ai successivi
commi.
3. L’accesso e la circolazione sono consentiti con le
seguenti limitazioni e modalita:
- l’accesso e la circolazione con mezzi motorizzati sono
consentiti al personale dell’ente
gestore ed ai soggetti autorizzati dall’ente stesso per
motivi di servizio o di studio. L’accesso
e la circolazione con mezzi motorizzati è consentita
inoltre ai residenti ed agli aventi titolo
di accesso a proprietà fondiarie situate nel Parco,
limitatamente ai tratti necessari per
raggiungere tali residenze e proprietà e comunque
subordinatamente a rilascio di specifica
autorizzazione da parte dell’ente gestore.
- l’accesso e la circolazione equestre, ciclistica o con
altri mezzi non motorizzati sono
consentiti esclusivamente all’interno dei percorsi
opportunamente predisposti e segnalati
dall’ente gestore con specifica cartellonistica.
- l’accesso e la circolazione pedonale, purché condotti
nel rispetto dei luoghi e dell’ambiente
naturale, sono liberamente consentiti, ad eccezione delle
zone di cui al seguente comma 4.
4. Nelle zone individuate negli elaborati grafici del Piano
come Aree di Particolare Tutela l’accesso e la fruizione sono controllati
dall’ente gestore al fine di garantire la salvaguardia e la conservazione dei
valori naturalistici ed ambientali presenti. In queste aree l’accesso e la
circolazione sono consentiti esclusivamente all’interno
dei percorsi opportunamente predisposti e segnalati dall’ente gestore con
specifica cartellonistica (di carattere informativo e scientificodidattico).
In relazione alle diverse esigenze di tutela, l’ente
gestore potrà individuare specifiche
modalità di fruizione per le singole A.P.T. (visite
guidate, limitazione del numero di accessi,
divieto di accesso in particolari periodi , ecc.).
5. Non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni
edilizie e di nuove strade o altre
infrastrutture, ad eccezione degli interventi
specificatamente finalizzati alla promozione ed alla
valorizzazione del parco previsti dal Piano attraverso
specifici Piani Attuativi e
subordinatamente alla valutazione degli effetti ambientali
delle trasformazioni ai sensi dell’art.
32 della L.R. 5/95. Sono consentiti interventi di recupero,
riqualificazione e ristrutturazione
degli edifici e dei complessi edilizi esistenti nel
rispetto delle indicazioni e della disciplina di
dettaglio contenuta nell’art. 19 delle presenti norme.
6. Le attività agricole dovranno essere condotte secondo
criteri di agricoltura biologica o, in
alternativa, adottare tecniche di coltivazione a basso
impatto. In tal senso le aziende presenti
dovranno presentare all’ente gestore specifici Piani
Aziendali (aventi i contenuti del Piano di
Miglioramento Agricolo Ambientale della L.R. 64/95 e succ.
mod.). L’utilizzazione a fini
agricoli di aree in stato di abbandono o in fase di
rinaturalizzazione (non considerabili come
aree boscate ai sensi della L.R. 39/2000) è consentita
esclusivamente attraverso la presentazione di specifici Piani Aziendali che
prevedano l’adozione di tecniche di agricoltura biologica. Non è ammessa
l’edificazione di nuovi annessi od altri edifici ad uso agricolo. Al fine
della riqualificazione e valorizzazione delle aziende agricole e faunistiche
presenti all’interno del Parco, l’ente gestore potrà promuovere uno
specifico piano di settore, esteso all’intero ambito
territoriale di competenza, che individui le esigenze e le
potenzialità di valorizzazione delle
aziende esistenti e preveda la possibilità di eventuali
interventi di ampliamento delle strutture
aziendali esistenti. Tale piano potrà valutare la
possibilità di interventi di promozione ed
incentivazione delle attività agricole presenti sul
territorio, anche attraverso la realizzazione di
consorzi o marchi pubblicitari.
7. E’ vietato l’esercizio dell’attività venatoria.
E’ consentita la raccolta dei prodotti secondari del
bosco nelle modalità previste dalla legislazione regionale
vigente, eccetto che nelle Aree di
Particolare Tutela di cui al precedente comma 1, dove tale
pratica potrà essere vietata o limitata dall’ente gestore in funzione di
particolari esigenze di tutela naturalistica ed ambientale. Il
Regolamento del Parco, da predisporre ai sensi della L.R. 11.4.1995 n.
49, preciserà nel dettaglio gli interventi e le attività consentite.
8. Tutti gli interventi che interessino le componenti
naturalistiche, paesaggistiche ed ambientali dell’area dovranno rispettare gli
indirizzi e le prescrizioni di cui al Capo III delle presenti norme.
Art. 10 – Aree Naturali Protette di Interesse Locale
1. Le Aree Naturali Protette di Interesse Locale dei Comuni
di Livorno, Collesalvetti e Rosignano
Marittimo, istituite da specifiche deliberazioni delle
Amministrazioni comunali predette.
comprendono aree di proprietà pubblica (Regione Toscana) e
privata. In tali aree, oggetto di
gestione unitaria con il Parco Provinciale, la disciplina
delle modalità di accesso e fruizione, la
realizzazione di interventi edilizi, l’esercizio delle
attività agricole, ed in generale tutte le attività suscettibili di avere
effetti sull’equilibrio ecologico e sull’assetto paesaggistico sono
disciplinate degli specifici Regolamenti di gestione approvati dai Comuni
competenti ai sensi della L.R. 49/95. L’Autorità del Parco assicura
l’unitarietà e la coerenza fra il Piano del Parco ed i Regolamenti delle
A.N.P.I.L., ai fini di una effettiva gestione unitaria del Sistema delle
Areeprotette dei Monti Livornesi.
Art. 11 – Aree esterne al Sistema delle Aree Protette
1. Il Piano del Parco prevede la possibilità di
localizzare, attraverso specifici accordi con i comuni
interessati, strutture e servizi del parco anche
all’esterno del perimetro dell’Area Protetta, in una logica di integrazione
funzionale dei diversi ambiti territoriali. All’interno di tali aree potrà
inoltre essere estesa, sotto il coordinamento dell’ente
gestore, la rete di sentieristica e la
segnaletica informativa del Parco, assicurando la reale
continuità di fruizione del territorio.
Capo III – Indirizzi di tutela delle componenti
naturalistiche ed ambientali
Art. 12 – Indirizzi di tutela delle componenti
naturalistiche, ambientali e paesistiche
1. Il Piano del Parco definisce indirizzi per la tutela e
la valorizzazione delle diverse componenti naturalistiche ed ambientali. Tali
indirizzi si compongono di:
− Criteri e direttive per la formazione di piani e
programmi e per la gestione naturalistica
del Parco: a tali criteri e direttive sono tenuti ad
attenersi l’ente gestore e gli altri soggetti
pubblici e privati nel predisporre programmi, piani e
progetti specifici, nonché
nell’attuazione degli interventi di gestione ordinaria e
straordinaria.
− Disposizioni normative per la disciplina delle
attività e dei comportamenti antropici
all’interno del Parco.: tali disposizioni sono
immediatamente efficaci ed operative nei
confronti dei soggetti pubblici e privati operanti nelle
Aree Protette, della popolazione
residente e dei visitatori.
Art. 13 – Tutela della flora e della vegetazione
naturale
1. Il Piano ha come obiettivo la conservazione e la tutela
dei valori floristici e vegetazionali
presenti nell’area del Parco, da perseguire favorendo lo
sviluppo spontaneo delle specie
autoctone o storicamente presenti nell’area verso
condizioni di equilibrio e stabilità ambientale crescenti.
2. In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno
essere adottate politiche di gestione
“passiva” della vegetazione e della flora, con
interventi mirati esclusivamente alla prevenzione
ed al superamento di condizioni di criticità in grado di
generare degrado dell’ecosistema (azioni
antropiche, patologie, incendi, ecc.). Sono pertanto da
evitare politiche di gestione forestale
finalizzate ad usi produttivi e/o colturali, in particolare
per quanto riguarda il patrimonio
forestale demaniale.
3. Gli interventi forestali pubblici e gli interventi
selvicolturali attuati da soggetti privati sono
ammessi nelle modalità e con le procedure stabilite dalla
L.R. 39/2000 e comunque previo nulla osta dell’ente gestore. Tali interventi
dovranno essere coerenti con quanto stabilito dal presente Piano, ed in
particolare con gli indirizzi indicati ai commi successivi.
4. All’interno delle aree boscate dovrà essere favorito
il processo di sviluppo spontaneo delle
specie autoctone, prevedendo interventi puntuali solo per
situazioni di criticità in
corrispondenza di sentieri o spazi di fruizione (alberi
crollati, vegetazione invasiva dei percorsi,ecc.). In tutti gli altri casi dovrà
essere favorito il consolidamento del bosco, anche attraverso la conservazione
della necromassa ed il mantenimento del soprassuolo spontaneo.
In relazione alla necessità di prevenzione degli incendi
potranno essere previsti, all’interno di
piani specifici approvati dall’ente gestore, interventi
di diradamento degli impianti di conifere ed altri interventi indirizzati alla
graduale riduzione della componente rappresentata dalle specie resinose a
vantaggio delle latifoglie. E’ comunque importante non eliminare mai del tutto
le conifere perché esse rivestono il ruolo biologico dei grandi alberi.
L’ente gestore potrà consentire interventi specifici
sulle singole cenosi forestali in presenza di
accertati fenomeni di degrado (patologie, presenza di
specie nocive o infestanti, ecc.)
5. Dovranno essere oggetto di tutela le aree di margine
forestale, in ragione della loro importanza quali spazi ecotonali. L’ente
gestore del Parco dovrà predisporre specifiche misure di salvaguardia, anche
attraverso l’individuazione di zone di rispetto, vietandone l’utilizzo a
fini agricoli e qualsiasi altro tipo di trasformazione morfologica ed
ambientale.
6. Nelle aree agricole abbandonate dovrà essere favorito
il recupero naturale della vegetazione, preferibilmente arrestato allo stadio di
prato/pascolo o arbusteto. La permanenza di aree a prato/pascolo è ritenuta
positiva come fattore di diversificazione ambientale e paesaggistica; per queste
aree è ammessa la gestione tramite pascolamento e sfalcio a rotazione
periodica. In alternativa, l’ente gestore potrà promuovere il recupero
programmato di queste aree con attività produttive compatibili (agricoltura di
qualità e biologica).
7. Dovranno essere promossi, anche attraverso la
predisposizione di specifici piani da parte
dell’ente gestore, interventi mirati al mantenimento
della biodiversità floristica. In particolare si
dovrà procedere al riconoscimento ed al censimento delle
specie floristiche di elevato valore
ambientale, nonché all’individuazione delle aree
floristiche, con regolamentazione delle attività
che comportano danneggiamento o disturbo delle specie in
funzione del grado di protezione
stabilito per le singole specie o nelle singole aree
(raccolta, danneggiamento, transito con
automezzi al di fuori dei percorsi esistenti, alterazioni
dell’assetto dei suoli, ecc.). La
reintroduzione di specie floristiche è subordinata alla
preventiva autorizzazione da parte
dell’ente gestore. Le eventuali reintroduzioni dovranno
essere finalizzate al miglioramento del
livello di biodiversità, considerando reintroducibili le
specie per le quali esistono precise
testimonianze storiche della loro presenza oppure quelle
comunque tipiche dell’areale di
appartenenza. La compatibilità di tali interventi dovrà
essere valutata caso per caso.
8. E’ vietata la raccolta ed il danneggiamento della
flora. Il Regolamento del Parco, da predisporre ai sensi della L.R. 11.4.1995 n.
49, preciserà nel dettaglio gli interventi consentiti sulla vegetazione e
regolamenterà la raccolta dei prodotti secondari del bosco.
Art. 14 – Tutela della fauna
1. Il Piano ha come obiettivo la protezione della fauna
presente nell’area del Parco, da perseguire
favorendo la formazione ed il mantenimento di un
equilibrato rapporto tra le specie.
2. In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno
essere promosse azioni dirette ed indirette
per la tutela e la gestione delle specie faunistiche,
predisponendo idonee misure per la
conservazione degli habitat naturali, controllando e
regolamentando gli interventi per
l’incremento o il contenimento delle singole specie,
disciplinando le modalità di esercizio
dell’attività venatoria e delle altre attività
antropiche in grado di arrecare disturbo alla fauna.
3. E’ vietata, in linea generale, ogni forma di disturbo
e danneggiamento della fauna. Il Piano
individua al Capo II delle presenti norme le aree nelle
quali è vietato l’esercizio dell’attività
venatoria; nelle restanti aree è consentito l’esercizio
dell’attività venatoria nei limiti e nelle
modalità previste dalla legislazione nazionale e regionale
vigente, nonché dagli specifici Piani
approvati dall’ente gestore del Parco. In relazione a
particolari esigenze di tutela delle specie
faunistiche, l’ente gestore del Parco può disporre la
temporanea sospensione dell’attività
venatoria in aree specificatamente individuate, indicando
le modalità e le condizioni necessarie per la ripresa dell’attività stessa.
4. Dovranno essere promossi, anche attraverso la
predisposizione di specifici piani da parte
dell’ente gestore, interventi mirati al mantenimento
della biodiversità faunistica. In particolare si dovrà procedere al
riconoscimento ed al censimento delle specie faunistiche di elevato valore
ambientale, nonché all’individuazione degli habitat naturali delle specie,
con regolamentazione delle attività che comportano disturbo delle specie in
funzione del grado di protezione stabilito (regolamentazione degli accessi in
aree e periodi caratterizzati da particolare presenze o comportamenti della
fauna, divieto di attività rumorose, ecc.) e realizzazione di interventi per
l’incremento della fauna autoctona (nidi artificiali, punti di abbeverata,
ecc.). Dovranno essere inoltre promossi interventi per la conservazione degli
habitat naturali delle specie mediante il mantenimento degli elementi diffusi
del paesaggio agrario (siepi, vegetazione ripariale, ecc.) e la regolamentazione
dell’uso di pesticidi e diserbanti nelle attività agricole.
5. La reintroduzione di specie faunistiche è subordinata
alla preventiva autorizzazione da parte dell’ente gestore. Le eventuali
reintroduzioni dovranno essere finalizzate al miglioramento del livello di
biodiversità, considerando reintroducibili le specie per le quali esistono
precise testimonianze storiche della loro presenza oppure quelle comunque
tipiche dell’areale di appartenenza
La compatibilità di tali interventi dovrà essere valutata
caso per caso.
6. L’Ente gestore potrà promuovere la formazione di
specifici piani o programmi per eventuali
prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi,
necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco,
indicando gli obiettivi prefissati ed i risultati da raggiungere per gli
interventi previsti da tali piani o programmi. Prelievi e abbattimenti devono
avvenire per
iniziativa e sotto la diretta responsabilità e
sorveglianza dell'Ente gestore ed essere attuati dal
personale dell'Ente gestore o da persone all'uopo
espressamente autorizzate dall'Ente gestore stesso.
7. Il Regolamento del Parco, da predisporre ai sensi della
L.R. 11.4.1995 n. 49, preciserà nel
dettaglio gli interventi e le attività consentite nelle
diverse aree del Parco.
Art. 15 – Tutela delle emergenze geologiche e
paleontologiche
1. Il Piano ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione
delle emergenze e dei siti di interesse
geologico e geomorfologico presenti nell’area del Parco,
con particolare riferimento alle
formazioni rocciose ed ai minerali, nonché alle emergenze
geomorfologiche dovute a fenomeni
naturali (incisioni dei torrenti, frane) ed all’azione
umana (cave, miniere). Il Piano ha inoltre
come obiettivo la salvaguardia e la tutela delle emergenze
paleontologiche e dei giacimenti
fossiliferi.
2. In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno
essere adottate, anche attraverso la
predisposizione di specifici piani o progetti, idonee
misure di protezione per le aree interessate
da tali emergenze. In particolare si dovrà procedere al
riconoscimento ed al censimento delle
emergenze geologiche, geomorfologiche e paleontologiche di
elevato valore naturalistico,
scientifico e paesaggistico-ambientale, nonché
all’individuazione dei siti di interesse geologico e
paleontologico, regolamentando l’accesso e l’esercizio
di attività che comportano
danneggiamento o degrado (prelievo, danneggiamento,
transito con automezzi al di fuori dei
percorsi esistenti, alterazioni dell’assetto dei suoli,
ecc.).
3. Dovranno essere promossi inoltre, anche attraverso la
predisposizione di specifici piani o
progetti, interventi per la valorizzazione delle emergenze
geologiche, geomorfologiche e
paleontologiche, con individuazione delle modalità di
fruizione collegate ad attività scientifiche
e didattiche. A tale scopo potranno essere previsti
interventi di limitazione e controllo della
vegetazione spontanea per il mantenimento della visibilità
e riconoscibilità delle formazioni di
pregio, nonché la realizzazione di apposita segnaletica
contenente informazioni di tipo didattico
–scientifico.
4. E’ vietato il prelievo ed il danneggiamento di rocce,
minerali, fossili, se non per attività di ricerca scientifica e previa
autorizzazione dell’ente gestore. Il Regolamento del Parco, da predisporre ai
sensi della L.R. 11.4.1995 n. 49, preciserà nel dettaglio gli interventi e le
attività consentite nelle diverse aree del Parco.
Art. 16 – Tutela del suolo
1. Il Piano ha come obiettivo la tutela e la difesa dei
suoli, da perseguire promuovendo interventi
finalizzati a ridurne la fragilità idrogeologica ed a
favorire il raggiungimento di condizioni di
equilibrio dal punto di vista ambientale.
2. In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno
essere adottate, anche attraverso la
predisposizione di specifici piani o progetti, idonee
misure di protezione e riqualificazione per le
aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico
(zone in frana, zone soggette al rischio
idraulico, zone ad elevata vulnerabilità della falda, aree
di cava dismesse). In particolare si dovrà
procedere al riconoscimento ed al censimento delle
situazioni di rischio e dei fenomeni di
dissesto in atto, predisponendo, previe approfondite
analisi tecniche e scientifiche, interventi di
prevenzione e recupero ambientale quali: interventi di
regimazione idraulica, interventi di
consolidamento dei soprassuoli, interventi puntuali di
consolidamento e messa in sicurezza dei
versanti in presenza di fenomeni di dissesto.
3. L’ente gestore del Parco esercita le funzioni di cui
all’art. 70 della L.R. 39/2000 in materia di
prevenzione e repressione degli incendi boschivi, con le
modalità attuative previste nel Piano
Operativo Anti Incendi Boschivi predisposto dalla Regione.
A tale proposito l’ente gestore
dovrà adottare idonee misure e provvedimenti, anche
attraverso la predisposizione di specifici
piani e programmi, in coerenza con gli indirizzi di tutela
e valorizzazione della flora e della
vegetazione enunciati nella presente normativa. Gli
interventi forestali finalizzati alla
prevenzione incendi effettuati dai soggetti competenti per
legge sono comunque subordinati al
nulla osta da parte dell’ente gestore del parco.
4. In attesa della predisposizione di studi specifici e di
apposita normativa di dettaglio da parte
dell’ente gestore, tutti gli interventi previsti
all’interno del Parco dovranno rispettare le
prescrizioni e gli indirizzi in materia di difesa del suolo
contenuti nel vigente PTC della
Provincia di Livorno.
5. E’ vietata l’apertura e l’esercizio di cave, di
miniere, di discariche. Sono vietati inoltre tutti gli interventi che comportino
alterazione morfologica dei suoli e del regime delle acque o che
comunque aumentino la fragilità idrogeologica dei luoghi,
compresa la costruzione di nuove
strade, ad esclusione delle ordinarie lavorazioni agricole.
Per le attività estrattive attualmente in esercizio è ammessa la prosecuzione
delle attività esclusivamente nei tempi e nelle modalità previsti dalla
vigente convenzione. Ogni variazione o rinnovo della convenzione è subordinato
al nulla osta preventivo dell’Ente gestore
6. Sono consentiti interventi di recupero ambientale di
siti estrattivi e/o di aree degradate ed
inquinate, purchè attuati in coerenza con i principi di
tutela e conservazione dei valori
naturalistici ed ambientali dell’area protetta; tali
interventi sono subordinati a preventiva verifica di compatibilità da parte
dell’ente gestore mediante la valutazione dell’incidenza ambientale, ai
sensi della legislazione vigente, delle azioni previste. In tal senso,
l’Autorità del Parco dovrà esprime preventivo parere di compatibilità
relativamente ai progetti predisposti in attuazione del Piano Programma Atlante
per il ripristino delle aree ex estrattive del Comune di Livorno.
7. Il Regolamento del Parco, da predisporre ai sensi della
L.R. 11.4.1995 n. 49, preciserà nel
dettaglio gli interventi e le attività consentite nei
diversi ambiti disciplinati.
Art. 17 – Tutela delle acque
1. Il Piano ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione
delle acque, da perseguire promuovendo interventi finalizzati ad assicurare
l’equilibrio ecologico ed il corretto funzionamento del sistema idraulico,
salvaguardandone al tempo stesso i valori paesaggistici ed ambientali.
2. In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno
essere previste, anche attraverso la
predisposizione di specifici piani o progetti, azioni
dirette ed indirette per la salvaguardia ed il
mantenimento delle condizioni di naturalità ed funzionalità
ecologica dei corsi d’acqua, con
particolare riferimento ai torrenti ed ai botri che
caratterizzano l’area collinare del parco. Il
reticolo idraulico delle aree di pianura, prodotto da
azioni di bonifica finalizzate all’utilizzazione
agricola del territorio, dovrà essere mantenuto in
condizioni di efficienza e tutelato nelle sue
caratteristiche paesaggistiche significative (siepi,
alberature, manufatti idraulici ed opere di
regimazione, ecc.). Dovranno inoltre essere adottate le
necessarie misure per minimizzare le
condizioni di rischio idraulico.
Tutti gli interventi, sia quelli di gestione diretta che
quelli facenti parte di piani e programmi di
settore, dovranno conformarsi agli indirizzi di seguito
indicati.
3. Dovrà essere predisposta un’attività di monitoraggio
della qualità delle acque superficiali e
sotterranee, con analisi periodiche e regolamentazione dei
prelievi. Gli interventi per la
realizzazione di pozzi e di scarichi per lo smaltimento
delle acque sono soggetti a nulla osta da parte dell’ente gestore, che potrà
definire criteri, requisiti prestazionali e tecnologici specifici da soddisfare
in relazione agli obiettivi di tutela ambientale.
4. Particolare attenzione dovrà essere posta alla tutela
ed alla valorizzazione delle sorgenti con caratteristiche idrotermali presenti
nel parco, che costituiscono una risorsa locale di significativo valore.
L’ente gestore dovrà procedere al censimento ed allo studio delle sorgenti
esistenti, individuando, anche attraverso specifici piani o progetti, le
strategie e le modalità per la loro valorizzazione scientifica e per la
corretta fruizione.
5. Dovrà essere predisposta un’attività di monitoraggio
dello stato di conservazione degli alvei, al fine di programmi eventuali
interventi di manutenzione e pulizia laddove ritenuto necessario ed
in ogni caso con l’esclusiva finalità di prevenire situazioni di
rischio e garantire il corretto regime delle acque.
6. Non sono ammessi interventi di alterazione della
morfologia dell’alveo dei torrenti o comunque di corsi d’acqua, compresi le
opere di intubamento ed artificializzazione di tratti dei medesimi.
A tale scopo l’ente gestore potrà individuare adeguate
fasce di rispetto, comprensive delle
eventuali opere d’argine ed aree di espansione, anche per
i corsi d’acqua non soggetti a vincoli sovraordinati. Eventuali deroghe alle
suddette prescrizioni potranno essere autorizzate solo relative ad interventi di
regimazione idraulica e di messa in sicurezza non attuabili con altre tipologie
di opere.
7. Il Regolamento del Parco, da predisporre ai sensi della
L.R. 11.4.1995 n. 49, preciserà nel
dettaglio gli interventi e le attività consentite nei
diversi ambiti disciplinati dal Piano. In attesa
della predisposizione di studi specifici e di apposita
normativa di dettaglio da parte dell’ente
gestore, tutti gli interventi previsti all’interno del
Parco e delle A.N.P.I.L. dovranno rispettare le
prescrizioni e gli indirizzi in materia di rischio
idraulico contenuti nel vigente PTC della
Provincia di Livorno.
Art. 18 – Tutela delle componenti di interesse
archeologico,
storico, paesaggistico ed ambientale
1. Il Piano ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione
delle componenti di interesse
archeologico, storico, paesaggistico ed ambientale, con
particolare riferimento ai siti di interesse archeologico, alle emergenze
architettoniche e monumentali, ai manufatti storici testimonianza dell’antica
organizzazione colturale e produttiva del territorio (mulini, ghiacciaie,
ponticelli, fonti, muri a secco, ecc.), alla rete dei percorsi storici, alle
sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali (terrazzamenti, ciglioni, ecc.),
agli elementi naturali con valore paesaggistico e territoriale (esemplari
arborei monumentali, filari alberati, siepi, ecc.).
2. In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno
essere predisposte, anche attraverso la
predisposizione di specifici piani o progetti, misure ed
interventi per la salvaguardia e la
valorizzazione degli elementi sopra descritti. Tutti gli
interventi, siano essi attuati da soggetti
pubblici o privati, dovranno conformarsi agli indirizzi di
seguito indicati.
3. Nei siti di interesse archeologico sono ammessi
unicamente gli interventi volti alla tutela e alla valorizzazione sia dei
singoli beni archeologici che del sistema di relazioni che tali beni hanno
instaurato con il contesto ambientale e paesaggistico. L’ente gestore, in
accordo con gli altri enti competenti, dovrà promuovere, attraverso piani e
progetti specifici, misure per il
riconoscimento, il censimento e lo studio dei siti di
interesse archeologico esistenti, nonché per la regolamentata pubblica
fruizione di tali beni e valori. Fino all’approvazione di tali piani e
progetti nelle aree di interesse archeologico è vietato
qualsiasi intervento che comporti
trasformazione morfologica del suolo.
4. Le emergenze architettoniche e monumentali ed in
generale tutti i beni culturali vincolati ai
sensi del D. Lgs 490/99 sono soggetti esclusivamente ad
interventi di restauro conservativo. Per tali beni sono ammesse ed auspicate,
compatibilmente con le caratteristiche architettoniche e tipologiche,
destinazioni d’uso e forme di utilizzazione integrate con le attività del
Parco. A tale scopo, l’ente gestore potrà promuovere specifici programmi e
convenzioni con i soggetti pubblici e privati interessati.
5. I manufatti sopra individuati come elementi di valore
storico e ambientale (mulini, ghiacciaie, ponticelli, fonti, muri a secco,
ecc.), dovranno essere oggetto di manutenzione e, qualora sia
necessario, di restauro. Tali interventi devono essere
estesi all’immediato intorno spaziale ed
ambientale nel quale il manufatto è collocato, al fine di
salvaguardarne le relazioni spaziali e
percettive con il contesto ambientale di riferimento.
Potranno essere promossi, anche attraverso piani e progetti specifici,
interventi di restauro e valorizzazione dei manufatti storici estesi ad ambiti
territoriali unitari e collegati ad iniziative per la fruizione didattica e
ricreativa. Tutti gli interventi sui manufatti che superino la manutenzione
ordinaria sono soggetti a nulla osta dell’ente gestore.
6. Non è consentita l’alterazione del tracciato, della
giacitura, delle caratteristiche formali e
materiali dei percorsi vicinali e poderali, se non per
comprovate esigenze e comunque da
effettuarsi sempre previo nulla osta dell’ente gestore.
Dette strade, qualora non di proprietà
pubblica, dovranno essere oggetto di manutenzione da parte
dei proprietari dei fondi interessati;gli interventi di manutenzione dovranno
essere condotti secondo modalità e tecniche finalizzat a mantenere le
caratteristiche funzionali, morfologiche e materiali dei percorsi o a
ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state perdute in seguito a
mancata manutenzione od ainterventi alterativi. La rete dei percorsi storici
dovrà essere valorizzata nella sua interezza attraverso un progetto complessivo
di riqualificazione della sentieristica che preveda, oltre alla cura ed alla
manutenzione dei percorsi, la dotazione di spazi di sosta attrezzati, di
segnaletica e cartellonistica a carattere didattico-informativo, ecc.
7. Non è consentita la demolizione o l’alterazione delle
opere di sistemazione idraulico-agraria tradizionali quali, a titolo
esemplificativo, muretti a secco, terrazzamenti, lunette. Dovrà essere prevista
la manutenzione delle medesime senza modificarne l’assetto e le funzionalità
originarie. L’ente gestore potrà promuovere ed incentivare, anche attraverso
programmi e progetti specifici, interventi di restauro e valorizzazione di tali
opere, estesi ad ambiti territoriali unitari e collegati ad iniziative per la
fruizione didattica e ricreativa.
8. Per gli elementi naturali quali filari di cipressi,
alberi di carattere monumentale o di valore
paesaggistico, alberature di valore storico e ambientale
disposte lungo strade pubbliche e private o lungo i confini di proprietà, è
obbligatoria la tutela. Gli interventi di tutela devono essere estesi
all’immediato intorno spaziale ed ambientale nel quale l’elemento o gli
elementi sono collocati, al
fine di salvaguardarne le relazioni spaziali e percettive con il contesto di
riferimento.
Sono obbligatori interventi di manutenzione e difesa
fitosanitarie tesi alla conservazione di tali
elementi naturali. L’eventuale loro abbattimento potrà
essere autorizzato dall’ente gestore
esclusivamente per comprovati motivi fisiologici,
fitosanitari, di instabilità: la loro sostituzione
dovrà essere effettuata con piante della stessa specie.
Gli interventi di manutenzione dovranno essere condotti secondo modalità e
tecniche finalizzate a mantenere le caratteristiche peculiari degli stessi, o a
ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state perdute in seguito a
mancata manutenzione od a interventi alterativi. Tutti gli interventi non
classificabili come interventi di manutenzione sono soggetti a nulla osta
dell’ente gestore.
9. Al fine di tutelare le caratteristiche ambientali e
paesaggistiche del territorio, il Regolamento del Parco, da predisporre ai sensi
della L.R. 11.4.1995 n. 49, potrà prevedere una specifica
disciplina in merito alla realizzazione di opere di arredo
e di illuminazione, di recinzioni, di
pavimentazioni esterne, di sistemazioni vegetazionali,
siano esse a servizio della viabilità che di pertinenze private. Non è
comunque ammessa la recinzione dei fondi agricoli, eccetto che in presenza di
attività di allevamento e solamente finalizzata al soddisfacimento delle
esigenze di custodia degli animali. Il Regolamento preciserà nel dettaglio gli
interventi e le attività consentite nelle diverse aree del Parco.
Art. 19 – Patrimonio edilizio esistente
1. Il Piano ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione
del patrimonio edilizio esistente, con
particolare riferimento all’edilizia rurale storica, che
costituisce parte significativa e prevalente
del patrimonio edilizio presente nell’ambito territoriale
disciplinato.
2. In relazione alle finalità sopra enunciate, il Piano
definisce la disciplina per la conservazione, il recupero e la valorizzazione
degli edifici presenti nell’ambito territoriale di competenza. A questo scopo,
il Piano individua:
a) gli interventi e le destinazioni d’uso ammissibili per
ciascun edificio o complesso edilizio
presente nel Parco, attraverso la predisposizione di
specifiche schede di dettaglio comprendenti il rilevamento dello stato di fatto
e prescrizioni normative per l’attuazione degli interventi.
b) le aree ed i complessi edilizi per i quali ogni
intervento è subordinato alla preventiva
formazione di un Piano Attuativo, nei casi dove tale
strumento è ritenuto necessario per
procedere alla riqualificazione dell’esistente, nonché
le disposizioni normative per la redazione del piano.
3. La disciplina di cui al precedente comma 2 è definita
in coerenza con le disposizioni generali di seguito indicate:
a) Per gli edifici storici individuati attraverso gli studi
del quadro conoscitivo sono ammessi
interventi di restauro e riqualificazione finalizzati alla
conservazione dei caratteri
architettonici e tipologici di pregio. Le schede di cui al
comma precedente definiscono nel
dettaglio le categorie di intervento ammesse per i singoli
edifici.
b) Per gli edifici privi di valore storico e/o tipologico
sono ammessi interventi di
ristrutturazione edilizia con modifica degli elementi
strutturali, riorganizzazione distributiva
e riqualificazione dei prospetti nel rispetto del volume
esistente. Le schede di cui al comma
precedente definiscono nel dettaglio le categorie di
intervento ammesse per i singoli edifici.
c) Gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all’art. 4 comma 2 lettera d) punti 1) e 2) della
L.R. 52/99 sono ammessi unicamente per gli annessi ed i
manufatti pertinenziali privi di
valore storico e tipologico. Non sono ammessi interventi di
ristrutturazione edilizia di cui
all’art. 4 comma 2 lettera d) punto 3) della L.R. 52/99.
d) Per il patrimonio edilizio presente nell’ambito
territoriale disciplinato sono ammesse le
seguenti destinazioni d’uso:
- residenza permanente o temporanea;
- attività agricole o connesse all’agricoltura, come
definite dall’art. 2 della L.R. 64/95 e
s.m.i.
- strutture ricettive extra-alberghiere con le
caratteristiche della civile abitazione così
come definite ai sensi della L.R. 42/2000 (affittacamere,
case ed appartamenti per
vacanza, locazioni ad uso turistico, residenze d’epoca),
previo convenzionamento con
l’ente gestore e compatibilmente con le condizioni di
accessibilità previste dal presente
Piano per l’area interessata.
- attività connesse alla gestione ed alla fruizione del
Parco (punti informativi e di ristoro,
sedi di attività didattiche e ricreative, ecc.) previo
convenzionamento con l’ente gestore e
compatibilmente con le condizioni di accessibilità
previste dal presente Piano per l’area
interessata.
Le schede normative di cui al precedente comma 2 riportano
per ciascun edificio la
destinazione d’uso indicata dal Piano. Tale destinazione
non ha carattere prescrittivo; sono
ammesse eventuali modifiche o variazioni purché coerenti
con le disposizioni del presente
comma e nel rispetto dei requisiti di compatibilità
ambientale, urbanistica ed edilizia previsti
dalla legislazione vigente e dal Piano del Parco.
4. Ciascun edificio può essere oggetto unicamente delle
trasformazioni per esso individualmente ammesse, intendendo come tali tutte le
trasformazioni riconducibili alla categoria di intervento
indicata o a quelle rispetto ad essa più restrittive; in
difetto di indicazioni specifiche gli interventi ammessi sono limitati alla
categoria della ristrutturazione edilizia interna e nel rispetto dei caratteri
tipologici, architettonici e formali dell’edificio.
5. La classificazione degli interventi edilizi è definita
ai sensi dell’art. 31 della L. 457/78 come
specificato dall’art. 4 comma 2 della L.R. 52/99. Tali
definizioni sono ulteriormente specificate
e articolate dal Piano, in funzione degli obiettivi di
tutela e conservazione del patrimonio
edilizio esistente. In particolare, gli interventi di
ristrutturazione edilizia sono così definiti:
- D/a: Ristrutturazione edilizia limitata alla
riorganizzazione funzionale interna delle singole
unità immobiliari senza che ne vengano alterati volumi e
superfici, con modifiche agli
elementi verticali non strutturali e fermi restando i
caratteri tipologici, architettonici e
decorativi dell’edificio, nonché gli elementi
caratterizzanti storicamente l’organismo edilizio
ed il contesto ambientale.
- D/b: Ristrutturazione edilizia finalizzata alla
riorganizzazione funzionale e all’adeguamento
igienico-sanitario con modifiche incidenti anche sugli
elementi strutturali verticali ma nel
rispetto dei caratteri tipologici, architettonici e
decorativi dell’edificio, nonché degli elementi
caratterizzanti storicamente l’organismo edilizio ed il
contesto ambientale.
- D/c: Ristrutturazione edilizia finalizzata alla
riqualificazione complessiva dell’edificio
comportante anche la modifica degli elementi strutturali,
la diversa organizzazione
distributiva e la riqualificazione dei prospetti e delle
aperture, fino allo svuotamento
dell’involucro edilizio. Gli interventi dovranno essere
attuati nel rispetto degli eventuali
elementi tipologici, architettonici e formali significativi
o di pregio esistenti.
6. Tutti gli interventi edilizi sono subordinati al nulla
osta da parte dell’ente gestore. Qualora la
documentazione allegata ad una richiesta di concessione o
ad una attestazione di conformità
evidenzi la presenza di particolari elementi di pregio
architettonico, tipologico o ambientale non segnalati nella scheda relativa
all’edificio in oggetto è facoltà dell'ente gestore ricondurre la
trasformazione edilizia entro categorie più restrittive rispetto a quelle
previste dal Piano per
l’edificio stesso.
7. Per quanto non specificato dal presente articolo si fa
riferimento alle disposizioni della L.R.
52/99 e dei Regolamenti Edilizi vigenti nei Comuni
interessati. Il Regolamento del Parco, da
approvare ai sensi della L.R. 49/95 preciserà le procedure
e le modalità di attuazione degli
interventi nei diversi ambiti territoriali e definirà nel
dettaglio la disciplina per la realizzazione di recinzioni, strutture
temporanee, impianti ed altre opere suscettibili di produrre modificazioni del
contesto paesaggistico ed ambientale. Il Regolamento del Parco potrà inoltre
predisporre specifiche norme di carattere urbanistico edilizio finalizzate ad
incentivare l’adozione, nelle operazioni di restauro e recupero del patrimonio
edilizio, di tecniche di bioarchitettura o comunque di soluzioni progettuali che
prevedano l’uso di energie rinnovabili.
Capo IV – Gestione e fruizione del Sistema delle Aree
Protette dei Monti Livornesi
Art. 20 – Gestione e fruizione del Sistema delle Aree
Protette dei Monti Livornesi
1. Il Piano esprime indirizzi e proposte di valorizzazione
relativi all’intero Sistema delle Aree Protette
dei Monti Livornesi, in un quadro di integrazione
funzionale dei diversi ambiti territoriali nell’ottica di una gestione e
fruizione unitaria, aperta alla interazione con le aree esterne. In particolare,
il Piano del Parco individua il sistema degli accessi e dei percorsi interni del
Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi, e definisce la localizzazione e
le caratteristiche delle principali strutture per la gestione e la fruizione del
Parco stesso. Il Piano individua inoltre progetti specifici e di settore rivolti
alla valorizzazione ambientale e paesaggistica, nonché alla promozione della
fruizione scientifica, educativa, turistica e ricreativa dell’area. Le
strutture ed i servizi sopra indicati sono oggetto di descrizioni di dettaglio
ed indicazioni normative per la loro attuazione e gestione.
2. L’attuazione delle strutture e dei servizi di cui al
comma precedente è subordinata all’approvazione di specifici Piani di settore
o Piani Attuativi ai sensi della L.R. 5/95. Tali piani, qualora promossi da
soggetti pubblici o privati diversi dall’ente gestore, dovranno prevedere il
convenzionamento con lo stesso ente riguardo alle modalità di gestione e di
utilizzazione delle strutture ed ai rapporti con gli altri soggetti operanti nel
Parco.
Art. 21 – Accessi e percorsi
1. Il sistema degli accessi e dei percorsi individuato dal
Piano si articola in:
a) Porte del Parco
b) Accessi del Parco
c) Rete dei Percorsi
Ognuna di queste componenti fa parte di un sistema
complessivo finalizzato alla razionalizzazione ed alla valorizzazione delle
possibilità di fruizione dell’area protetta. Tale sistema è relazionato ed
ntegrato con i servizi e le strutture previste dal Piano.
2. Le Porte del Parco costituiscono ingressi privilegiati
al Sistema delle Aree Protette, adeguatamente segnalati ed attrezzati, in grado
di razionalizzare al massimo la fruibilità dei servizi previsti. Le Porte
rappresentano inoltre:
- un’occasione di "pubblicità" diretta, di
informazione della presenza del Parco;
- un luogo di orientamento ed informazione dei servizi
esistenti, delle possibilità di accesso, delle
caratteristiche dei sentieri, delle difficoltà di percorso
e altro;
I principali criteri adottati per un’adeguata
dislocazione e una razionale utilizzazione delle porte
sono stati la facile accessibilità, ovvero la possibilità
di essere facilmente raggiungibili dalle principali
direttrici stradali; la disponibilità in zona di
parcheggi, la presenza di strutture di accoglienza per i visitatori, la
possibilità di sistemi di orientamento per i portatori di handicap.
Sulla base di queste considerazioni sono state individuate
le seguenti Porte del Parco:
- Porta nord: IL CISTERNINO (porta principale del Parco):
Punto Accoglienza Visitatori presso strutture esistenti
- Porta est n.1: COLOGNOLE: Punto Accoglienza Visitatori ex
scuola elementare
- Porta est n.2 (integrata con la n. 1): PARRANA S.
MARTINO: Punto Accoglienza Visitatori
presso strutture esistenti
- Porta sud: NIBBIAIA: Punto Accoglienza Visitatori presso
strutture esistenti da concordare
con l’Amministrazione Comunale
- Porta ovest: CASTELLACCIO: Punto Accoglienza Visitatori
presso strutture esistenti
- Porta decentrata sud: I POGGETTI: Punto Accoglienza
Visitatori Villa Pertusati
In corrispondenza di ciascuna Porta dovrà essere previsto
un Punto Accoglienza Visitatori gestito direttamente dall’Ente gestore o da
soggetti convenzionati. La localizzazione delle Porte privilegia
l’utilizzazione di strutture esistenti e consente la possibilità di
collaborazione con attività private locali (circoli, attività di ristoro,
ecc,) per fornire servizi supplementari al visitatore.
3. Gli Accessi al Parco sono stati individuati tenendo in
considerazione lo sviluppo della rete dei sentieri, la facilità di
raggiungimento, la valenza delle località limitrofi, la possibilità di
valorizzare il più possibili i centri contigui all’area protetta. Gli accessi
sono i seguenti:
- Accessi Nord: Il Crocione, La Puzzolente-Bagnetti
- Accessi Ovest: Calignaia, Maroccone, Foce del Chioma
(Approdi del “Battello del Parco”)
- Altri accessi: Il Limoncino, Le Focerelle, Le Palazzine,
Villa del Molino Nuovo
In corrispondenza di ognuno di questi punti dovrà essere
predisposto un adeguato spazio di
parcheggio ed almeno uno o più pannelli informativi sul
Parco e sulla rete dei Percorsi, In
corrispondenza degli accessi più importanti potrà essere
previsto anche l’allestimento di un punto informazioni permanente o
temporaneo.
4. Il Piano individua inoltre la rete dei percorsi e la
sentieristica per la fruizione del Sistema delle Aree
Protette e delle Aree esterne al Parco. La rete dei
percorsi è individuata in specifiche schede
progettuali, facenti parte integrante degli elaborati del
Piano, che ne definiscono estensione,
caratteristiche, modalità di fruizione ed interventi
necessari per il ripristino o la riqualificazione. Si rimanda agli elaborati
sopra citati per l’approfondimento di dettaglio dei singoli percorsi. L’ente
gestore dovrà prevedere, anche attraverso un piano specifico, criteri ed
interventi per la soddisfacente riqualificazione, manutenzione e gestione della
rete di percorsi individuata, nonché per la realizzazione della segnaletica a
carattere informativo e scientifico didattico.
Art. 22 – Strutture e servizi
1. Il Piano individua le strutture e gli edifici di
servizio alla gestione ed alla fruizione del Parco,
all’interno dell’area del Parco stesso o nelle zone
contigue, definendo per ciascuno di essi le
funzioni e le modalità di gestione ipotizzate. Le
strutture individuate sono le seguenti:
- Centro Accoglienza Visitatori (ex scuola Valle Benedetta)
- Centro Visite e Foresteria (Villa Cristina)
- Centro Convegni e soggiorni studio (Eremo della Sambuca)
- Centro Studi Ambientali (Case Poggetti – Villa
Pertusati)
- Rifugi, Punti Ristoro e Punti tappa
- Punti informazioni
- Punti sorveglianza e primo soccorso
Tali servizi, oltre ad ospitare le funzioni principali del
Parco, devono risolvere i problemi di
attrazione, accoglienza, orientamento, ristoro, primo
soccorso per i visitatori. La loro localizzazione è stata effettuata seguendo
il criterio del riuso di strutture ed edifici esistenti nell’area, dando
priorità a quelli di proprietà pubblica.
2. Gli elaborati di Piano definiscono nel dettaglio le
caratteristiche e la localizzazione delle strutture
individuate, le funzioni previste e le possibili modalità
di gestione. L’attuazione e la gestione dei servizi previsti dovrà essere
definita, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 20 comma 2,
attraverso l’approvazione di Piani e progetti specifici e previo accordo fra
gli Enti ed i soggetti interessati.
Art. 23 – Piani Attuativi e di settore
1. Il Piano del Parco individua i Piani Attuativi e di
settore necessari per la realizzazione degli
interventi previsti, ed in particolare:
- Piani di settore o strumenti attuativi particolareggiati
predisposti dall’organismo di gestione in
attuazione delle previsioni del Piano
- Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata
convenzionata di cui all’art. 31 della L.R. 16.1.95 n. 5 (Piani
Particolareggiati, Piani di Recupero, ecc.) nei casi e secondo le modalità
specificatamente previste dalle presenti norme.
2. L’Ente gestore potrà predisporre la redazione di
ulteriori Piani Attuativi e di settore qualora ritenuti necessari per la
migliore attuazione del Piano del Parco. Tali Piani dovranno essere
predisposti in coerenza e nel rispetto delle previsioni di
intervento e degli indirizzi di gestione del Piano stesso.
3. L’Ente gestore dovrà verificare e garantire,
attraverso rilascio di nulla osta, la coerenza con le previsioni di intervento e
gli indirizzi di gestione del Piano del Parco anche per quanto
riguarda Piani di settore predisposti da soggetti pubblici
e privati in attuazione di specifiche
competente (Piano di gestione forestale del demanio
regionale, ecc.)
Art. 24 – Progetti specifici
1. Il Piano del Parco individua Progetti d’Area e
Progetti Tematici collegati alla promozione delle attività di didattica
ambientale, di educazione permanente, di turismo naturalistico e sportivo in
grado di consentire adeguati livelli di valorizzazione dell’area protetta.
Sono così individuati progetti di
area (progetto per il Parco ai Poggetti) ed una serie di progetti tematici, per
ognuno dei quali gli elaborati del Piano indicano le linee generali di
definizione progettuale, le funzioni e le modalità di gestione e fruizione
ipotizzate. Per i progetti localizzati in ambienti con elevate caratteristiche
di naturalità (boschi, aree in corso di rinaturalizzazione spontanea, ecc.) è
stata valutata la compatibilità ecosistemica.
2. La realizzazione dei singoli progetti è subordinata
all’approvazione di un Piano Attuativo
predisposto dall’ente gestore o da soggetti pubblici e
privati convenzionati. I progetti che
interessano l’utilizzo di edifici e complessi edilizi
prevedono prioritariamente interventi di restauro, recupero e riuso
dell’esistente. I progetti relativi a complessi edilizi in condizioni di
degrado per i quali il Piano preveda esplicitamente la possibilità di ricorrere
ad operazioni di riqualificazione urbanistica complessiva, anche con limitati
incrementi di volume rispetto all’esistente, dovranno essere corredati da
specifica valutazione degli effetti ambientali ai sensi dell’art. 32 della
L.R. 5/95 che contenga:
- l’individuazione delle aree e dei beni di rilevanza
ambientale
- l’analisi dello stato delle risorse soggetto a
modificazione
- l’indicazione delle finalità degli interventi previsti
e dei motivi delle scelte rispetto ad altre
alternative
- la descrizione delle azioni previste e dei loro
prevedibili impatti sull’ambiente
- l’individuazione dei livelli di criticità delle aree e
delle risorse interessate
- l’indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o
compensare gli effetti negativi
sull’ambiente, individuando la disponibilità delle
risorse economiche da impiegare
- l’accertamento del rispetto delle norme igienico
sanitarie
3. All’interno del Piano sono individuati i seguenti
progetti specifici:
- Progetto per il Parco ai Poggetti (Progetto d’area)
- Le Palazzine: Orto botanico delle rocce verdi
- Pian della Rena: Laboratorio di lavorazione artigianale
della steatite
- (Loc. Limone ): Fattoria sperimentale
- (Loc. da individuare): centro per la gestione forestale
del bosco
- Villa Cristina: arboreto
- Cave di Acquabona: Centro pratico di orientamento
- Eremo della Sambuca: Osservatorio astronomico
- Azienda Benedetti: Campo Base per l’osservazione della
fauna
- Case San Quirico: Laboratorio geo-minerario
- Laghetto di Casa de’Corsi: Oasi faunistica
Per ognuno dei progetti è predisposta una specifica scheda
tecnico-normativa facente parte
integrante delle presenti norme, alla quale si rimanda.
Art. 25 – Indirizzi per la predisposizione del
Regolamento del Parco
e del Piano Pluriennale Economico e Sociale
1. Il Piano del Parco esprime indirizzi per la futura
predisposizione del Regolamento del Parco e del Piano Pluriennale Economico e
Sociale, in attuazione di quanto disposto dalla L.R. 49/95, nonché
dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno.
2. Il Regolamento del Parco, nel disciplinare l’esercizio
delle attività consentite all’interno del Sistema delle Aree Protette dei
Monti Livornesi, dovrà conformarsi alla disposizioni ed alla direttive
contenute nel presente Piano, con particolare riferimento a:
- tutela delle componenti storiche, naturalistiche ed
ambientali
- disciplina del patrimonio edilizio esistente
- modalità di accesso e circolazione
- svolgimento delle attività di servizio ed
agro-silvo-pastorali
- svolgimento delle attività scientifiche, educative,
sportive, ricreative
- accessibilità nel territorio del Parco attraverso
percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap ed anziani
Il Regolamento del Parco dovrà predisporre, in conformità
a quanto disposto dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dal Piano
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno,
una specifica disciplina di dettaglio relativa alla:
- la tipologia e le modalità di costruzione di opere e
manufatti;
- lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali,
di servizio e agro-silvo-pastorali;
- il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi
mezzo di trasporto;
- lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed
educative;
- lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e
biosanitaria;
- i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro
genere, nell'ambito della legislazione in materia;
- lo svolgimento delle attività da affidare a interventi
di occupazione giovanile, di volontariato,
con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e
al servizio civile alternativo;
- l'accessibilità nel territorio del parco attraverso
percorsi e strutture idonee per disabili, portatori
di handicap e anziani.
Il Regolamento, salvo eventuali diritti esclusivi di caccia
o di prelievi faunistici previsti a favore delle
comunità locali, dovrà inoltre vietare:
- la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo
delle specie animali; la raccolta e il
danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori
in cui sono consentite le attività agrosilvo-
pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee,
vegetali o animali, che possano alterare
l'equilibrio naturale;
- l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di
discariche, nonché l'asportazione di minerali;
- la modificazione del regime delle acque;
- lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei
centri urbani, non autorizzate dall'Ente
parco;
- l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di
distruzione o di alterazione dei cicli
biogeochimici;
- l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e
qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
- l'uso di fuochi all'aperto;
- il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto
definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
Il Regolamento potrà stabilire altresì le eventuali
deroghe ai divieti di cui sopra, in coerenza e nel rispetto di quanto disposto
dal presente Piano.
3. Attraverso l’approvazione del Piano pluriennale
economico e sociale, la Provincia promuove iniziative coordinate con quelle
della Regione e degli enti locali interessati, atte a favorire lo sviluppo
economico, sociale e culturale della collettività residente all’interno del
parco e delle aree contigue.
Tale Piano dovrà essere predisposto nel rispetto delle
finalità istitutive del parco, delle previsioni del presente Piano e nei limiti
stabiliti dal Regolamento del parco.
Il Piano economico e sociale può prevedere:
- la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali;
- la predisposizione di attrezzature, impianti di
depurazione e per il risparmio energetico;
- servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico;
- l’agevolazione e la promozione, anche in forma
cooperativa, di attività tradizionali, artigianali, agro-silvo-pastorali,
servizi sociali e culturali, restauro anche di beni naturali
Una quota parte di tali attività è diretta a favorire
l’occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l’accessibilità e la
fruizione, in particolare per i portatori di handicap.
Nella predisposizione del Piano pluriennale economico e
sociale, la Provincia dovrà riferirsi
coerentemente agli indirizzi ed alla previsioni del
presente Piano del Parco, con particolare
riferimento alla individuazione ed alla localizzazione dei
servizi e delle strutture del Parco, alla
individuazione ed alla caratterizzazione dei progetti
finalizzati, agli indirizzi per la valorizzazione del patrimonio edilizio
esistente e per la promozione delle attività agricole e selvicolturali, e più
in generale, alle strategie di valorizzazione indicate dal Piano del Parco.
L’attuazione dei progetti e delle attività previste dal
Piano dovrà essere perseguita sia attraverso il sovvenzionamento di privati ed
enti locali per la realizzazione dei progetti stessi, sia attraverso la
promozione e l’incentivazione di associazioni e società, anche cooperative,
per la gestione e la fruizione dei servizi ad essi collegati.
Per un’ampia e coerente azione di valorizzazione del
territorio, particolare rilevanza assume il
coinvolgimento dei soggetti e delle attività presenti
nelle aree contigue al Parco Provinciale, da perseguire attraverso specifici
accordi con gli enti locali interessati.
Capo IV - Disposizioni finali
Art. 26 - Procedure autorizzative
1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativa ad
interventi, impianti ed opere nelle aree
ricomprese nel Parco e’ subordinato al preventivo nulla
osta della Provincia. Nel caso in cui la
gestione dell’area protetta sia affidata ad aziende
speciali od istituzioni ai sensi dell’art. 9, comma 1, il nulla osta e’
rilasciato dall’organismo di gestione. Al nulla osta si applicano le
disposizioni stabilite dalla legislazione vigente, con particolare riferimento
all’art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Art. 27 - Vigilanza
1. La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti
previsti dal presente Piano e’ affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti
poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle
leggi vigenti. Apposita convenzione ai sensi dell’art. 27, comma 2 della legge
6
dicembre 1991, n. 394, regola i rapporti con il personale
del Corpo Forestale dello Stato.
2. Lo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma
puo’ essere demandato dalla Provincia o, se istituito, dall’organismo di
gestione dei parchi, riserve naturali e aree naturali protette di
interesse locale, anche a personale di sorveglianza,
appositamente individuato dagli enti
stessi, cui attribuire funzioni di guardia giurata a norma
dell’art. 138 del TU delle leggi di
Pubblica Sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931, n.
773.
3. L’organismo di gestione organizza, ai sensi
dell’art. 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, d’intesa con la Regione e
con le Province, corsi speciali di formazione al termine dei quali rilascia il
titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco o della riserva naturale.
Art. 28 – Sanzioni
1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa
vigente, in caso di violazione delle norme del presente Piano si applicano le
sanzioni amministrative previste dalla L.R. 49/95, artt. 22 e seguenti.
ALLEGATO 1 : PROGETTI SPECIFICI
Progetto: Orto botanico delle Rocce verdi
della Valle del Chioma (Le Palazzine)
Ubicazione: in ambito ANPIL, in area sottostante
l’edificio denominato Le Palazzine, a
poche decine di metri dalla strada provinciale, ove esiste
una vecchia cava dismessa di
rocce verdi (ofioliti), che tra l’altro rappresenta
un’area di degradazione che necessita di
interventi di risistemazione.
Indicazioni progettuali: in questa area potrebbe
essere costruito un piccolo orto botanico
ove inserire le specie floristiche tipiche di questo tipo
di costituzione geologica
(serpentinofite). Potrebbero essere ricavati, nelle rocce
affioranti, aiuole ove inserire le
singole specie inquadrate sistematicamente ed
ecologicamente. Il percorso all’interno
dell’Orto botanico potrebbe avvenire tramite comodi
vialetti, opportunamente lastricati, in
modo da essere percorsi anche dai portatori di handicap.
L’allestimento dell’Orto botanico potrebbe essere
curato dagli operatori del Museo
Provinciale di Storia Naturale del Mediterraneo, del quale
questa struttura dovrebbe
divenire una dependance.
Gestione: da parte dell’Ente, in collaborazione
con il Museo Provinciale di Storia Naturale
del Mediterraneo e con la Sezione didattica dell’Acquario
Comunale “D.Cestoni”.
Prevedibili eventuali convenzioni con privati.
Progetto: Laboratorio artigianale per la
lavorazione della Steatite (Loc. Pian della Rena)
Ubicazione: In ambito ANPIL nelle vecchie cave di
steatite di Pian della Rena
Indicazioni progettuali: si potrebbe allestire un
laboratorio artigianale per la produzione di
manufatti, ripercorrendo le tecniche di lavorazione della
preistoria. I prodotti artigianali
potrebbero trovare collocazione nel mercato dei prodotti
tipici del parco, ma il laboratorio,
per le metodologie di lavoro impiegate, potrebbe divenire
un centro didattico.
Gestione: nell’iniziativa potrebbe essere
coinvolta la locale comunità di recupero ex
tossicodipendenti, per la quale potrebbe essere previsto un
corso formativo per
l’acquisizione delle tecniche di lavorazione.
Progetto: La Fattoria sperimentale (Località
Limone)
Ubicazione: in zona contigua, presso Loc. Limone.
Indicazioni progettuali: l’azienda, ubicata in
località Limone, conduce attività di
coltivazione ed allevamento.
In collaborazione con i proprietari dell’Azienda è
possibile organizzare un percorso
didattico relativo agli aspetti della vita rurale.
I bambini delle scuole materne, elementari e medie
avrebbero la possibilità di prendere
contatto con le coltivazioni agricole tradizionali, con
l’allevamento degli animali da cortile,
con le produzioni tipiche della zona. Il programma di
massima delle attività proposte dalla
proprietà riguardano: la coltivazione degli ortaggi, il
lavoro dei campi; la raccolta dei
prodotti della campagna; le produzioni tradizionali, oltre
che ad Attività didattiche
complementari.
Gestione: privata, da parte dei proprietari
dell’azienda, ma coinvolgendo associazioni e
società naturalistiche
Progetto: La gestione del bosco (località
da individuare)
Ubicazione: da localizzare.
Indicazioni progettuali: individuare un’area di
bosco ceduo sulla quale intraprendere una
turnazione ed operare il taglio ceduo, al fine di mostrare
(anche con supporti espositivi
fissi) le tecniche di taglio, di trasporto, di cura alle
matricine nella tradizione forestale
locale. Allestimento di una carbonaia. E’ possibile
l’allestimento di un piccolo Orto
botanico con la catalogazione delle principali specie
arboree ed arbustive presenti sul
territorio, con riferimenti alle caratteristiche botaniche,
produttive, ecosistemiche.
Gestione: da parte dell’Ente, o in convenzione con
privati
Progetto: Arboreto di Villa Cristina (Sequoie, alberi
del passato e Lecci, alberi del
presente)
Ubicazione: in zona Parco.
Indicazioni progettuali: i Monti Livornesi nel
passato, a partire da circa 6 milioni di anni
fa (Messiniano), avevano un manto vegetale con piante ad
affinità tropicale, quindi di
clima caldo come: Myricacee, Nyctaginacee, Hamamelidacee,
Anacardiacee, Sapindacee
e di tipo subtropicale come: Pinacee, Taxodiacee,
Cupressacee, Salicacee, Juglandacee,
ecc. Le piante ad affinità tropicale, con il
deterioramento del clima, avvenuto a causa della
chiusura dello stretto di Gibilterra, 5,5 milioni di anni
fa, scomparvero, mentre rimasero
quelle subtropicali e comparvero quelle di clima temperato,
come le querce caducifoglie e
le zelkova.
Con il ripristino dello stretto di Gibilterra e la
formazione del Mediterraneo, avvenuta 5,2
milioni di anni fa (Pliocene inferiore), i Monti Livornesi
divennero isole ed il clima
temperato- caldo favorì il permanere della componente
floristica subtropicale che, intorno
ai 2 milioni di anni fa (Pliocene sup.-Pleistocene
inferiore) si estinguerà a causa degli
eventi glaciali (Thuja, Glyptostrobus, Libocedrus,
Sequoia, Taxodium,
Cinnamomophyllum, ecc.). Barriere naturali:
montagne, mare, non hanno permesso a
queste piante di spostarsi o trovare stazioni di rifugio,
come invece è avvenuto in America
ed in Asia, dove ancora sono presenti. In seguito l’uomo
ha cominciato a diffonderle nei
luoghi dove sono scomparse, ed oggi Sequoia, Thuya,
Taxodium, ecc,, provenienti dai
succitati continenti, sono presenti in giardini e parchi di
varie località italiane.Dal
momento che le condizioni climatiche attuali dei Monti
Livornesi permettono
l’attecchimento e la sopravvivenza di queste piante del
passato, perché non costituire un
“arboreto” dove accanto agli alberi attuali vi siano
anche quelli che milioni di anni fa
erano presenti in queste contrade o meglio i loro
discendenti ?
L’indicazione di Villa Cristina (Molino), nell’alta
Valle del Torrente Ugione, è scaturita
perché qui vi possono essere le condizioni ideali per la
costituzione di questo arboreto, dal
momento che è possibile sfruttare esposizioni diverse, ed
è possibile realizzare una zona
umida in prossimità del torrente, per la messa a dimora di
piante come i Tassodi, Pioppi,
Salici, ecc.
Con la realizzazione dell’arboreto, quest’area
acquisirebbe una notevole valenza didattica
e turistica.
In uno specifico allegato si riportano le specie di piante
viventi in America settentrionale,
in Asia, in Europa e nel bacino Mediterraneo, affini a
quelle fossili, che potrebbero far
parte dell’arboreto.
Gestione: da parte dell’Ente gestore
Progetto: L’osservatorio astronomico (alla
Sambuca)
Ubicazione: in zona Parco
Indicazioni progettuali: in collaborazione col
Gruppo astronomico del Museo Provinciale
di Storia Naturale del Mediterraneo è possibile
predisporre, nella zona di Villa Cristina, un
piccolo centro per l’osservazione degli astri.
Gestione: da parte dell’Ente gestore, in
collaborazione con il Gruppo Astronomico del
Museo Provinciale di Storia Naturale del Mediterraneo.
Progetto: Centro pratico di orientamento e
tiro con l’arco (Cave di Acquabona. I
Poggetti)
Ubicazione: in zona Parco, ai Poggetti nell’area
della ex cava, nel settore nord orientale
del Parco dei Poggetti,
Indicazioni progettuali: si tratta, in linea
generale, di interventi di risistemazione e di
messa in sicurezza della ex cava, ove attualmente sono
dislocate le piazzole per il tiro con
l’arco di campagna. Gli stessi percorsi ora utilizzati
per il tiro con l’arco (attività da
mantenere e da valorizzare) possono essere utilizzati (con
opportuni turni) anche per
esperienze sul campo di orientamento ed uso delle carte. Le
piazzole di tiro e le sagome
degli animali possono essere usate come stazioni di
riferimento nella pratica di
orientamento, rivolta ai bambini delle scuole elementari e
medie. In virtù delle
caratteristiche geologiche del luogo possono essere trovati
ulteriori indirizzi per la
didattica dell’ambiente.
Gestione: da parte dell’Ente gestore, o in
convenzione con privati.
Progetto: Laboratorio geo–minerario di Case
San Quirico (Località case San Quirico.
Nibbiaia)
Ubicazione: in corrispondenza delle miniere di
magnesite abbandonate di Campolecciano.
Indicazioni progettuali: potrebbe essere allestita
una piccola mostra documentaria delle
antiche attività estrattive. Possibilità di allestimento
anche di un piccolo spazio espositivo
dei principali minerali dell’area del Parco (o della
Provincia di Livorno), con criteri
didattici.
Le gallerie che ancora si prestano, messe in condizioni di
assoluta sicurezza, potrebbero
essere agevolmente visitate.
Visitabile dai portatori di handicap.
Gestione: da parte dell’Ente gestore, o in
convenzione con privati.
Progetto: L’oasi del Laghetto di Casa de’
Corsi.
Ubicazione: in zona ANPIL, nella tenuta attorno a
Casa de’ Corsi, nei pressi del
Castellaccio
Indicazioni progettuali: grazie alla disponibilità
dei proprietari della piccola tenuta, che
racchiude circa 30 ettari, tra bosco ed incolto, sarebbe
possibile realizzare un’oasi
naturalistica presso la quale organizzare programmi di
educazione ambientale. La
presenza di un piccolo invaso artificiale ormai
naturalizzato nel perimetro della proprietà,
può consentire la fruizione di un ecosistema legato agli
ambienti acquatici che ben si
integra con l’area circostante, di alta valenza
naturalistica.
Nelle indicazioni progettuali di massima della proprietà,
viene indicata la ristrutturazione
del rudere denominato Casa de’ Corsi (per la quale sono
già state concesse le
autorizzazioni per il recupero). Queste volumetrie, oltre
ad essere destinate a civile
abitazione per la proprietà, potrebbero divenire un Centro
culturale per lo studio
dell’alimentazione naturale ed alternativa, in
collegamento con con il centro “Cibo per la
Pace”, di Livorno, degli stessi proprietari.
Per la valenza naturalistica dell’area e per l natura
delle attività previste, potrebbe essere
prevista un’inclusione dell’area all’interno del
Parco provinciale, o comunque rivista la
regolamentazione venatoria ora vigente.
Gestione: diretta, da parte dei proprietari della
tenuta, in convenzione con l’ente gestore
Progetto: Campo base per l’osservazione
della fauna dell’Azienda faunistica Benedetti
(Parrane, Collesalvetti)
Ubicazione: in zona Parco; il progetto è da
realizzare sul territorio dell’Azienda faunistica
(circa 180 ha) compreso nel Parco provinciale.
Indicazioni progettuali: L’Azienda dispone sul
proprio territorio, in stato di libertà entro il
perimetro recintato della proprietà, di numerosi capi di
Artiodattili, quali il Daino (Cervus
dama), il Cervo (Cervus elaphus), il Muflone
(Ovis orientalis musimon), il Cinghiale (Sus
scrofa). Il progetto del Campo base dovrebbe
prevedere il recupero e la riqualificazione
dei fabbricati esistenti presso il centro aziendale, per la
predisposizione di strutture per la
ricettività (ostello, refettorio con punto ristoro, aula
didattica) nonché la risistemazione
della rete dei sentieri, comunque già ben sviluppata. Il
progetto potrà prevedere la
formazione di alcuni punti di osservazione, a pulpito o a
capanno, da far fruire ai
visitatori, in particolar modo per la realizzazione di
programmi di didattica ambientale.
Le attività possibili all’interno dell’area, che
ricade totalmente nel Parco provinciale,
saranno regolamentate dagli strumenti di gestione del Parco
stesso che dovranno altresì
prevedere piani di riconversione faunistica e i criteri di
recupero delle strutture esistenti..
Data la particolare ricchezza faunistica, la zonazione
prevista può far considerare l’intera
zona come Riserva faunistica, previa una revisione dei
carichi animali presenti, da
effettuarsi, con criteri rigorosamente scientifici, a cura
dell’ente gestore.
Prescrizioni: E’ ammessa la ristrutturazione urbanistica
dei corpi edilizi esistenti, con
eventuale incremento del volume esistente, fino a ricavare
spazi per la ricettività
potenziale di gruppi scolastici e/o turistici per la
didattica ambientale (max 50 persone). Il
progetto dovrà adottare soluzioni tali da garantire un
corretto inserimento nel contesto,
attraverso il ricorso a tipologie e materiali appropriati
nonché a sistemazioni
paesaggistiche ed ambientali. L’Autorità del Parco
valuterà la compatibilità ambientale
della proposta progettuale anche attraverso specificia
Valutazione degli Effetti Ambientali
ai sensi dell’art. 32 L.R. 5/95.
Gestione: diretta, da parte della proprietà
dell’azienda attraverso convenzionamento con
Sul web non si trovano attualmente molte informazioni sul Parco, sulla sentieristica e sui punti di interesse particolari, nulla almeno che comprenda in toto l'area naturale e che ne permetta una adeguata e facile esplorazione: non esiste una cartografia recente e dettagliata, non sono evidenziati i percorsi e neppure esiste una cartellonistica, anche minima, su emergenze antropiche o floreali etc.etc.etc.
Questo il motivo per cui, unitamente alle informazioni esposte in questa pagina, vi rimandiamo anche ad alcuni siti in cui si possono trovare riferimenti ed approfondimenti sul Parco dei monti livornesi, naturale o no..........ma sono veramente pochi:
Wikipedia Colline livornesi - http://it.wikipedia.org/wiki/Colline_Livornesi
APT Costa degli Etruschi - http://www.costadeglietruschi.it (cliccare su: natura e parchi e quindi itinerari)
Associazione Gaia- http://www.associazionegaia.net (vedere link sul territorio di Collesalvetti)
varie su particolari:
mulini del territorio livornese:
http://www.quercianellasonnino.it/biblio/mulini.pdf
mulini territorio livornese (rio Sanguigna)
http://www.lungomarecastiglioncello.it/ (andare a itinerari extraurbani e
selezionare mulini rio Sanguigna)
http://xoomer.virgilio.it/whpar//livorno/incontro10[vbenedetta].html
(mulini valle Benedetta)
http://www.viadalvento.org/wp-content/uploads/2011/06/OsservItaliaNostraEoli
coCannetoMonteverdiMarittimoPi.pdf (mulini valle Benedetta)
Piano del Parco, Regolamento di gestione, Norme, Schede di disciplina del patrimonio edilizio, Scheda sentieristica:
http://www.associazionegaia.net/occhi/documenti/norme.html
 elaborato
dei percorsi effettuati
elaborato
dei percorsi effettuati
1) I mulini della Sanguigna (Gabbro)
2) anello della Valle Benedetta
3) Cascatelle dell’Infernaccio, Ghiacciaie, eremo della Sambuca e cave di talco (anello)
4) uno sbocco al mare: Marroccone, riserva di Calafuria, Calignaia
6) variante della Valle Benedetta 1, per la cava della Focerella ed i tempietti del Poccianti
7) Variante della Valle Benedetta 2- per il Calvario, Pandoiano e l’Acquedotto (parzialmente riprende il ritorno della variante 1
8) valle Benedetta, Sambuca, villa Cristina e ritorno
9) Il Parco e lo sbocco al mare: Nibbiaia, Podere del Gorgo, Chioma
11) La valle del Fosso del Molino nuovo
12) Verso il monte La Poggia (colline livornesi)
13) itinerari brevi (zona Montenero e Castellaccio)
14) dalla valle del rio Savalano a quella del rio Sanguigna
15) Itinerari inediti nel Parco: da Nibbiaia alle grotte dei banditi
17) L’anello del “ponte romano”, dai lavatoi del Gabbro ai mulini della Sanguigna
18) il percorso del Pellegrino
I MULINI DELLA SANGUIGNA:
Vie di acqua tra memoria e progetto:
un
itinerario sul territorio di Rosignano Marittimo e nel Parco delle Colline
livornesi.
L’ associazione Ambientalista
Agire Verde si occupa di tempo
libero, organizzando escursioni atte a conoscere il nostro territorio e di
pratiche di consumo critico, turismo responsabile e progetti ecologici, sia in
ambito urbano che naturale.
La gita da noi proposta, per
domenica 4 Dicembre, sarà strutturata in questo modo: in mattinata esploreremo
il complesso molitorio dell’alta valle del Botro Sanguigna al Gabbro e
l’ecosistema della zona, che propone notevoli specificità naturalistiche,
geologiche e biologiche. Nel
pomeriggio invece, andremo sul monte Carvoli, nel cuore del parco delle Colline
Livornesi, per esplorare la necropoli etrusca del II-III sec.
I
mulini del Gabbro rappresentano una testimonianza fisica, in apprezzabile stato
di conservazione, nell’area dei Monti Livornesi di edifici destinati a tale
scopo. In altre zone gli stessi manufatti si presentano in uno stato di
conservazione molto
più fatiscente. Nell’ambito dell’escursione sarà presentato anche il
sistema idraulico con derivazione delle acque dal Torrente, collegato ai Mulini,
che forniva l’energia idraulica necessaria
al funzionamento
delle macine e le notevoli opere territoriali, presenti e funzionali
all’accumulo delle acque e alla sua canalizzazione.
Il
dott. Roberto Branchetti, del gruppo archeologico del museo di Storia Naturale,
illustrerà la storia di tali opifici, il loro sistema di funzionamento,
descrivendo il contesto storico ed ambientale nel quale erano insediati in modo
operativo .
Ci domanderemo se è possibile e
come, trasformare
tali resti edilizi di valore storico-documentale e di immagine,
da pura preesistenza,
destinata alla rovina per esposizione alle intemperie, senza protezione,
in una possibile risorsa, anche di sviluppo del territorio, tramite il
loro recupero funzionale.
In altri contesti territoriali sono stati realizzati Parchi a
tema, in cui tale tipo di archeologia è uno degli elementi di attrazione, perché
non pensare ad un simile impiego del nostro territorio?
Nel
pomeriggio ci sposteremo poi sul monte Carvoli, nel cuore del parco delle
Colline Livornesi, per esplorare la necropoli etrusca del II-III sec. A.C.
assistiti sempre dal dott. R. Branchetti che ci illustrerà le caratteristiche
tipiche di un insediamento archeologico, sconosciuto ai più.
Il pranzo è previsto al sacco, a
pian dei Lupi. C’è tuttavia la possibilità, per chi lo desidera, di
prenotare un pranzo rustico, presso il pastore insediato a Pian dei Lupi,
richiedendolo nell’ambito della prenotazione da effettuare presso Picardi
Salvatore al n. 0586/867563 durante il giorno oppure al n.° 0586/861138 dalle
21.15 in poi (possibilmente entro venerdi sera, per motivi organizzativi.
Nota a margine:
E’ da qualche tempo che, come
associazione Agire Verde, stiamo maturando l’intenzione di
adottare un progetto o con
valenze naturalistiche e storiche in un sistema ambientale naturale o con
valenze urbanistiche nel sistema
urbano, diretto a promuoverne poi la realizzazione.
L’iniziativa odierna vale come iniziale ricognizione, volta allo scopo.
Ne seguiranno altre, con il medesimo intento, in altre zone: a villa Mauro
Gordato ad esempio, porteremo avanti questo discorso, nel mese di gennaio.
Abbiamo chiamato questi itinerari di conoscenza del
territorio che ci circonda “Conoscere per Adottare
un Progetto “.
In altre realtà esistono scuole che adottano monumenti e ne
promuovono il restauro, facendoli uscire dal silenzio che li circonda, noi, come
Associazione in primo luogo, ci proponiamo di ampliare il più possibile la
conoscenza dei cittadini sulle emergenze territoriali, tentando contemporaneamente
di far pressione affinchè un
qualche progetto di restauro e sviluppo venga infine avviato, attivando
investitimenti, sia pubblici che privati.
Ps: alla nostra iniziativa sono ovviamente invitate le
associazioni aderenti ai forum ambientali e pacifisti, ritenendo che un
confronto leale ed aperto sulle tematiche da noi proposte, non possa che essere
produttivo per un territorio
livornese duramente toccato da una crisi economica senza
precedenti………….“Conoscere per Adottare
un Progetto “, non risolverà la crisi ma……..è pur sempre
un’idea per uno sviluppo a venire, in mezzo a tante chiacchiere.
sez.ambiente e territorio
il percorso dettagliato dell'anello:
Dalla piazzetta della Valle Benedetta, dove si legge via del radar, si lascia alla nostra sinistra la discesa che porterebbe alla Sambuca e ci si dirige invece verso lo sterrato proprio di fronte a noi, c’è solo quello e non ci si può sbagliare.
Lo sterrato, dopo un primo tratto in salita, trovando alla nostra sinistra ed in alto e recintati i ruderi di un antico mulino a vento, arriva, dopo 10/15 minuti, nei pressi di un evidente incrocio di sentieri.
Andiamo a sinistra ed iniziamo a percorrere il bosco, in leggera discesa, e dopo circa 20 minuti troviamo una sbarra alla nostra sinistra, proprio accanto al segnale della regione. Andiamo oltre, ancora a diritto, e dopo poco si esce dal bosco per trovare ruderi di un vecchio podere, oramai soltanto un cumulo di pietre sormontate da alberi secchi ( guardare in alto e a destra per vederlo, sopra la collina). Un pino solitario si trova più in basso e sulla nostra destra, mentre in alto, sulla collina di fronte ed a destra, vediamo “la palla” della Valle Benedetta con di fronte a noi l’ampio e splendido panorama della piana che da Colognole va a Parrana S.Giusto, al lago di Santa Luce ed alle colline pisane, a sinistra, con in fondo il promontorio di Piombino ed il mare che nelle giornate terse è veramente uno spettacolo da godere.
Siamo adesso al Calvario, detto così perchè l’abate Colombino Bassi, monaco vallombrosano, verso la fine del ‘600, vi issò tre croci per ricordare il Golgotha. A quel tempo l’eremo della Sambuca era passato dall’utilizzo dei Gesuiti a quello dei Benedettini.
Rientriamo adesso nel bosco, restando sempre sulla sinistra del crinale e, seguendo un largo sentiero principale, ben evidente, troviamo uno slargo, una radura ed un bivio di sentieri dove prendiamo quello davanti a noi e non quello alla nostra sinistra. Usciamo dal bosco e cominciamo a scendere: “La palla” è sempre in alto alla nostra destra ed oramai sarà lontana dietro di noi. Continuiamo a scendere per altri 20/30 minuti e troviamo prima i resti di un casale abbandonato e recintato e quindi le prime case della frazione di Pandoiano. Alla fine della discesa, entrando nell’abitato, vedremo un lampione e l’asfalto (Dalla nostra partenza, per arrivare qui, saranno passate circa due ore), giriamo adesso a destra, fino ad arrivare ad un circolo a.r.c.i. Opzione 1) davanti a noi vediamo un cartello di divieto di transito ed uno sterratelo con l’indicazione strada privata, lo imbocchiamo ed arriviamo al guado del torrente Morra dopo altri 10/15 minuti. Qui potremo sostare per il pranzo, come anche nei prati del circolino arci. Guadare adesso il torrente, all’altezza di un ponticello in ferro, che adesso è sfondato e quindi pericoloso e conseguentemente non utilizzabile, bagnarsi un po’ i piedi e passare oltre. Proprio di fronte troveremo una salita, larga e abbastanza ripida, tra la macchia, e, risalendola per circa 30/40 minuti (dislivello mt.150), aiutandoci un po’ con dei bastoncini da montagna, almeno finchè non verrà attrezzato opportunamente per una sua comoda fruibilità, alla fine saremo sulla strada asfaltata proprio all’inizio dell’abitato di Colognole, all’altezza del cimitero. Prenderemo adesso a destra, per circa un chilometro, arrivando ad una trentina di metri prima del bivio per il Gabbro ( alla nostra sinistra sull’asfaltata), e, sulla destra, prenderemo il sentiero che scendendo arriverà ad una spianata sull’acquedotto (si riconosce perché c’è una sbarra proprio all’inizio, ad impedire il transito alle auto), l’inizio della camminata lungo la struttura. Dall’inizio dell’escursione saranno trascorse circa tre ore, soste escluse.
Il sentiero, Immerso nella macchia mediterranea. Arriva subito ad una curva a gomito (praticamente la prima) ed entra nella lecceta, aprendosi in una radura, la spianata di cui si diceva e che porta ai "tempietti” del Poccianti, custodi delle sorgenti principali dell'acquedotto.
Scendiamo ora verso il Morra, utilizzando la scalinata realizzata al di sopra del condotto che porta le acque al Bottin Tondo, raggiungendo e una sorta di “terrazza” che ci offrirà una splendida vista panoramica sull’intero ambiente.
Le possibilità adesso sono due: risalite le arcate dell’acquedotto o scendere verso valle per risalire nuovamente alla Valle Benedetta.
Variante 1: alla nostra sinistra ed in alto, una volta arrivati alla terrazza panoramica con vista sui tempietti, si può risalire per un lungo ed incantevole percorso sulle arcate in muratura dell’acquedotto, alla scoperta dell’ultima sorgente, quella della Terrazza (nota: per chi soffre di vertigini è possibile, in alcuni passaggi ed in tarda primavera/estate, transitare da sotto le arcate invece che sopra, stando sulla destra) .Passeranno altri 30/40 minuti quando infine troveremo una ripida salita alla nostra destra ( per un 3 o 4 metri), a questo punto, per un sentiero che sale proprio davanti a noi, usciremo dal bosco, vedendo gli affioramenti delle verdi rocce ofilitiche della cava della Focerella. Ci troveremo adesso su una carrareccia che prenderemo a destra ( a sinistra, andando un po’ avanti, arriveremmo nuovamente all’asfaltata e percorrendola saremmo ancora a Colognole –- oppure, prendendo il sentiero in salita, subito a destra dell’ippovia su cui adesso siamo- prima dell'asfaltata - si ritorna in via del radar alla valle Benedetta, in 30 minuti-.Nota: uscendo dal bosco e trovandoci sulla carrareccia, se invece che a sinistra si va a destra e la si segue, si arriva lo stesso alla Valle Benedetta in 45/60 minuti, è una variante più lunga ma meno faticosa.
Variante 2)
Un’alternativa più corta che seguire le arcate dell’acquedotto, sarebbe, sempre al terrazzamento iniziale da cui si partiva per percorrere le arcate, di seguire l’acquedotto in discesa, proprio davanti a noi e non salendo a sinistra, ma scendendo fino ai ruderi di un edificio – ci sono recintati in plastica arancione – dove si guaderà un torrentello alla nostra sinistra, arrivando sempre alla ippovia, sentiero 00, di cui si diceva prima, risalendola sulla destra per 45 minuti……………perdendo però la passeggiata sulle arcate, anche se più breve.
Opzione 2) invece che a Pandoiano, proseguire per Loti e scendere tra le case, proprio di fronte a noi, per girare a destra ed arrivare subito nei campi (seguire dei segni bianco/rossi sfumati e mirare un traliccio dell’enel, davanti a noi (10 minuti). Prendere uno sterrato a destra e trovare una salita alla nostra sinistra, sempre individuando con attenzione i segni sfumati: si arriverà al Morra, trovando un ponte in pietra, molto suggestivo. Salendo ancora ci si ritroverà proprio dove abbiamo detto che avremmo trovato il rudere di edificio, sul torrente. Per arrivare ai tempietti del Poccianti adesso, si può o prendere lo sterrato a sinistra ed in salita, rientrando nel bosco alla prima deviazione a destra o risalire il torrente dal basso (nota: prima del rudere c’è un mulino ad acqua restaurato ed abitato.
attenzione a non fare questa escursione durante la stagione delle piogge perchè il terreno sarebbe molto fangoso ed anche non da fine novembre a fine gennaio perchè all'acquedotto c'è la caccia al cinghiale ............rischiate di venire impallinati! L'ideale è maggio, bello anche per le fioriture.
note storiche e brevi cenni sull'acquedotto di Colognole ( nella foto: i "tempietti" del Poccianti).
brevi cenni sui Mulini della Valle Benedetta
Molta della documentazione relativa alla costruzione dell’Acquedotto di Colognole, durante la direzione dei lavori dell’ingegnere Giuseppe Salvetti (1793-1801), relativa alla fornitura dei materiali e le prestazioni di lavoro, è a tutt’oggi conservata negli archivi e ne permette così una interessante ricostruzione storica.
Alla fine del 1700 la situazione idrica della città di Livorno era molto preoccupante in quanto l’approvvigionamento idrico era del tutto insufficiente.
Sul finire del governo di Pietro Leopoldo in Toscana, il 13 aprile 1790 veniva incaricato l’ingegnere Giuseppe Salvetti di esprimersi su un progetto, effettuato precedentemente dell’ingegnere Francesco Bombici, per il tracciato dei nuovi acquedotti livornesi.
Si intendeva allacciare le sorgenti di acqua rinvenute nelle valle di Popogna alle sorgenti iniziali del rio Ardenza e dei suoi affluenti, per incanalarle lungo la vallata, con un condotto che sarebbe penetrato in città in direzione della via di Salviano. Si prevedeva anche di unire le acque delle sorgenti di Colognole, immettendole nel condotto, con un traforo attraverso il monte Maggiore, proprio in prossimità delle sorgenti stesse.
Questo traforo, lungo più di un chilometro e mezzo, fu valutato imprudente dal Salvetti, sia per il rischio di deviazione delle sorgenti, sia per la pericolosità ed il disagio dei lavori.
Egli propose di fare affidamento solo alle sorgenti di Colognole, più abbondanti, e di seguire un tracciato alle spalle della città, dopo un accurato studio di livellazione.
L’approvazione del progetto del Salvetti e l’incarico della direzione dei lavori, si ebbero sotto FerdinandoIII l’11 novembre 1792.
Con Notificazione Governativa del 23 gennaio 1793 si dava inizio ufficiale ai lavori.
Il tracciato dell’acquedotto, lungo circa diciotto chilometri, fu diviso in undici tronchi.
Punti chiave per lo svolgersi del condotto, oltre che per l’impegno costruttivo, erano gli attraversamenti su archi della valle del Rio dell’Acqua Puzzolente e della fornace vicino a Livorno, della Valle della Tanna prima di Cordecimo, della valle del Rio Corsara o Mulinaccio nelle Parrane. I lavori comincia appunto in queste località.
I lavori procedettero con alacrità e notevoli spese fino al 27 marzo 1799, quando il Granduca Ferdinando III, a causa della complicata situazione politica internazionale, fu costretto ad abbandonare la Toscana.
A quel momento erano state eseguite: le arcate dell’acqua Puzzolente e della valle della Fornace, nei pressi della città; le arcate sul Rio Tanna, quelle sul Botro della Casa, la doppia arcata sul Rio Mulinaccio ed altre due più piccole, queste ultime tutte nelle Parrane.
Restava comunque da costruire una parte notevole del condotto, compreso l’allacciamento alle sorgenti.
I tempi previsti per la costruzione dell’acquedotto erano stati stabiliti in 4 anni e la spesa preventivata in scudi 193.000.
Negli oltre sette anni trascorsi dall’inizio dei lavori, la spesa raggiunta ammontava a 261.575 scudi, molto di più di quanto era stato preventivato.
A causa della scarsità dei finanziamenti, la costruzione dell’acquedotto venne sospesa ed i lavori rimasero sostanzialmente fermi, tranne alcune opere di mantenimento e consolidamento.
Con la sospensione dei lavori e la relativa assenza di personale, iniziarono i furti ed i danneggiamenti. I furti continuarono anche dopo la ripresa dei lavori.
Si deve arrivare al 1806 perche Maria Luisa, reggente di Carlo Ludovica, disponga della ripresa dei lavori ed incarichi l’ingegnere Neri Zocchi ed il matematico Pietro Paoli, per la parte idraulica.
Questi rimasero alla direzione dell’opera sino al 1809.
Nel 1808 la direzione dei lavori venne affidata all’architetto Pasquale Poccianti, che nel ruolo di ingegnere del Comune di Livorno, ebbe l’incarico di occuparsi anche dell’acquedotto portando a termine i lavori dall’allacciamento delle acque.
Nel 1814, dopo la” restaurazione” ed il ritorno di Ferdinando III sul trono granducale, la costruzione dell’acquedotto riprese a pieno ritmo ed il 30 maggio 1816, da una fonte a quattro zampilli, alla cosiddetta Pina d’Oro, sgorga per la prima volta l’acqua dell’imponente acquedotto di Colognole.
La costruzione continuò ancora per molti anni; infatti il Poccianti aveva apportato importanti modifiche al progetto del Salvetti.
Le opere eseguite dal Poccianti, nei primi anni della sua direzione, furono di fatto interamente rivolte al miglioramento della tenuta del sistema idraulico alle sorgenti e lungo il condotto.
Tra le opere ideate in questi anni vi sono anche alcuni “casotti” la cui funzione era quella di ridurre la velocità delle acque e di consentire l’ispezione dei condotti. A lui si devono il Purgatoio o Costernino di Pian di Rota, Il Cisternone ed il Costernino, Oggi in fase di restauro e nuova destinazione d’uso.
L’acquedotto fu terminato dopo circa 590 anni.
Il Poccianti mantenne la direzione dei lavori fino al 1858, quando gli subentrò l’architetto Angiolo Della Valle.
L’ingegnere Pasquale Poccianti, sul percorso dell’acquedotto di Colognole, aveva progettato di costruire una passeggiata, al fine di indurre gli abitanti di Livorno “alla scoperta” della sua opera e, per questo motivo, aveva ampliato la larghezza della fascia di terreno di pertinenza dell’acquedotto, portandola a 24 braccia, con spazi più ampi in prossimità dei pozzetti di areazione e di ispezione.
Il tracciato della nuova via delle Sorgenti venne costruito lungo il percorso dell’acquedotto, come il Poccianti aveva più volte caldeggiato e, ancora oggi, percorrendo questa strada, potremmo ammirare questa splendida opera, se non fosse completamente ricoperta dai rovi.
Nel 1854 il nuovo percorso, in molti punti aderente a quello della vecchia via livornese, venne ultimato dal fiume Tanna fino in località Torciano.
Qui i lavori si fermarono.
Tratto da "Vita civile e religiosa nel territorio di Collesalvetti La Sambuca, le Parrane
ed altri luoghi collinari fra il XVI e il XX secolo" Clara Errico e Michele Montanelli- Felici Editori .
per ulteriori approfondimenti e maggiori, vi rimandiamo a http://it.wikipedia.org/wiki/Acquedotto_Leopoldino
I mulini della della Valle Benedetta
da un lavoro sviluppato dal liceo F.Enriques di Livorno – vedi in particolare gli autori– e dal gruppo archeologico di Pisa – a cui vi rimandiamo, visionando questo sito web: http://www.comune.pisa.it/gr-archeologico/musvir/mulini/home.htm
Nel 1740 alcuni imprenditori livornesi, credendo in questa
tecnologia, danno un nuovo impulso all'utilizzo di mulini a vento, forti anche
dell' apporto di personaggi del calibro di M. Vayringe, professore di meccanica
e filosofia sperimentale presso l'accademia di Nancy e poi di Firenze. Il suo
progetto definito "grandioso, comodo e sicuro" viene applicato alla costruzione
di alcuni mulini sul poggio di Valle Bendetta.
Nel 1742 il signor Filippo Tidi (famiglia che possedeva i mulini ad acqua sul
Rio Ardenza) inizia a costruire sei mulini. In realtà, alla fine solo quattro
strutture verranno effettivamente costruite, come si individuano in alcune carte
della costa livornese ad uso dei naviganti, nelle quali i mulini della Valle
Benedetta, per la loro posizione eminente sono presi a referimento e mira per l'
attraversamento delle secche della Meloria e l' ingresso in porto. Le carte sono
datate 1769-1795. Attualmente i mulini sono da tempo in via di degrado e posti
su terreni privati, un vero peccato che questo, che dovrebbe essere patrimonio
pubblico, sia di fatto non accessibile per una adeguata fruibilità sia culturale
che turistica …………..ma tant’è!
DETTAGLIO: Cascatelle dell’Infernaccio, Ghiacciaie, eremo della Sambuca e cave di talco
Il percorso si snoda attraverso l’alta valle del torrente Ugione e ci conduce dal poggio Corbolone all’eremo della Sambuca. in questa zona sono presenti molte cave di talco, talco che poi era macinato nei molini intorno e, proprio sopra uno di questi molini, troveremo “le ghiacciaie”, strutture fabbricate in pietra ed intonacate, che sprofondano nel terreno per circa 7-8 metri, leggermente coniche, con un diametro di circa 6 metri ed uno scarico sul fondo, per drenare l’acqua.
Riempite con ghiaccio e neve e strati di paglia come coibente, erano coperte con intavolati e rifornivano Livorno di ghiaccio nel periodo estivo, nel 1800 e fino agli inizi del 1900. Ecco dunque, oltre alle cave, un altro punto caratteristico del Parco, da valorizzare (ad informarci in modo approfondito, abbiamo invitato il prof.Branchetti, del gruppo archeologico del museo di storia naturale) .
Il bello della passeggiata però, non sono tanto rappresentate dalle emergenze storiche/culturali (i mulini, le ghiacciaie o lo stesso eremo) oppure geologiche (le cave) quanto l’ambiente naturale: pini mediterranei messi a dimora nel dopoguerra, la macchia originaria che sempre rispunta dopo gli incendi a ricostruire il bosco, il pino marittimo che colonizza facilmente scarpate ed aree di cava e poi il ginepro, il cerro, il cisto, il corbezzolo, il mirto, l’alloro, l’agrifoglio etc.etc.etc. e tutto un moltiplicarsi di emergenze floreali che meriterebbero sicuramente percorsi didattici ad hoc, che purtroppo mancano, come anche manca la segnaletica sui sentieri e la cartellonistica nei punti di interesse.
Dettaglio del percorso:
attraverso la media ed alta valle del Torrente Ugione, verso la vecchia ed
abbandonata Abbazia della Sambuca.
Dalla Strada provinciale delle Sorgenti, in auto e dopo circa un chilometro, si
raggiunge il Tiro a Segno di Poggio Corbolone (m. 110) dove, lasciate le auto ed
incamminandoci oltre la sbarra, iniziamo a percorrere una carrareccia sterrata
grigia che solca il versante ovest del Poggio Corbolone. Fatti poche centinaia
di metri lo sguardo potrà spaziare sulla città di Livorno, il porto ed il mare,
con la Gorgona in lontananza ed un’ampia e bella panoramica che vale la pena di
ammirare.
Percorsi circa 1,5 km incontriamo quindi un
quadrivio: ad ovest (a sinistra) si va verso La Puzzolente, ad est ad una
vecchia Cava di talco steatite, noi veniamo da nord ed a sud si andrà verso la
Sambuca. Le Colline Livornesi in questa zona presentano molte cave di talco e
magnesite che veniva macinato nei molini attivi in zona e lavorato infine in
città.
A questo punto saranno trascorsi circa 20/30 minuti e possiamo quindi
permetterci una breve visita alla Cava di talco steatite, che non ci prenderà
troppo tempo (15 minuti). L’attività mineraria si concluse qui negli anni
‘50 ed adesso la miniera è chiusa, restando solo alcuni vecchi macchinari
arrugginiti, a testimoniare le andate attività. Torniamo sul sentiero principale
e lo seguiamo fino ad una casa disabitata, dove, lasciando il segnavia 00 che ci
porterebbe direttamente a Villa Cristina, prendiamo il sentiero in discesa, per
arrivare al Molino di Sotto del Torrente Ugione.
Ancora ben identificabile il bottaccio lungo 75 metri con la sua gora
d’alimentazione dal torrente ed ancora visibili una parte delle serrande
d’alimentazione e di scarico con la cascatella, dove una steccaia sbarrava il
torrente (fare attenzione perché la zona non è in sicurezza).
Poco sopra il Molino e un po’ più avanti,
alla nostra destra, c’erano le 3 Ghiacciaie che sono ancora visibili e recintate
per ragioni di sicurezza.
Fabbricate in pietra ed intonacate, sprofondano nel terreno per circa 7-8 metri
e sono leggermente coniche con un diametro di circa 6 metri. Nota: erano
riempite con ghiaccio e neve e strati di paglia come coibente ed erano coperte
con intavolato, rifornivano Livorno con ghiaccio nel periodo estivo, nel 1800 ed
fino ad inizio 1900 ed avevano uno scarico sul fondo, per drenare il ghiaccio,
convogliando l’acqua di scarico nel bottaccio, nei pressi del quale, sull’argine
a monte della strada, è ancora visibile una buca nel terreno con l’interno in
pietra e mattoni.
Si guada adesso il torrente Ugione e si sale verso l’Eremo della Sambuca,
costeggiando l’Ugione, e ci arriviamo dopo aver valicato un piccolo ponte (dal
quadrivio a qui sono passati circa 40 minuti). La struttura è stata
completamente risanata, anche se l’intonaco esterno ne ha rovinato l’aspetto, ed
è chiusa con lamiere di ferro alle finestre ed alle porte per evitare scassi e
deturpazioni. Lasciamo l’Eremo, oltrepassando un secondo ponte, e saliamo
dolcemente per circa 20 minuti, fino ad incontrare la strada che scende dalla
Valle Benedetta (segnavia 00) e procedendo in direzione nord, per andare a villa
Cristina.
Ci saremo in altri 20 minuti, ricordandosi al bivio di andare a destra perché di indicazioni non ce ne sono e, non avendo bussola, si rischia di perdere la strada.
Da Villa Cristina, gestita dagli scouts di Livorno (anche adesso, non essendoci indicazioni, prendere a destra per lo sterrato in piano), raggiungiamo nuovamente prima la casa disabitata e quindi il Tiro a segno (15 minuti al quadrivio ed altri 15 alla sbarra del parcheggio..Nota: procedendo oltre, fin dove la strada sterrata spiana , e deviando verso destra, il sentiero scende fino alla Cascata dell’Infernaccio, un luogo ameno che conclude degnamente una degna passeggiata per le Colline. Totale percorrenza dell’intero anello circa 2 h. , senza interruzioni né soste alla cava ed all’Infernaccio.
i luoghi: Le ghiacciaie _ Nel Granducato di Toscana, l’attività di produzione, conservazione e vendita del ghiaccio e della neve ricadeva sotto il monopolio del granduca ed era regolata dallo Scrittoio delle Regie Possessioni, ufficio istituito da Cosimo I. Nel 1777 l’abolizione della privativa, con conseguente liberalizzazione della produzione e del commercio del ghiaccio, fu un incentivo per molti imprenditori che decisero di investire in quest'affare. Se inizialmente per conservare il ghiaccio si utilizzarono cavità naturali, col passare del tempo furono costruite strutture specifiche finalizzate a questo scopo. Una ghiacciaia era composta di un pelago, area naturale o artificiale destinata alla formazione del ghiaccio e dalle conserve, aree destinate alla conservazione del ghiaccio costruite secondo diversi metodi e stili. Generalmente la raccolta del ghiaccio si eseguiva su un terreno asciutto, possibilmente poco esposto al sole, in cui si scavava una fossa di forma circolare tendente a restringersi man mano che si procedeva in profondità. La buca era rivestita dal basso verso l’alto con pietre ben intonacate oppure si ricorreva ad un rivestimento di legno. Sul fondo era scavato un pozzo, provvisto di grata, destinato a raccogliere l’acqua che si creava a causa del parziale scioglimento del ghiaccio. La parte superiore della ghiacciaia era ricoperta da legna e paglia conferendo alla struttura una forma piramidale. La parte interna invece era totalmente rivestita con paglia. L’introduzione del ghiaccio all’interno della cavità doveva essere eseguita in modo da non creare troppi spazi vuoti tra i diversi pezzi di ghiaccio. In tal caso s’introduceva acqua nelle fessure affinché si creassero piccoli ghiaccioli all’interno degli spazi vuoti in modo da formare un unico blocco di ghiaccio che successivamente sarebbe stato rotto a pezzi per prendere la porzione necessaria. Una volta introdotto il ghiaccio, lo si ricopriva con paglia e vi si ponevano sopra assi di legno e pietre. Il sentiero necessario per entrare nella ghiacciaia, solitamente volgeva verso nord ed era provvisto di due porte. All’interno delle ghiacciaie, oltre al ghiaccio, era conservata anche la neve, che veniva raccolta in luoghi erbosi, in modo che non fosse mescolata con la terra.
Anche se molte di queste ghiacciaie non sono state individuate sul territorio, la cartografia ed i documenti risalenti al XVIII secolo ci tramandano toponimi relativi alla parola diaccio. Nella pianta della macchia di Suese, ad esempio, ritroviamo i toponimi collina dei diacci, gronde dei diacci, la strada dei diacci che va alle Guasticce ecc., dai documenti risulta che la tenuta includeva cinque conserve ed una grande area adibita a pelaghi. In un documento del 1826 vengono mensionati due complessi di ghiacciaie nella zona di Collesalvetti uno dei quali in località Badia. Altri due depositi di ghiaccio nel territorio comunale si trovano in prossimità della Sambuca (lungo il torrente Ugione); anche se non conosciamo l’anno in cui sono state costruite queste ghiacciaie abbiamo note datate al 1779 relative alla vendita del ghiaccio.
Eremo della Sambuca
Il Romitorio della Sambuca (Santa Buca), situato nella Valle del torrente Ugione, è posto tra il Monte Masso, il Monte Corbolone e la Valle Benedetta e prende il nome dalla suggestiva posizione e dalla presenza dei religiosi. E’ raggiungibile attraverso quattro strade: la prima discende dalla Valle Benedetta, la seconda passa dalle Vallicelle, la terza si dirama dalla via di Nugola ed infine la quarta passa da Parrana San Martino.
Questo luogo inizialmente fu la sede di eremiti agostiniani che vi costruirono un romitorio ed una chiesetta (Santa Maria di Parrana). Intorno ai primi anni del 1300 l’edificio fu abbandonato e nel 1318 il romitorio e la chiesetta furono donati ad alcuni frati di penitenza. Fu in quella circostanza che il romitorio cambiò il suo nome in Santa Maria della Sambuca. Tra il 1374 ed il 1375, Michele da Firenze e Luca Laterini (o della Terrina), appartenenti entrambi all’Ordine dei Gesuati, edificarono il convento dedicato alla Vergine. Le celle erano poche e potevano accogliere non più di venti religiosi. Nel 1442 il Vescovo Ricci di Pisa consacrò la cappella, affidando ai Gesuati anche la cura del Santuario di Montenero e fu proprio in quegli anni che il patrimonio dei Gesuati aumentò considerevolmente grazie alle elargizioni.
Nel 1668 Papa Clemente IX soppresse l’ordine dei Gesuati, i quali una volta deposto l’abito rimasero alla Sambuca e a Montenero. Nel 1688, probabilmente i Gesuati non dovevano più esser presenti alla Sambuca, poichè ci si doveva rivolgere ai Vallombrosani per celebrare la messa nella chiesetta. Il passaggio del Romitorio in mano ai privati va a coincidere con l’inizio del periodo di decadenza dell’edificio che, dopo una serie di modifiche, acquista una connotazione rurale. La struttura passò dalla famiglia Tonci alla famiglia Mangani, per poi esser venduto alla famiglia Cipriani che s'impegnò nel restauro.
Furono messe a vista le costruzioni originarie, stonacati gli ambienti ed eliminate le cause delle infiltrazioni. Durante i molti lavori di restauro, ritornò alla luce l’affresco dell’Annunciazione, fino a quel momento coperto da un contraltare di legno ex voto delle corporazioni del porto di Livorno. Nel 1912 il Romitorio fu dichiarato monumento nazionale e l’anno successivo la chiesa fu riaperta al culto. La Sambuca più tardi passò nelle mani della famiglia Bugliesi e poi del signor Bernini. Negli ultimi anni sulla struttura sono stati eseguiti due interventi di restauro: uno nel 1983, operato dal Genio Civile su delega dalla Soprintendenza con il quale si è intervenuti sul campanile e sulla copertura dell’ala destra dell’edificio; l’altro, nel 1994 eseguito dal Comune di Collesalvetti grazie a finanziamenti della comunità europea.
Le cascatelle dell’Infernaccio, nella valle dell’Ugione La zona è uno dei luoghi più solitari e pittoreschi del Parco delle Colline livornesi, nel cuore della foresta della valle Benedetta e, seguendo per alcuni tratti il corso del torrente Ugione, troveremo una delle cascatelle che si formano nella sua discesa a valle: quella più spettacolare, detta dell’Infernaccio. Il paesaggio geologico è qui molto variegato, con rocce formatesi nei fondali marini di 25 milioni di anni fa e poi emersi per processi tettonici, andando a generare oltre che i monti livornesi, anche l’Appennino. Numerose le cave, sia per l’estrazione di gabbriccio (utilizzato per sottofondi stradali) come per quello di rocce ricche di calcare (usate per produrre calce) e di serpentinite (roccia magmatica verdastra), ma oramai abbandonate. Scarsi invece i coltivi, a causa di terreni argillosi, poco profondi ed aridi, poco adatti all’agricoltura. L’ambiente vegetale è quello caratteristico del clima temperato ed umido, con caducifoglie (Carpino, Acero, Nocciolo, Cerro) e conifere (Pino, Cipresso), largamente usate nei rimboschimenti degli anni ’50.
colline livornesi, uno sbocco al mare del Parco. Il percorso urbano del lungomare labronico termina in prossimità del Castello del Boccale, nella zona più meridionale di Antignano. Da qui, lungo la via Aurelia (che assume la denominazione di via del Littorale), si apre un tratto di costa a strapiombo sul mare che è particolarmente suggestivo ed è conosciuta indicativamente come “Il Romito”. Qui emergono i segni di antiche postazioni d'avvistamento (la Torre di Calafuria e il Castello Sonnino) ed è questa la zona che andremo a visitare . Risaliremo per le Colline sovrastanti (di cui la scogliera è però parte integrante) a partire dal Marroccone, e, dalla "Voltina" – dove c’è uno spiazzo in cui è possibile parcheggiare le auto-, per uno stradello bianco ci porteremo al "semaforo" (tempo h. 1-1,30) facendo un percorso non troppo impegnativo e breve che, arrivando sopra Calafuria ed al Castellaccio, ci porterà infine a scendere a Calignaia, godendo prima e dall’alto del bellissimo panorama sulle isole dell'Arcipelago Toscano e quindi del mare, proprio sotto il ponte di Calignaia.
Benché all’inizio del percorso esista un cartellone esplicativo, i sentieri non sono segnati e meno che mai la deviazione per la costa: il motivo per cui un territorio di così ampio interesse paesaggistico ed ambientale non venga valorizzato, come del resto tutto il Parco delle Colline livornesii resta un mistero, almeno per noi.
Dettaglio:
Si passa sotto l’arco della ferrovia (alle Voltine) e si percorre la strada sterrata, iniziando una salita non troppo impegnativa per una quindicina di minuti, la salita poi tende a spianare e, con calma, possiamo guardarci un po’ intorno: macchia mediterranea e pini e lecci, lungo il cammino, le colline a sud est ed il mare ad ovest.
Non occorre prendere alcuna deviazione ed è sufficiente restare sullo stradello, abbastanza largo, per non sbagliare direzione.
Troveremo un bivio sulla destra (via degli Allori) e quindi un bivio a sinistra (via del Maroccone) ed un altro, ancora a sinistra (via della Cava), non ci facciamo caso ed andiamo invece sempre a diritto, almeno fino ad uno slargo
dove troveremo via del Telegrafo (a destra), noi però andremo invece a sinistra ed in salita a raggiungere in circa 10 minuti il Semaforo, una torre di avvistamento antincendio che sarà per noi un eccellente punto panoramico su tutta la Costa e sulle isole dell’Arcipelago Toscano. Proseguendo, si esce dalla riserva naturale di Calafuria e la sterrata raggiunge l’abitato del Castellaccio. Da quando siamo partiti saranno passate circa 1 ora, 1 ora e mezza, secondo il passo, e non saremo molto lontani da Montenero e quindi da una possibile ed interessante deviazione ecoturistica. Giunti all’abitato sarà sufficiente proseguire per via di Quercianella quando, all’altezza di un quadrivio, con via dei Fondacci sulla nostra destra, prenderemo la via a sinistra dell’asfaltata principale che ci porterebbe al Romito e, trovato uno sterrato, inizieremo ad inoltrarci nella macchia a lecci che digrada verso la costa. Non ci sono sentieri segnati e quindi non è semplice orientarsi, non almeno come fin’ora, tuttavia, sapendo che dobbiamo andare a sud/sud ovest, che scenderemo solamente e che praticamente stiamo seguendo il corso del botro Calignaia, ce la caveremo. In circa un’ora saremo al tracciato della vecchia Aurelia, parallela al ponte di Calignaia, ed il nostro cammino verso il mare sarà terminato.Molto bella anche la discesa nel bosco.Per il ritorno si può utilizzare il bus ma in circa 20 minuti saremo di nuovo alle auto, anche a piedi.
Il percorso, che ha una lunghezza totale di circa 11 km, si snoda attraverso la valle del torrente Fortulla e ci porta dal mare fino alla sommità del Monte Carvoli a quota 352 m/s.l.m.
Lasciare le macchine nei pressi del Residence "Il Boschetto" in località FORTULLINO fra la vecchia Aurelia e la variante. Si incomincia risalendo la valle lungo una vecchia mulattiera che ci porterà ad incrociare la sorgente sulfurea detta “Padula” che pare fosse usata dai romani per le sue caratteristiche oligominerali e la sua temperatura costante di 24° per un impianto termale, del quale sono stati trovate le tracce consistenti in frammenti di ceramica d’epoca. Nella zona è presente anche un’interessante gruppo di lecci ultracentenari. La sorgente si trova presso uno di questi a pochi metri dalla strada. Subito dopo raggiungeremo, con una brevissima deviazione, la sorgente ipotermale detta di “Occhi Bolleri”, nei campi bassi di S.Quirico in mezzo ad un campo. Questa piccolissima sorgente fuoriesce con manifestazioni rumorose, con un gorgoglio come di acqua in ebollizione ed è ricca di anidride carbonica e solfidrato, (acido solfidrico dal caratteristico odore di uova marce), uno “spettacolo” crudele che potremo osservare sarà dato dai numerosissimi insetti che scendendo a bere nelle pozze sono rimasti asfissiati dalle esalazioni venefiche.
Continueremo sul sentiero per incrociare le tracce della miniera “Escafrullina” dalla quale veniva estratto ferro e magnesite e della quale potremo vedere numerose tracce di gallerie e lavori minerari. La macchia Escafrullina prende questo nome da una leggenda medievale che riportava in questi boschi la presenza di una maga con questo nome.
Percorrendo la valle incontreremo “Il Muraglione” una vecchia diga usata come invaso di acqua per la lavorazione dei minerali estratti nei primi decenni del 1900 posto a poche decine di metri dalla confluenza dei due torrenti.
Ancora salendo, adesso in discreta pendenza, attraverso il bosco fino ad incrociare, a quota 260 m/s.l.m., la strada Castelnuovo-Nibbiaia (Via del Vaiolo) che attraverseremo per giungere, con un ultimo strappo, sulla sommità di Monte Calvoli dove sono presenti due cerchie di cinte murarie di ignota origine.
Scendendo di nuovo
verso la valle, passando da casa “Pian dei Lupi”, e dalla necropoli ubicata nei
pressi, verso il Poggio di San Quirico, si raggiunge la miniera di Campolecciano,
da dove veniva estratta la magnesite e, volendo, potremo entrare in una breve
galleria ancora agibile.
Nella zona costiera fra Fortullino e Chioma, alla metà dell'800, l'avv. Gaetano
Lami costituiva la fattoria di Campolecciano e la dotava di un mulino da grano
azionato con le acque del Botro Fortulla.
Seguiamo ora il corso della Fortulla fino allo sbocco in mare passando sotto i
ponti della ferrovia e della strada. Raggiungeremo infine le auto in località il
Boschetto.
Il percorso può anche essere abbreviato alla metà seguendo il corso del botro
senza arrivare fino a Monte Carvoli e tornando indietro per lo stesso sentiero.
nota: una documentazione approfondita della zona, con dettagli fotografici e argomentazioni storiche, è reperibile sull'ottimo sito www.lungomarecastiglioncello.it ed in modo specifico al link
http://www.lungomarecastiglioncello.it/ITINERARI_EXTRA/FORTULLA/~Fortulla.htm
Anello breve valle benedetta, per la cava della Focerella e le sorgenti dell’acquedotto.
- Zona: Valle Benedetta
- Località di partenza: piazzetta fermata bus della Valle Benedetta
- Località di arrivo: medesima
- Accesso al percorso: in auto o autobus linea 12
- Lunghezza complessiva: Km.9.00
- Dislivello totale in salita: mt .200
- Modalità di percorrenza: piedi
- Tempi medi di percorrenza: h.4.00
- Difficoltà: medio/EE
- Principali punti di interesse lungo il percorso: cava della Focerella, acquedotto leopoldino
- Note: le arcate dell’acquedott, odai tempietti alle sorgenti, non hanno protezione alcuna, fare quindi molta attenzione se si intende percorrerli..
- Links utili: http://provincialivorno.parchinsieme.it/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=60
- http://www.associazionegaia.net/flora_colognole.htm
- http://it.wikipedia.org/wiki/Acquedotto_Leopoldino
- Descrizione del percorso: si scende nella valle del torrente Morra, seguendo il percorso 00 dell’ippovia fino ad una cava di rocce verdi (della Focerella) da dove, per una discesa dolce fino al Morra, ci portiamo all’acquedotto. Guadato facilmente il torrente saliremo poi ai tempietti del Poccianti e, per qualche decina di metri, cammineremo sulle arcate dell’acquedotto, almeno finchè queste non cominceranno ad innalzarsi. Tornati sui nostri passi, riguadagneremo quindi nuovamente il torrente per risalire verso la Valle Benedetta, questa volta prendendo però la salita a destra, l’unico tratto un po’ impegnativo del nostro tracciato. Nota: la vegetazione in cui ci immergeremo è sia tipica della macchia mediterranea (corbezzolo, lentisco, mirto,erica, ginestra etc.etc.) che della lecceta (zona acquedotto).
Dettaglio
Dalla piazzetta della Valle Benedetta si sale per lo sterrato di fronte e in dieci minuti, lasciato alla nostra sinistra il primo mulino, ben riconoscibile, al bivio si prende per il sentiero 00 dell’ippovia, in discesa, tralasciando l’altro sentiero sulla nostra sinistra che scende al Calvario prima ed a Pandoiano e Loti poi. Quasi subito troviamo un traliccio della linea elettrica ed a sinistra un ripido sentiero che scende velocemente al Morra, prossimo al camminamento per i tempietti del Poccianti. Lo tralasciamo ed andiamo invece avanti ed in discesa per arrivare, dopo circa 30 mt.ad una fattoria, riconoscibile per i molti cani da guardia che abbaiano. Siamo sempre sullo 00 e continuiamo a scendere per altri 30 mt., arrivando all’ex cava della Fociarella (caratteristica per il colore verde del pietrisco).
A questo punto abbiamo due possibilità: 1) andare oltre la cava e prendere un sentiero c.a.i sulla sinistra, indicato come 02, per scendere alla terrazza dell’acquedotto, la fine del camminamento sull’acquedotto a partire dai tempietti 2) girare a sinistra, con ampia curva, e prendere la sterrata sempre indicata come ippovia 00 per scendere al Morra, all’inizio però del camminamento e non alla fine, dove si arriverebbe, come detto prima, per il sentiero 02.
Oggi scegliamo l’ipotesi 2 ed in 30/40 minuti di discesa non impegnativa arriviamo ad un gruppo di case intorno al Morra, da dove, seguendo il segnavia bianco/rosso, prendiamo una salitella che arriva subito ad un bivio dove gireremo a destra, in salita, per arrivare ad uno spiazzo che ci conduce nel bosco dove prendere a destra per finire sul camminamento dell’acquedotto. Lo risaliamo, compresa la scalinata che troveremo, e saremo ai tempietti (20 mt.). Qui sosteremo, tenendo presente che potremmo anche andare a destra, percorrendo per intero le arcate in muratura dell’acquedotto (30/40 mt., fino all’ultima sorgente dove risaliremmo in salita il sentiero c.a.i n°02, nominato all’inizio, trovandoci nuovamente alla cava della Focerella. Oggi però faremo sosta ai Tempietti e torneremo invece sui nostri passi per la stessa via a ritroso ed in 20 mt. risaremo nuovamente al Morra ed al gruppo di case, dove, oltrepassato il guado, saliremo a destra (nb: siamo arrivati a questo guado da sinistra ed adesso risaliamo a destra).
La salita sarà di 45 mt.circa , fino ad una casa abbandonata bianca, seguita da un'altra abitata, proseguiamo per altri 45 minuti e nuovamente ritroveremo il traliccio dell’alta tensione che abbiamo incontrato all’inizio. Totale dislivello 200 metri in discesa e 200 in salita.Tempo di percorrenza 3.30/4: andata h.2 e h.1.30 ritorno.
Difficoltà media per l’ultima salita). Scarponcini e acqua e ricordare che la Valle la lasciamo alle nostre spalle, dovremo seguire lo 00 e poi girare in direzione Colognole ( a sinistra). Utile anche una carta delle colline perché di segnali direzionali non ce ne sono.
Variante della Valle Benedetta per il Calvario, Pandoiano, l’acquedotto
Dalla piazzetta della Valle Benedetta, dove si legge via del radar, si lascia alla nostra sinistra la discesa che porterebbe alla Sambuca e ci si dirige invece verso lo sterrato proprio di fronte a noi, c’è solo quello e non ci si può sbagliare.
Lo sterrato, dopo un primo tratto in salita, trovando alla nostra sinistra ed in alto e recintati i ruderi di un antico mulino a vento arriva, dopo 10/15 minuti, nei pressi di un evidente incrocio di sentieri.
Andiamo a sinistra ed iniziamo a percorrere il bosco, in leggera discesa e dopo circa 20 minuti troviamo una sbarra alla nostra sinistra, proprio accanto al segnale della regione. Andiamo oltre, ancora a diritto, e dopo poco si esce dal bosco per trovare i ruderi di un vecchio podere, oramai soltanto un cumulo di pietre sormontate da alberi secchi ( guardare in alto e a destra per vederlo, sopra la collina). Un pino solitario si trova più in basso e sulla nostra destra, mentre in alto, sulla collina di fronte ed a destra, vediamo “la palla” della Valle Benedetta con di fronte a noi l’ampio e splendido panorama della piana che da Colognole va a Parrana S.Giusto, al lago di Santa Luce ed alle colline pisane, a sinistra, con in fondo il promontorio di Piombino ed il mare che nelle giornate terse è veramente uno spettacolo da godere.
Siamo adesso al Calvario, detto così perchè l’abate Colombino Bassi, monaco vallombrosano, verso la fine del ‘600, vi issò tre croci per ricordare il Golgotha. A quel tempo l’eremo della Sambuca era passato dall’utilizzo dei Gesuiti a quello dei Benedettini.
Rientriamo nel bosco, restando sempre sulla sinistra del crinale e, seguendo un largo sentiero principale, ben evidente, troviamo uno slargo, una radura ed un bivio di sentieri dove prendiamo quello davanti a noi e non quello alla nostra sinistra. Usciamo dal bosco e cominciamo a scendere: “La palla” è sempre in alto alla nostra destra ed oramai sarà lontana dietro di noi. Continuiamo a scendere per altri 20/30 minuti e troviamo prima i resti di un casale abbandonato e recintato e quindi le prime case della frazione di Pandoiano. Alla fine della discesa, entrando nell’abitato, vedremo un lampione e l’asfalto (dalla nostra partenza, per arrivare qui, saranno passate circa due ore). Qui giriamo a destra, fino ad arrivare ad un circolo a.r.c.i. Davanti a noi vediamo un cartello di divieto di transito ed uno sterratelo con l’indicazione strada privata, lo imbocchiamo ed arriviamo al guado del torrente Morra dopo altri 10/15 minuti. Qui potremo sostare per il pranzo, come anche nei prati del circolino arci. Arrivati che saremo al torrente, all’altezza di un ponticello in ferro, sfondato e quindi pericoloso e conseguentemente non utilizzabile, ci bagneremo un po’ i piedi e passeremo oltre. Proprio di fronte a noi, vedremo una salita, larga e abbastanza ripida, tra la macchia, e, risalendola per circa 30/40 minuti (dislivello mt.150), aiutandoci un po’ con dei bastoncini da montagna, almeno finchè non verrà attrezzato opportunamente per una sua comoda fruibilità, alla fine saremo sulla strada asfaltata proprio all’inizio dell’abitato di Colognole, all’altezza del cimitero. Prenderemo adesso a destra, per circa un chilometro, arrivando ad una trentina di metri prima del bivio per il Gabbro ( alla nostra sinistra sull’asfaltata), e, sulla destra, prendiamo il sentiero che scendendo arriverà ad una spianata sull’acquedotto (lo riconosceremo perché c’è una sbarra proprio all’inizio, ad impedire il transito alle auto), e questo sarà l’inizio della camminata lungo la struttura, sia che vogliamo risalirla sia che da qui si voglia scenderla. Dall’inizio dell’escursione saranno trascorse circa tre ore, soste escluse.
Il sentiero, Immerso nella macchia mediterranea. Arriva subito ad una curva a gomito (praticamente la prima) ed entra nella lecceta, aprendosi in una radura, la spianata di cui si diceva, che porta ai "tempietti” del Poccianti, custodi delle sorgenti principali dell'acquedotto.
Scendiamo ora verso il Morra, utilizzando la scalinata realizzata al di sopra del condotto che porta le acque al Bottin Tondo, raggiungendo e una sorta di “terrazza” che ci offrirà una splendida vista panoramica sull’intero ambiente.
Le possibilità adesso sono due: risalire le arcate dell’acquedotto oppure scendere verso valle per tornare nuovamente alla Valle Benedetta. Prendiamo questa alternativa più breve e, invece di seguire le arcate dell’acquedotto, scendiamo, seguendo l’acquedotto in discesa cioè, proprio davanti a noi, fino ad una casa recentemente ristrutturata , guadiamo il Morra ed andiamo alla nostra destra, risalendola fino ad una casa abbandonata in 45 minuti + altri 45 minuti per trovare un traliccio dell’alta tensione, lo 00 e la Valle.
Tempo di percorrenza totale 5/5.30 ore. Difficoltà: salita abbastanza faticosa dal Morra alla strada asfaltata (circa 45/60 minuti), fangosissima se ci sono state piogge precedenti e l’ultima salita faticosa mt.45 + 45 dal Morra alla Valle.
Nota: da non farsi nella stagione delle piogge, per l’ingrossamento del torrente e per la fangosità della salita verso l’asfaltata per Colognole/Gabbro/Livorno, né da fine novembre a fine gennaio perché è stagione di caccia al cinghiale e quindi si rischia l’impallinamento.
Dalla Valle Benedetta a Villa Cristina per l’eremo della Sambuca
- Zona: valle Benedetta
- Località di partenza: valle Benedetta- cancello aperto dopo via del Radar, sterrato in discesa
- Località di arrivo: idem
- Accesso al percorso: in auto, da Livorno per Valle Benedetta o autobus linea 12 -P.Grande-Ospedale-Salviano-V.Benedetta-Colognole
- Lunghezza complessiva: Km.14
- Dislivello totale in salita: mt.200
- Modalità di percorrenza: a piedi
- Tempi medi di percorrenza: h.3.30 (anello)
- Difficoltà: medio
- Principali punti di interesse lungo il percorso: eremo Sambuca, Ghiacciaie, ruderi dei mulini ad acqua.
- Note: (altre informazioni brevi da sottolineare)
- Links utili: http://it.wikipedia.org/wiki/Eremo_di_Santa_Maria_alla_Sambuca --
- http://www.comune.livorno.it/_cn_online/index.php?id=114&lang=it
-
 Descrittivo:
percorso di media difficoltà, all'andata quasi interamente in discesa per
vaste distese prative punteggiate da ulivi e per sentieri che diventano
sempre più verdi fino ad entrare profondamente nella lecceta, dove troviamo
l’eremo agostiniano della Sambuca. Un attimo di sosta per ammirare l’amena
valle, dove generazioni di monaci si ritirarono per una vita di preghiera e
meditazione e si risale verso villa Cristina. Particolarmente interessante
la camminata lungo il torrente Ugione che ci rivela i ruderi degli antichi
mulini ad acqua della zona. Tempo di percorrenza all’andata di circa h.2.00.
Al ritorno, per una carrareccia della forestale (h.0.30), si torna nei
pressi della Sambuca da dove, in un’altra ora ed in leggera salita, si
raggiunge nuovamente il nostro punto di partenza.
Descrittivo:
percorso di media difficoltà, all'andata quasi interamente in discesa per
vaste distese prative punteggiate da ulivi e per sentieri che diventano
sempre più verdi fino ad entrare profondamente nella lecceta, dove troviamo
l’eremo agostiniano della Sambuca. Un attimo di sosta per ammirare l’amena
valle, dove generazioni di monaci si ritirarono per una vita di preghiera e
meditazione e si risale verso villa Cristina. Particolarmente interessante
la camminata lungo il torrente Ugione che ci rivela i ruderi degli antichi
mulini ad acqua della zona. Tempo di percorrenza all’andata di circa h.2.00.
Al ritorno, per una carrareccia della forestale (h.0.30), si torna nei
pressi della Sambuca da dove, in un’altra ora ed in leggera salita, si
raggiunge nuovamente il nostro punto di partenza.
Dettaglio: al cancello sulla sinistra, dopo via del Radar, prendiamo un sentiero in discesa attorniato da una doppia fila di cipressi e, con ampie panoramiche sulla città sottostante, il mare e la Gorgona, arriviamo in h.0.30 ad un bivio: via delle Vallicelle a diritto e via della Sambuca a destra. Prendiamo a destra ed in h.0.15 , mentre il bosco diventa a cerro e carpino, troviamo un palo della luce con una freccia gialla, la seguiamo ed con altri 10 minuti di cammino saremo ad un incrocio di tre sentieri dove seguiremo l’ippovia in piano (un’altra freccia gialla ci indica la direzione). Adesso, alla nostra sinistra, vedremo la “casa del pastore” tra prati punteggiati da ulivi e l’immancabile gregge di pecore, proseguiamo ancora un po’ e vediamo una sbarra di colore verde ( h.0.10). Proseguiamo, lasciando alla nostra sinistra il sentiero dell’ippovia per costeggiare un torrente e trovare l’eremo della Sambuca dopo altri 10 minuti. Da notare, mentre scendiamo, la presenza di ruderi di mulini alla nostra sinistra e lungo la riva del torrente. Fin’ora sono stati percorsi circa km.5, in discesa, in h.1.15. Oltrepassato il ponticello in pietra, davanti all’eremo, seguiamo adesso il torrente Ugione alla nostra sinistra, trovando altri ruderi dei mulini meglio conservati ed immersi nella lecceta (h.0.10), poi, guadato il torrente, in h.0.20 ritroviamo l’ippovia, sulla nostra sinistra, e la seguiamo, tornando indietro, fino a Villa Cristina (h.0.30). Totale fin’ora h.1.15 + h.0.50. Il ritorno, in leggera salita, ci porta in 30 minuti dal cartello che indica la Sambuca -quello con scritto 0.45- ad un altro successivo e sempre indicante la Sambuca – alla nostra sinistra- per guidarci sulla medesima via dell’andata, a ritroso: h.0.10 alla sbarra e alla fattoria del pastore, h.0.20 al bivio con via delle Vallicelle, h.0.30 alla Valle Benedetta.
Totale percorrenza: c.a km.14 totali , a piedi, all’andata h.2.05, al ritorno h.1.30 (minor tempo perché si evita il percorso sull’Ugione).
note critiche:
assenza di segnaletica, per cui occorre conoscere la direzione da seguire nord/sud o dal Corbolone o dalla Valle Benedetta.
mancanza di manutenzione dei manufatti e quindi inevitabile il loro degrado nel tempo............anche se è vero che una scaletta in legno ci porta alle ghiacciaie dall'Ugione. Ma non viene poi segnalato che continuando per il sentiero si arriva a Villa Cristina.
mancanza di cartellonistica che spieghi brevemente se non la flora e la fauna, almeno la Sambuca e le ghiacciaie.
note positive:
i sentieri principali vengono tenuti puliti e Villa Cristina è "tenuta viva" dagli scouts ed in futuro potrebbe essere attrezzata come piccolo ostello.
Nibbiaia, Podere del Gorgo, Chioma (traversatata)
Punto di partenza e arrivo: Nibbiaia/Chioma
Distanza: 9 km circa
Durata: 3 ore, escluso soste -
Tipo di Tracciato: carrarecce e sentieri
Dislivello: 250 metri circa
Difficoltà: facile
dettaglio:
Lasciate metà auto al Chioma (sotto al cavalcavia), si sale a Nibbiaia Bassa e, trovata via Parri, parcheggiamo. Sulla nostra sx (c’è una grande tavola di legno con indicato il segno bianco rosso del c.a.i n°00 - in piccolo e in alto). Si scende per la strada vicinale, incontrando un vecchio fontanile ed un caseggiato rurale e un podere bianco con cancello. Proseguiamo ed arriviamo infine ad un evidente bivio dove, a sinistra e su un palo in legno c’è un segnale di direzione senza alcuna scritta, solo una freccia in legno (davanti a noi e in discesa vediamo chiaramente una stradella bianca, che evitiamo).
Seguiamo invece l’indicazione della freccia senza scritte e prendiamo la salitella sulla destra per poche decine di metri, inoltrandoci nel bosco.
Fin qui saranno passati circa 30/40 minuti in graduale discesa e/o falsopiano.
Sempre seguendo il sentiero su cui siamo adesso (5 minuti), sempre nel bosco, troviamo quasi subito un sentiero alla nostra destra che ci porterebbe a Nibbiaia alta, noi invece scendiamo per circa 30 minuti e troviamo prima una pesante sbarra di ferro, colorata di verde, e poi un’ampia radura (in località podere del Gorgo).
Prendiamo adesso a sinistra per qualche decina di metri ed arriviamo ad un incrocio di tre sentieri con a destra un palo in legno ed una scritta poco leggibile in alto (Popogna), di là si va alle Palazzine. Noi andiamo invece a sinistra, seguendo l’indicazione per Quarata e, dopo circa 5/10 minuti, troviamo uno spiazzo con un cumulo di pietre impilate, prendiamo allora a sinistra, passando il guado del Chioma e proseguiamo nella boscaglia, sempre restando sul sentiero principale. Da Nibbiaia bassa a qui h.1.20 circa.
Nota: Proseguendo alla nostra destra si finirebbe al Castellaccio (fuori zona per ritrovare le auto) o anche a Quercianella alta.
Guadato che avremo il torrente ci inoltreremo nella macchia, proseguendo senza problemi, sempre sul sentiero principale, che poi diventa francamente strabella, per altri 60/80 minuti, arrivando infine dove avremo lasciato le auto, sotto al cavalcavia ed al porticciolo del Chioma, quando avremo attraversato l’Aurelia.
La bellezza dell’itinerario consiste nell’attraversare zone ancora piuttosto selvagge ed estesi tratti di macchia mediterranea, alta e bassa, dove ogni tanto si scoprono scorci panoramici, sia verso l’entroterra collinare che verso la costa. Bellissime le fioriture primaverili ed interessante il sentiero nella macchia che attraversa il torrente e, a secondo della stagione, anche le molteplici piante aromatiche che troviamo lungo il percorso (salvia, rosmarino, alloro, etc.etc.) come pure le more a fine estate oppure i fichi e l'uva selvatica o le mele, piccole ed aspre ma dissetanti. Da ricordare poi che entrando in paese e lasciato a sinistra il porticciolo del Chioma, andando un po' avanti, si trovano pittoreschi scorci sul mare, dove, lasciata l'auto e scesa la scaletta, è possibile anche fare il bagno..........soprattutto ai primi di maggio quando ancora il turismo di massa manca. Alternativa estiva potrebbe essere anche la spiaggia sassosa del Fortullino, a due Km. sull’Aurelia, verso sud. Criticità: da Nibbiaia bassa (via Parri) non si trovano indicazioni per scendere al Chioma e mancano anche le segnalazioni di direzione una volta che si è arrivati al guado del torrente.
Variante per le Palazzine (in questo caso ricordarsi di lasciare metà auto alle Palazzine e metà a Nibbiaia bassa): da questo spiazzo saliamo per 10 minuti fino ad un invaso artificiale sulla nostra destra e per altri 35 minuti fino a trovare un ponte che conduce al podere Le Cerretelle. Ancora 50 minuti e siamo alle Palazzine, sulla strada per il Gabbro, circa al km.10.00 della s.p. Ritorno dal podere del Gorgo h.1.35.
Variante Nibbiaia alta/Gorgo:
Questo tratto dell’ippovia del mediterraneo, sentiero 00, attualmente è stato spostato da via Parri (Nibbiaia bassa) a via di Montenero (Nibbiaia alta), forse perchè la discesa è molto più remunerativa dal p.d.v escursionistico e quasi interamente nel verde di un bosco di lecci e cerri, con macchia bassa e alta.
Si lascia l’auto al parcheggio degli impianti sportivi di Nibbiaia alta, si risale la scaletta e siamo nella piazzetta del borgo da dove ci incamminiamo per via di Sgarallino alla nostra destra (5 minuti), per lasciarla quasi subito e svoltare (alla ns/sinistra) in via di Montenero (5 minuti). In fondo alla via troviamo un tunnel verde ben riconoscibile, proseguiamo per altri 5 minuti e siamo ad una casa colonica, con vista sulla valle Benedetta (in alto si nota l’osservatorio), dove un segnale ci indica il Chioma.
Andiamo in discesa per 15 minuti ed arriviamo ad un bivio, che però trascuriamo per proseguire a diritto. Avanti e sempre in discesa per altri 30 minuti (al bivio, a sinistra si finirebbe sullo stradello che porta a Nibbiaia bassa, in via Parri), trovando prima una pesante sbarra verde e quindi la zona detta “podere del Gorgo”, dove possiamo scegliere se andare al Chioma o alle Palazzine o al Castellaccio e/o Quercianella alta, seguendo le indicazioni date in precedenza. Tot.minuti 60, circa .
Volendo non scendere al Chioma da Nibbiaia ma dalle Palazzine, sulla strada per il Gabbro verso il Km.10 della provinciale e ben segnata da un cartello, ricordandosi di lasciare metà auto qui e metà al Chioma, sotto al cavalcavia, si prende per l'ippovia, per scendere a destra della casa.
Fatti pochi metri in discesa, a livello del traliccio enel e trovato uno spiazzo larghissimo e panoramico, si prende a sinistra per il sentiero c.a.i 00e, dopo 30 minuti di cammino si arriva ad una curva che si segue (a destra c'è una fattoria) e si va avanti per altri 5 minuti trovando, sulla nostra sinistra, un ponte con l'indicazione "le Cerretelle". Ancora 20 minuti e , sempre a sinistra, troviamo una deviazione verso un torrente, buono per una sosta, che noi trascuriamo per procedere avanti e trovare prima un invaso artificale per raccogliere acqua e successivamente un bivio con l'indicazione Quarata, in alto su un palo.
Sono passati altri 30 minuti. Nota: a sinistra troviamo il sentiero che conduce a Nibbiaia - seguendo i segni bianco/rossi del c.a.i e trovando una casa e quindi la salita per Nibbiaia ( da circa 12 metri di altitudine si va ai mt.275). Non prendendo la deviazione a sinistra ma andando avanti verso Quarata, in pochi minuti si arriva allo spiazzo per deviare verso Chioma, come descritto nell'itinerario sopra a questo:
attraversiamo il torrente ed entriamo nel fitto della macchia, andando avanti per circa 60/80 minuti ed arrivando infine al porticciolo del Chioma o per meglio dire prima dell'Aurelia dove avremo lasciato le auto.
La bellezza dell’itinerario consiste nell’attraversare zone piuttosto selvagge ed estesi tratti di macchia mediterranea, dove ogni tanto si scoprono scorci panoramici, sia verso l’entroterra collinare che verso la costa. Bellissime le fioriture primaverili ed interessante il sentiero nella macchia che attraversa il torrente e, a secondo della stagione, anche le molteplici piante da cucina che troviamo lungo il percorso (salvia, rosmarino, alloro, come pure le more di fine estate oppure i fichi e l'uva inselvatichita e le mele, piccole ed aspre e dissetanti). Da ricordare poi che entrando in paese, lasciato a sinistra il porticciolo del Chioma, si trovano pittoreschi angoli di mare dove, lasciata l'auto e scesa la scaletta, è possibile fare il bagno..........soprattutto ai primi di maggio quando ancora il turismo di massa non c’è ancora. Alternativa estiva potrebbe essere ance la spiaggia sassosa del Fortullino, a due Km. sull’Aurelia, verso sud. Totale itinerario km.8 circa per h.3.00 di cammino tranquillo (dislivelloin discesa di circa mt.250)
Verso il monte La Poggia (colline livornesi)
A partire dal vialetto retrostante il Cisternino, ci incamminiamo verso l'entroterra per uno dei tratti sterrati che scendono alle arcate dell’acquedotto. Scesi che saremo sui campi andremo a diritto davanti a noi seguendo dei segni bianco/rossi che ci condurranno dai campi alla boscaglia e di nuovo sui campi, all’altezza di un guado che ci conduce direttamente alla macchia che ci porta alla fonte dell’acqua puzzolente (h.0,30 + 0,10).
Qui, all’altezza del ponte in cemento (a destra si va alla fonte) si procede a diritto per uno stradello che collega tra loro i diversi poderi e orti della zona e lo si segue per circa h.0,30. Arrivati ad un bivio, lasciamo questa carrareccia ed andiamo a destra, proprio dove vediamo una sbarra bianco/verde che ci segnala che siamo nel Parco. Saliamo adesso nel bosco, risalendo il rio la puzzolente che ad un certo punto dobbiamo guadare, di traverso, alcune volte (per circa h.0,30). L’ultimo tratto di questo itinerario è in leggera salita per altri h.0,15 e ci vede sbucare sul monte La Poggia, proprio sotto la zona della cava del Canaccini. A questo punto prendiamo lo stradello asfaltato alla nostra destra e in discesa per circa h.0,20, finchè troviamo un bivio che scende a destra ed entra nel bosco per circa h.0,45, uscendone alla fine sulla sinistra trovando una rete divisoria lunghissima che seguiamo non lasciando il bosco finchè non arriviamo alla zona degli oliveti. Scendiamo a diritto tra gli olivi, leggermente sulla destra e siamo alla fonte della Puzzolente in altri h.0,45. Siamo alla fine del nostro itinerario: prendiamo a destra, passiamo il ponte in cemento e voltiamo a sinistra, ritornando in vista delle arcate dell’acquedotto, dopo aver oltrepassato una sbarra sul sentiero. Ci dirigiamo verso le arcate ed in altre h.0,30 siamo arrivati. Totale circa h.4 (escluse soste) x 12 km.
dalla valle del rio Savalano a quella del rio Sanguigna. Il progetto “occhisullecolline” richiede un monitoraggio frequente del territorio che permetta di evidenziare criticità sui sentieri, segnalando strutture murarie che necessitino di manutenzione e documentando eventuali inizi di discarica, tanto per fare alcuni esempi, ed essendo importante per questo l’ausilio dei soci, con fotoscatti successivamente girati al tavolo tecnico del progetto. Questo detto, l’iniziativa di oggi ci porterà dal borgo di Colognole, percorrerendo le zone boschive che fino all’immediato dopoguerra univano la frazione al Gabbro, a Castelnuovo e Rosignano per arrivare a Vada, ai mulini del rio Sanguigna. Inizialmente saremo su un terreno roccioso, con basalti e serpentiniti, quindi scenderemo e risaliremo nella macchia bassa a cisto, mirto, lentisco e ginestra (la valle del rio Savalano e di diversi altri botri di minore entità) e poi nella macchia d’alto fusto, a pini, sugheri, frassini e lecci. La salita si spianerà infine nella carrareccia per villa Mirabella, settecentesca e storica dimora da troppo tempo in avanzato degrado, e da qui ai mulini ad acqua del rio Sanguigna, altro patrimonio storico del nostro territorio. Nota: per permetterci di apprezzare pienamente l’ambiente e rendere la passeggiata non affrettata, l’escursione viene prevista con le auto lasciate nei due borghi attraversati. Durata complessiva prevista, escluso soste, di circa h.4.
descrittivo: dal centro di Colognole si scende per 10 minuti ed all’altezza del cimitero si gira a sinistra per il sentiero 199. Si scende, ma prevalentemente si sale, per circa h.2, prima prendendo a sx al primo bivio (vedere segno sull'albero alto, a scendere) e dopo, a sx e sempre a scendere, al secondo bivio, per guadare il rio Savalano. Continuando per il largo sentiero si arriva poi, in salita, alla Sp.8 dove noi andremo a destra per circa mt.200 imboccando quindi lo sterrato a sx. Troviamo quasi subito una marginetta e noi, sempre seguendo i segni bianco/rossi, entriamo in zona abitata per circa 30 minuti, fino ad attraversare in discesa un canneto per ritrovare l'asfaltata. Siamo adesso al cimitero del Gabbro. Prendiamo per il sentiero indicato come per Mtb, a sinistra della struttura e scendiamo per circa 60 minuti, prima per uno stradello sterrato e dopo nella macchia per un sentiero più stretto. Fare attenzione che dopo circa 30 minuti, ad un bivio (un palo a terra porta le indicazioni direzionali) dobbiamo andare a destra. Si scende ancora ed attraversiamo il paese del Gabbro. Arrivati che saremo in fondo a via delle rose, proprio sopra il parcheggio, seguiamo l'asfaltata andando a sinistra ed allo sterrato che troviamo alla nostra destra, il primo che incontriamo e che ci porta ad una casa colonica, lo seguiremo fino in fondo, per girare all'ultimo a sx, in salita. Eccoci a villa Mirabella in 10 minuti. Si torna poi indietro per la stessa via ma, al parcheggio delle auto e sulla nostra sinistra, scendendo per l'asfaltata, arriviamo al campo sportivo, dove, proprio nello spiazzo di fronte ed in discesa ed ancora sull'asfaltata a sinistra, ci porteremo finalmente ai mulini: di cima (prendendo primo sentiero a dx), di mezzo (deviazione a dx) e di bucafondanda (deviazione a destra) , in altri 30 minuti circa.
Totale: circa h. 4 - solo andata - partenza h.8.30 da Livorno ed alle 9 da Colognole. Arrivo a villa Mirabella alle 13 circa dove si effettua la sosta-pranzo. Pomeriggio ai mulini. Nota: portare auto al Gabbro e tornare con quelle alle auto lasciate al Gabbro.
1) Dal monumento a Ciano (Montenero) alla fonte del Sasso Rosso.
Dal parcheggio di Montenero si va in direzione Livorno e, quasi subito, troviamo uno sterrato a sinistra in leggera salita. Tempo 15 minuti e siamo al monumento a Ciano. Si prende adesso lo stradello a sinistra ed al primo bivio, dopo altri 15 minuti, si va a sinistra, arrivando all’incrocio tra via Lecceta e via Vignacce, qui prendiamo a destra e saliamo per 5 minuti quando al nuovo bivio andremo a sinistra, salendo, per circa 40 minuti, arrivando al Castellaccio ed intravedendo la zona pic nic, sotto la casa Forestale. Sosta e quindi percorso di 10 minuti nella macchia accanto al posteggio, per trovare la fonte del Sasso Rosso basta andare sulla sterrata che sale verso la Forestale e prendere il primo sentiero a sinistra.
Al ritorno scenderemo da via Castellaccio (accanto a dove saremo sbucati e riconoscibile per il divieto di transito), via Castellaccio diventerà via Ciampi e dopo via Byron, riportandoci prima in piazza delle Carrozze e quindi nuovamente al parcheggio in circa 40 minuti.
2) Alla grotta dei banditi
presa la carrareccia dietro la casa della forestale per circa 30 minuti e superate le deviazioni a sinistra per Pian della Rena (segnali bianco rossi 138 e 140), troviamo alla nostra destra un segno verde per terra. Proseguiamo nella macchia per circa un’ora e senza deviazioni (restare comunque a sinistra), arrivando a trovare un altro segno verde alla nostra destra. Adesso giriamo a sinistra e invece di scendere che ci sembrerebbe ovvio, fatti 30 metri, troviamo l’ingresso della grotta. Al ritorno scendiamo poi per il sentiero di prima e, trovato subito un bivio, prendiamo la traccia a salire per un’ora circa a ritrovare la carrareccia della mattina che prenderemo però a sinistra, Altri 40 minuti e siamo nuovamente al Castellaccio.
nota: descrittivo della fonte del sasso rosso a http://www.agireverde.it/programma%202015.htm#Domenica_25_gennaio:_percorsi_della_memoria.
La valle del Fosso del Molino nuovo:
percorso
dall’area di sosta al Castellaccio si scende a visitare la fonte del Sasso Rosso (primo sentiero a sinistra del parcheggio). Si scende, con molta attenzione, alla tagliafuoco sottostante (sentiero n°138) e lo si percorre in discesa per h.0,30, fino a Pian della Rena. A vista della costruzione si prosegue per il sentiero 138, in salita per h.0,15, fino all’intersezione col n°140, girando qui a sinistra a trovare, sempre sulla ns/sx il sentiero 134. Questo bellissimo sentiero nella macchia scende per h.1.45 ed arriva a un evidente bivio dove noi, lasciando il 134, scendiamo per la bretella di raccordo 134 a, altre h.0.15. Terminata la discesa, talora difficoltosa, siamo sul sentiero 136, costeggiamo il botro Molini, passando un paio di ponti in muratura, e proseguiamo in leggera salita per h.0.45, tornando a Pian della Rena, Adesso seguiamo il sentiero 138 a destra, al contrario dell’andata, e in h.0,45 siamo all’asfaltata. Altre h.0.10 e saremo di nuovo alle auto.
Totale escursione, escluso soste e visita alla fonte del Sasso Rosso, h.4.30 circa.
Escursione di media difficoltà, per lunghezza e saliscendi, obbligo scarponcini robusti e molto utili i bastoncini.
da Nibbiaia alle grotte dei banditi
 La “grotta dei banditi” è a
neanche un paio di chilometri dal Castellaccio ed era il luogo dove si
rifugiavano i partigiani del Decimo Distaccamento Oberdan Chiesa della Terza
Brigata Garibaldi, insieme ai tanti giovani alla macchia che, dopo l'8
settembre’43, fuggivano dal reclutamento forzato fra i repubblichini e dai
rastrellamenti dei tedeschi (ricordiamo che la strage di Sant’Anna di Stazzema
avvenne nell’agosto del’44 e quindi che la guerra era tutt’altro che finita). La
zona “Quarata” è impervia e boscosa ma, conoscendone i sentieri, soprattutto
adesso che sono stati puliti, non sarà difficile trovarla, a partire dal
torrente Quarata ed arrivandoci da Nibbiaia. L’escursione ha una notevole
valenza paesaggistica ed evidentemente anche storica, sviluppandosi per i 2/3
nel folto del sottobosco collinare e per 1/3 su strade vicinali, ad uso dei
numerosi poderi della zona. Nota: grotta dei banditi è così chiamata
perché i tedeschi i partigiani li chiamavano banditen. Dettaglio:
arrivati al campo sportivo di Nibbiaia si attraversa la strada ed in direzione
Gabbro si va avanti per circa 10 minuti. In via di Montenero, alla nostra sx, e
sempre seguendo il sentiero 00 ed in discesa (segni bianco/rossi), si arriva al
podere del Gorgo - mt.45 – da dove, alla nostra sx , prendiamo per una
carrareccia in direzione Quarata, per altri mt.45. In alto noteremo una casa
colonica bianca e da lì, alla nostra dx, saliremo nella macchia per mt.40,
arrivando ad uno spiazzo aperto con evidente bivio. La zona si riconosce per dei
segni blu su alcune pietre. Prendiamo a dx, in discesa, arrivando alle grotte,
sulla nostra sx ed indicate da una freccia blu. Visitate le grotte, continueremo
per il sentiero, in discesa, e risaremo alla casa colonica di prima ( mt.40 dal
bivio) dove, per la stessa via dell’andata, termineremo il percorso in circa
h.2.
La “grotta dei banditi” è a
neanche un paio di chilometri dal Castellaccio ed era il luogo dove si
rifugiavano i partigiani del Decimo Distaccamento Oberdan Chiesa della Terza
Brigata Garibaldi, insieme ai tanti giovani alla macchia che, dopo l'8
settembre’43, fuggivano dal reclutamento forzato fra i repubblichini e dai
rastrellamenti dei tedeschi (ricordiamo che la strage di Sant’Anna di Stazzema
avvenne nell’agosto del’44 e quindi che la guerra era tutt’altro che finita). La
zona “Quarata” è impervia e boscosa ma, conoscendone i sentieri, soprattutto
adesso che sono stati puliti, non sarà difficile trovarla, a partire dal
torrente Quarata ed arrivandoci da Nibbiaia. L’escursione ha una notevole
valenza paesaggistica ed evidentemente anche storica, sviluppandosi per i 2/3
nel folto del sottobosco collinare e per 1/3 su strade vicinali, ad uso dei
numerosi poderi della zona. Nota: grotta dei banditi è così chiamata
perché i tedeschi i partigiani li chiamavano banditen. Dettaglio:
arrivati al campo sportivo di Nibbiaia si attraversa la strada ed in direzione
Gabbro si va avanti per circa 10 minuti. In via di Montenero, alla nostra sx, e
sempre seguendo il sentiero 00 ed in discesa (segni bianco/rossi), si arriva al
podere del Gorgo - mt.45 – da dove, alla nostra sx , prendiamo per una
carrareccia in direzione Quarata, per altri mt.45. In alto noteremo una casa
colonica bianca e da lì, alla nostra dx, saliremo nella macchia per mt.40,
arrivando ad uno spiazzo aperto con evidente bivio. La zona si riconosce per dei
segni blu su alcune pietre. Prendiamo a dx, in discesa, arrivando alle grotte,
sulla nostra sx ed indicate da una freccia blu. Visitate le grotte, continueremo
per il sentiero, in discesa, e risaremo alla casa colonica di prima ( mt.40 dal
bivio) dove, per la stessa via dell’andata, termineremo il percorso in circa
h.2.
Totale km.14 circa e circa 5 ore di cammino - media difficoltà
Descrizione del percorso delle macine: Un percorso ad anello che parte da e arriva alla Valle Benedetta, snodandosi interamente all’interno dell’area dell’ ANPIL DI COLOGNOLE (Area Naturale Protetta di Interesse Locale) ed effettuato in occasione della festa dei parchi 2016.
Dalla
piazzetta della Valle Benedetta si sale per lo sterrato di fronte ed in 10/15
minuti, lasciato alla nostra sinistra il primo e ben riconoscibile mulino, al
bivio, si prende per il sentiero 00 dell’ippovia, in discesa, tralasciando
l’altro sentiero sulla nostra sinistra che va al Calvario prima ed a Pandoiano e
Loti poi. Quasi subito troviamo un traliccio della linea elettrica ed a sinistra
un ripido sentiero che scende velocemente al Morra (n°123), lo trascuriamo ed
andiamo invece avanti, in falsopiano, per arrivare dopo circa 30 mt ad una
fattoria, riconoscibile per i maiali cinghialati. Siamo sempre sullo 00 e
continuiamo per altri 30 mt., arrivando all’ex cava della Fociarella
(caratteristica per il colore verde del pietrisco). Non prenderemo mai
deviazioni, tenendoci sempre sul percorso principale.
A questo punto abbiamo due possibilità: 1) andare oltre la cava e prendere un sentiero sulla sinistra (n°125), per scendere alla terrazza dell’acquedotto direttamente ( alla fine cioè del camminamento sull’acquedotto, a partire dai tempietti) 2) girare subito a sinistra, con ampia curva, prendendo la sterrata, indicata come sentiero 199, che scende al Morra ( all’inizio però del camminamento e non alla fine).
Oggi scegliamo la seconda ipotesi ed in 30/40 minuti di discesa non impegnativa ci portiamo ad un gruppo di case intorno al torrente, da dove, seguendo un segnavia bianco/rosso e prenderendo una salitella, si arriverà subito ad un bivio, andando a destra e in salita, fino ad uno spiazzo che ci porterà nel bosco. Siamo adesso sul camminamento dell’acquedotto, lo risaliamo, compresa la scalinata, e finiamo ai tempietti (20 mt.) dove sosteremo.
Al ritorno seguiremo per intero le arcate in muratura dell’acquedotto (30/40 mt., fino all’ultima sorgente e risaliremmo il sentiero 1252, nominato all’inizio, trovandoci nuovamente alla cava della Focerella, da dove potremo o tornare alla valle Benedetta per lo 00 oppure prendere un sentiero in salita che si trova nello spiazzo esterno (dove vengono parcheggiate le auto), sulla destra. Il tempo di percorrenza per entrambi è di circa h.0,50/0,60.
Tempo occorrente per l’escursione h 4/5 circa, con ampia sosta pranzo e quindi di difficoltà non eccessiva (meglio comunque portare i bastoncini e calzare scarpe con suola robusta). nota: il poggio ai tre mulini che da il nome all'escursione, unitamente ai mulini ad acqua del Morra (attualmente di problematica individuazione perchè vi si è costruito sopra), si trovano prendendo un sentierino che sale per 5 minuti nella boscaglia: al bivio Valle Benedetta/Calvario prendere a sx verso il Calvario per circa 100 metri e un po' più avanti della prima casa a sx, diciamo 10 metri, c'è un sentierino che sale ma lo si perde subito perchè diventa boscaglia. Dopo 5 minuti si vedono i tre mulini, in alto e davanti a noi.
 L’anello
del “ponte romano”,
dai lavatoi del Gabbro ai mulini della Sanguigna
L’anello
del “ponte romano”,
dai lavatoi del Gabbro ai mulini della Sanguigna
Per far conoscere la nuova segnaletica del Parco dei monti livornesi, realizzata e messa in opera grazie al lavoro delle associazioni aderenti al “progetto occhisullecolline”, oggi vi portiamo su un interessante percorso misto che si sviluppa ora in zone boschive, ora per tratte agresti ora infine nell’area dei mulini ad acqua del rio Sanguigna, dopo aver attraversato la valle del botro Riardo, sotto i rilievi di Monte Carvoli e del Monte Pelato. Arriveremo, descrivendo un semianello, al cosi detto ponte romano di Castelnuovo della Misericordia, benchè le sue origini siano più recenti e verosimilmente tardo settecentesche, in quanto costruito per rendere raggiungibile una fornace di mattoni oltre il botro Riardo, anche durante eventuali periodo di piena.
L’escursione inizierà dal paese del Gabbro per raggiungere i vecchi lavatoi, un itinerario che veniva seguito dalle donne del Gabbro per andare ad attingere l’acqua ed a lavare i panni dalla seconda metà del 1600 fino alla seconda del 1900. Saremo parzialmente sul “sentiero del mille” (antico tracciato medioevale che collegava i borghi collinari a Vada e quindi al mare, anche se la costa era tuttavia raggiungibile ben prima, prendendo per la via vecchia della Marina del m.Pelato), per boschi e viottoli di campagna che si alternano piacevolmente, lasciandoci anche il tempo di visitare la valle del rio Sanguigna con i suoi mulini ad acqua, al nostro ritorno. Il trekking non è difficile ed occorreranno circa h.4/4.30 per completarlo, escluse ovviamente le soste sia al “ponte romano” che ai vecchi mulini e prima ancora ai seicenteschi lavatoi, recentemente restaurati.
Dettaglio: Dal parcheggio del Gabbro saliamo all’asfaltata e prendiamo subito per via della Rosa, di fronte a noi e ben riconoscibile per la presenza di un ambulatorio veterinario. Andiamo avanti per circa 10 minuti, uscendo dal paese e trovando prima un’edicola votiva a sinistra e quindi un bivio che ci indica Colognole andando avanti ed invece a destra Ricaldo.
Scendiamo per Ricaldo, ora nel bosco, ora uscendo verso i coltivi ed in altri 20 minuti siamo ai lavatoi del Gabbro, di cui si ha notizia fin dal tardo ‘600. Una breve visita e risaliamo quindi per una stradina sterrata (a destra) che ci riporta sull’asfaltata in circa 20 minuti. Prendiamo ancora a destra per altri 10 minuti sulla provinciale ed iniziamo l’avvicinamento al ponte romano, facendo attenzione a scendere alla nostra sinistra (ben evidenti i cartelli che indicano la direzione da seguire, seguendo il sentiero 199). Ci aspetta adesso un saliscendi di circa h.1, per zone boschive, sterrati e canneti e viottoli lastricati di massi, vestigia di antichi tracciati, finchè, dopo aver guadato il botro Riardo, siamo ad un cancello grigio dove andremo a sinistra per altri 30 minuti per raggiungere il “ponte romano”. Il ritorno sarà per questo stesso sterrato, altre h.0,30 dunque, andando questa volta a diritto per h.0,20 finchè, alla nostra sinistra, vedremo un breve stradello a fondo chiuso dove noi gireremo alla prima carrareccia a destra. In altre h.0,30 saremo al botro Sanguigna ed ai suoi mulini, girando a destra e cercando sempre di seguire il corso d’acqua (la sosta prevedibile per una breve visita è di circa h.0,30). Da qui termineremo infine il nostro giro risalendo per circa h.0,20 ed arrivando al campo sportivo e dopo al parcheggio dove avremo lasciato le auto.
Tot. Prima parte h.1/ seconda parte h.1.30/.Ritorno h.2 Calcolare le soste al ponte h.1 (sosta pranzo) ed ai mulini della Sanguigna h.0.30. Trekking di h.4.30/5 + 1.30 soste.
Altre note descrittive :
1) Gabbro - Sorto sul versante orientale dei monti livornesi ha origini medievali: mai citato dalle fonti come castello – nel ‘300 è definito ‘comune rurale’ - l’agglomerato ereditò probabilmente la popolazione dei vicini castelli di Torricchi e Contrino, forse distrutti già nel corso del basso-medioevo. Il toponimo, dal latino glabrum, allude alla sterilità del suolo, ricco di rocce di origine vulcanica - il “gabbro” appunto, così battezzato in onore del paese, trovando un curioso parallelo nell’appellativo ‘Pelato’ dato al poggio su cui il paese sorge.
La zona fu oggetto, dal 1547 - con Cosimo I° de Medici - in poi, di ripetuti tentativi di colonizzazione voluti dai Medici allo scopo di accrescere la produzione agricola necessaria allo sviluppo del centro di Livorno. L’interesse granducale è testimoniato anche dai resti di numerosi mulini ad acqua, risalenti allo stesso periodo e che sorgevano lungo l’alta valle del Botro Sanguigna, facenti parte di un più ampio sistema produttivo creato proprio allo scopo di approvvigionare di grano la nascente e vicina città di Livorno. Dal 1886 visse a Gabbro il pittore macchiaiolo Silvestro Lega che nella sua opera si è ispirato più volte al paesaggio di questo ridente paese.
2) I vecchi lavatoi:
Situata fra Gabbro e Torricchi per secoli è stata usata da uomini e donne per l'acqua da bere e per lavare i panni. Da Piazza Cavour, seguendo Via Rialto che scende verso la vallata orientale si ha occasione di percorrere un sentiero molto suggestivo che si snoda fra alberi di sughero ai margini della boscaglia. Questo itinerario veniva seguito dalle donne del Gabbro per andare ad attingere l’acqua e a lavare i panni alla fonte di Rialto. Tale fonte fu ristrutturata nel 1609 e nel 1682 quando vennero costruiti i lavatoi e gli abbeveratoi per gli animali. Prima di arrivare alla fonte è possibile scorgere una edicola votiva originaria del 600, che custodisce un quadro della Madonna, ed alcuni cunicoli nei quali i Gabbrigiani si nascondevano per sfuggire ai bombardamenti dell’ultima guerra mondiale. Si ha notizia dei lavatoi fin dal 1682, quando vengono stanziati dalla Comunità del Gabbro: "25 scudi per fare un arco e muro attorno alla Fonte del Ricaldo, per far venire l'acqua a doccio, fare un abbeveratoio per le bestie.
Il rifornimento di acqua potabile avveniva presso le due fonti distanti un
chilometro dal paese sulla parte destra della strada che porta a Castelnuovo
della Misericordia. Veniva anche attinta a una fonte situata nella località
Riardo, anche questa distante oltre un chilometro dal paese, lungo una strada
secondaria che porta verso la località di Staggiano. Dopo il 1945 la fonte fu
chiusa e l'acqua incanalata, a mezzo di un piccolo acquedotto, fu fatta affluire
alla Fornace Serredi per le necessità della lavorazione. L'acqua veniva
trasportata giornalmente alle abitazioni dalle donne che portavano sulla testa
brocche o canestre piene di fiaschi e da ragazzi con carretti o con corbellini
anche questi pieni di fiaschi. La lontananza delle fonti causava fatica e
perdita di tempo specialmente nell'estate quando si doveva fare la fila perchè
il getto dell'acqua diminuiva. Le donne spesso si recavano, portando sempre
grosse canestre in testa, a lavare i panni ai due lavatoi pubblici, cioè a
quello di Rialdo e a quello che si trova dalla parte opposta, sulla via che dal
Gabbro porta a Castelnuovo della Misericordia. Due fonti di incerta potabilità,
una chiamata fonte di Giomo sulla via Taversa Livornese per Castelnuovo poco
prima della località Stregonie e l'altra situata nelle vicinanze, fornivano
acqua, per far fronte alle diverse necessità degli agricoltori e dei possidenti,
i quali riempivano damigiane e botticelle che trasportavano con carri trainati
da buoi o con barrocci trainati da cavalli o di ciuchi. Dopo il 1945 il comune
di Rosignano Marittimo, dietro le insistenti richieste dei paesani, deliberò di
fare l'acquedotto per portare l'acqua potabile in paese. Fu allora incanalata
l'acqua delle due fonti e, utilizzate altre sorgenti a mezza costa della collina
di Poggio d'Arco, fu creato un deposito sul Poggio Pelato. Col passar del tempo
le fonti del paese furono integrate da altre direttamente installate nelle case
avendo così gli utenti l'acqua sempre a disposizione senza fatica, con vantaggi
igienici e senza perdita di tempo. Purtroppo quando il Comune, per
approvvigionare l'acqua potabile al paese di Nibbiaia, decise di alimentare
l'acquedotto con altra acqua presa lungo il fiume Sanguigna, in località
Bucafonda, la situazione peggiorò sia come qualità sia come quantità. Da
- http://www.lungomarecastiglioncello.it/
Pellegrinaggi medioevali nel territorio livornese
Nell’area settentrionale delle Colline livornesi sono presenti due complessi storico-religiosi di culto Mariano che hanno caratterizzato dal punto di vista sociale, economico e religioso questa porzione di territorio: il Santuario della Madonna delle Grazie di Montenero (1390) e l’Eremo di Santa Maria alla Sambuca (1367). In questi due luoghi i pellegrini medioevali di ritorno da Santiago di Compostela o diretti a Roma, due delle tre grandi mete spirituali dell’epoca, insieme a Gerusalemme, arrivano alla ricerca di riparo, ospitalità e cibo e ci sono testimonianze di un percorso che dalla pianura livornese, attraverso la via delle Sorgenti, costeggiava la valle del torrente Ugione per giungere all’Eremo della Sambuca, da dove poi proseguiva verso Roma lungo la Via delle Parrane oppure lungo il principale percorso della Via Francigena, verso Volterra e S. Gimignano. I Gesuati gestirono congiuntamente i beni dell’Eremo della Sambuca e del Santuario di Montenero (tra il 1450 e il 1650) ed è quindi probabile che per questo siano aumentati i contatti tra i due luoghi facendo in modo che i devoti che venivano in pellegrinaggio al Santuario proseguissero poi il loro cammino penitenziale o devozionale verso l’Eremo della Sambuca e viceversa. Oggi è storicamente possibile ricostruire un percorso che, partendo dall’Eremo della Sambuca sale a Valle Benedetta, prosegue per un breve tratto verso ovest sulla S.P. 5 di Valle Benedetta fino a Poggio Montioni e, deviando a sinistra verso Campo della Menta e Popogna Nuova, raggiunge la Strada provinciale e Popogna Vecchia per terminare, seguendo l’attuale segnavia 140, a Castellaccio e quindi, per la via del Poggio, arrivare in breve all’Aula Mariana ed al Santuario, dove nel 1500 i fedeli si recavano, dopo la fine della pestilenza della città di Livorno (1479) a rendere grazie alla Madonna di Montenero. La presenza di testimonianze religiose e dello storico uso di strade e sentieri come percorso di umiltà e semplicità offre lo spunto per proporre un particolare utilizzo dell’anello di sentieri di questa porzione del Parco che, come il pellegrino di un tempo noi percorreremo, ritrovando forse un’occasione per rallentare i nostri ritmi quotidiani, ascoltare la voce della natura ed anche ascoltare noi stessi.
Il Percorso del Pellegrino si sviluppa su una parte dei sentieri presenti nella foresta di Montenero, tutti efficacemente e recentemente segnalati con segnaletica a terra dalle associazioni aderenti al Progetto “Occhi sulle Colline”. Il Percorso del Pellegrino è formato da quattro sentieri principali, percorribili ad anello, e due varianti che permettono di “chiuderlo”. L’intero percorso è segnalato con frecce segnavia.
Testo liberamente adattato da: http://www.percorsodelpellegrino.it/pagine/pellegrinaggi.html
Dettagli percorsi a: http://www.percorsodelpellegrino.it/pagine/i_sentieri.html
Noi oggi seguiremo un itinerario breve, utilizzando i sentieri 138 (in discesa per h.0,40 fino a Pian della Rena dove, a vista della costruzione, si prosegue per il sentiero 138, in salita per h.0,20, fino all’intersezione col n°140. Qui si va a sinistra per il sentiero 134 (non segnalato), bellissimo tratto nella macchia che scende per h.1.45 ed arriva a un evidente bivio dove noi, lasciando il 134, scendiamo per la bretella di raccordo 134 a, altri h.0.20. Terminata la discesa, talora difficoltosa, siamo sul sentiero 136, costeggiamo il botro del Molino nuovo, passando un paio di ponti in muratura, e proseguiamo in leggera salita per h.0.45, tornando quindi a Pian della Rena dove saliremo nuovamente per il sentiero 138 e quindi il 140 verso destra per arrivare in h.0,45 all’asfaltata. Altre h.0.15 e saremo di nuovo alle auto. Nota: in prossimità di questo percorso sono accessibili sia 1) la fonte del Sasso Rosso (dall’area di sosta del Castellaccio si scende per il primo sentiero a sinistra del parcheggio – non segnalato- per h.0,20). 2 la Grotta dei Banditi (lungo il n°140, poco dopo lo sbocco del n°138, una deviazione a destra -non segnalata- che scende per circa h.0,40.
Da: http://www.agireverde.it/PARCO%20MONTI%20LIVORNESI.htm
Totale escursione, escluso soste, h.4/4.30 circa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
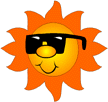 il materiale sottostante è stato raccolto dall’ass.initinere di
Rosignano M.mo, aderente al progetto O.s.C: mappe delle aree sir di Calafuria e Monte Pelato.
Per maggiori dettagli:
http://www.initinereonweb.it/parco-monti-livornesi/
il materiale sottostante è stato raccolto dall’ass.initinere di
Rosignano M.mo, aderente al progetto O.s.C: mappe delle aree sir di Calafuria e Monte Pelato.
Per maggiori dettagli:
http://www.initinereonweb.it/parco-monti-livornesi/
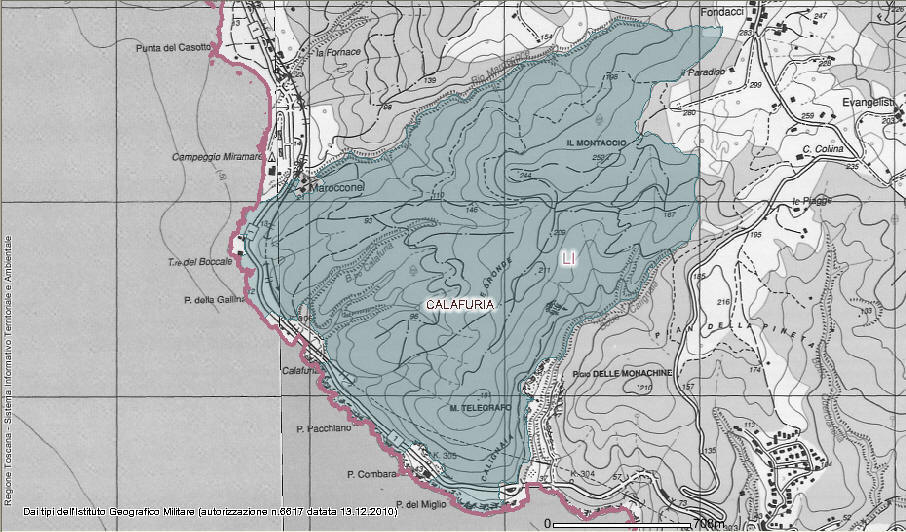 area
S.I.R. Calafuria
area
S.I.R. Calafuria
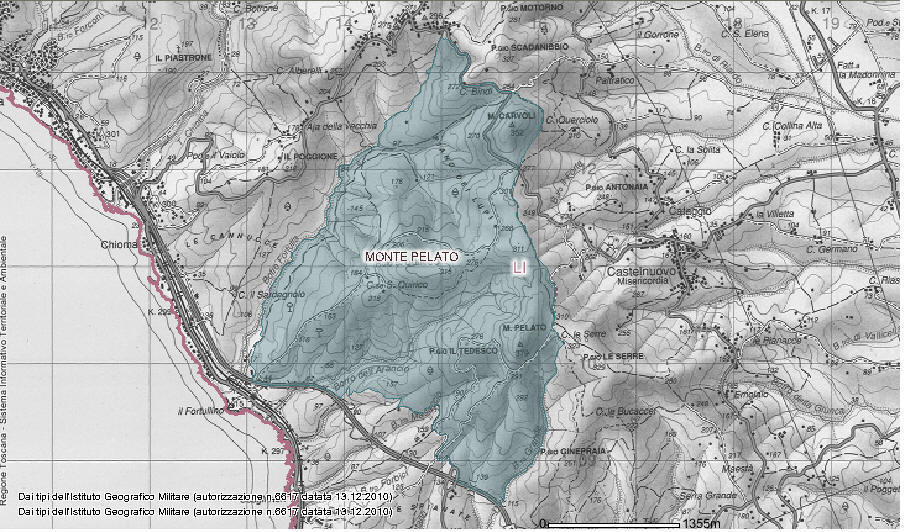 area S.I.R. Calafuria
area S.I.R. Calafuria
Il Parco secondo noi, MANIFESTO
MONTI LIVORNESI - IL PARCO SECONDO NOI
Le 18 Associazioni Aderenti al Progetto Occhi sulle Colline:
Agire Verde Livorno
A.N.P.A.N.A. Livorno (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura e Ambiente)
A.N.W.I. Livorno (Associazione Nordic Walking Italia)
A.S.C.A. (Associazione Scienze e Comunicazione Ambientale)
Asd Il Mandriolo
Circolo Ippico l'Unicorno
Circolo Porto di Livorno gruppo MTB
C.S.S.T.O. (Comitato Salvaguardia e Sviluppo Territorio e Occupazione)
CAI Livorno (Club Alpino Italiano)
FIAB Livorno (Federazione Italiana Amici della Bicicletta)
GAPL (Gruppo Archeologico Paleontologico Livornese)
G.I.R.O.S. (Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee)
I.N.B.AR. Sez. Livorno e Arcipelago Toscano (Istituto Nazionale Bioarchitettura)
INITINERE
Legambiente Livorno
L.I.P.U. Livorno (Lega Italiana Protezione Uccelli)
Trekking Libertas
WWF Livorno (World Wide Fund for Nature)
PROGETTO OCCHI SULLE COLLINE
In prossimità delle elezioni nazionali condividiamo con tutte le forze politiche del territorio questo documento che cerca di riassumere gli obiettivi che le associazioni firmatarie, unite sotto il logo di Occhi sulle Colline, hanno perseguito negli ultimi 8 anni. Un percorso arduo che ad oggi appare ancora lontano e pieno di ostacoli. Questo è un appello per il futuro del nostro territorio.
INGREDIENTI PER “COSTRUIRE” UN PARCO
NATURA = questo è il primo ingrediente, sembra ovvio ma non lo è: ne fanno parte tutte le specie, gli habitat e gli ecosistemi che si sviluppano sull’intero territorio dei Monti Livornesi. E il loro valore e la loro sopravvivenza esula dagli immensi benefici che l’uomo ne può ricavare direttamente o indirettamente. La vita ha diritto di esistere senza che sia sottoposta ad una analisi costi-benefici misurati in euro. Questo “ingrediente” è, fortunatamente, ancora assai presente sulle nostre colline. Tuttavia molte situazioni sono a rischio e gli habitat sono sempre più frammentati; alcuni ambienti rari e preziosi possono scomparire in pochi giorni con la realizzazione di una strada o un taglio boschivo eccessivo.
DA FARE: Occhi sulle Colline e Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno stanno cercando di aggiornare e mettere insieme tutte le informazioni naturalistiche del nostro territorio in un lavoro complesso ma necessario. I dati scientifici permettono di individuare le aree che necessitano una maggiore tutela e il tipo di tutela che occorre.
UOMO = l’uomo è parte integrante della Natura. “Siamo tutti connessi” in un unico ecosistema. L’area protetta nasce dunque non per ESCLUDERE l’uomo da un ambiente naturale ma di ricondurlo ad una corretta convivenza con esso. Nasce per rendere l’uomo consapevole delle conseguenze delle proprie azioni su ambienti che non sono più vasti e incontaminati, ma sono ridotti e fragili. Nasce per educare l’uomo sul fatto che “il BOSCO non è di TUTTI”, come ormai sempre più spesso sentiamo dire da chi vuole agire indisturbato, ma che invece il BOSCO non appartiene a nessuno, e tutti possiamo imparare a godere delle risorse e dei benefici inesauribili e rinnovabili nel tempo che esso ci dà. Anche l’UOMO è elemento già fortemente presente e radicato sul territorio che vogliamo tutelare.
PERCORSI = l’uomo deve potersi muovere all’interno del Parco. Il valore di un’area protetta, ripetiamo, rimarrebbe tale anche se non ci fossero visitatori ma la sua fondamentale funzione educativa si esplica direttamente con la corretta fruizione. Chi fruisce di un’area protetta deve farlo “in punta di piedi”, “senza lasciare tracce” e non è detto che possa raggiungere qualsiasi luogo, né che possa liberamente aprire sentieri dove fa più comodo. Un parco non è un parco finché non ha una mappa di sentieri numerati e identificati sul territorio con segnaletica orizzontale e verticale; sentieri riconosciuti e tutelati dalle istituzioni e dalla cittadinanza, ognuno con le corrette modalità di percorrenza. La mappa dei sentieri deve essere pubblica, facilmente reperibile e periodicamente aggiornata.
DA FARE: Su questo punto Occhi sulle Colline ha lavorato molto, anche grazie al Tavolo Tecnico sulla Sentieristica (tra associazioni, Provincia di Livorno e Comuni di Livorno, Collesalvetti, Rosignano): sono tornati i segni bianchi e rossi sui principali sentieri, ci sono mappe aggiornate di pezzi di territorio. L’attività del Tavolo Tecnico è terminata bruscamente e troppo presto ma il lavoro da fare è ancora tanto. Risulta ancora arduo risalire alla classificazione di una strada; elaborare forme di tutela del sentiero dagli sbarramenti dei privati e dall’ingresso dei mezzi motorizzati; organizzare modalità di manutenzione che ne garantiscano l’accesso in ogni stagione; reperire risorse per una segnaletica verticale efficiente.
ACCESSI = il Parco è un laboratorio educativo e didattico a cielo aperto. Chi visita un Parco, in qualsiasi nazione si trovi, passa inizialmente da un Centro Visite dove poter reperire informazioni, conoscere le peculiarità del territorio, contattare guide, conoscere le modalità per raggiungere e percorrere i sentieri del Parco. Ciò non è presente sul nostro territorio. Un parco non è un parco se non ha luoghi facilmente raggiungibili, soprattutto con mezzi pubblici, da cui poter accedere ai principali sentieri.
DA FARE: Tutto. Le porte del Parco non esistono. Non ci sono luoghi né siti web che presentino informazioni adeguate. Anche per una scolaresca di Livorno arrivare sulle Colline è un’impresa ardua.
CONFINI = Chi entra entro i confini geografici di un Parco, che sia a piedi, in bici, a cavallo o in auto su una strada asfaltata, deve percepirlo. I cartelli che delimitano l’area protetta devono essere ben evidenti. Il Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi è ad oggi un puzzle disarticolato di parti di territorio con modalità di gestione diverse: la cartellonistica assente o ridotta non ha mai permesso al visitatore di capire in quale ambito territoriale si trovasse. I confini di un’area protetta sono dunque importanti ma quasi sempre risultano inadeguati per una gestione virtuosa e una corretta tutela: occorre superarli, andare oltre.
DA FARE: la nuova normativa regionale (LR 30/2015) ha determinato una riclassificazione delle aree protette dei Monti Livornesi. Occhi sulle Colline ha svolto decine di incontri e iniziative per scongiurare la perdita di alcune delle sue parti. Adesso che l’obiettivo sembra raggiunto è necessario sfruttare questa riclassificazione per riconfigurare i confini delle aree protette, da sempre inadeguati per le emergenze naturalistiche del nostro territorio.
REGOLE = Ecco la parola che in molti vorrebbero eliminare dal vocabolario. Ma un Parco non è un parco se non ha un suo regolamento che punta alla convivenza tra UOMO e AMBIENTE e tra le varie attività lavorative o ricreative che si svolgono al loro interno. E le regole non servono se non c’è nessuno che si impegna a farle applicare: non c’è parco se non ci sono i “guardiaparco”. E le regole possono andare dal “non cogliere i fiori”, “non fare rumori molesti” (che impariamo alla scuola primaria o anche prima) al divieto di discariche e edifici abusivi, di caccia o pesca: è evidente che alcune trasgressioni sono più gravi e dannose, ma questo non vuol dire che le altre non siano più sanzionabili.
DA FARE: Tutto. Le regole che ci sono vengono messe in discussione e non vengono applicate, altre mancano del tutto. I regolamenti sono disomogenei sul territorio e per questo difficili da rispettare e da far rispettare. Le nostre colline sono il luogo dove ognuno sembra poter fare quello che vuole. Occorre ritrovare una convergenza tra istituzioni, guardie professioniste o volontarie, carabinieri forestali e anche i cittadini che segnalano le azioni illegali.
SOSTENIBILITA’ = Non si può fare niente dentro un Parco? Si possono fare molte cose, dal turismo all’agricoltura: occorre premiare le attività SOSTENIBILI per l’ambiente che vogliamo tutelare. Un Parco non è un parco se non conosce nel dettaglio quali sono le attività che ricadono sul suo territorio, non sa valutarne gli impatti e non riesce a premiare e incentivare le attività compatibili. Il valore di un’area protetta è inestimabile di per sé ma produce comunque RICCHEZZA e LAVORO continuativi nel tempo se gestita in maniera opportuna.
DA FARE: creare sinergia tra portatori di interesse che lavorano nel campo dell’agricoltura di qualità, dell’agriturismo, del turismo verde e in altre attività che non infliggono danni permanenti alle risorse del territorio. L’esperienza del “Parco Culturale di Camaiano” è un esempio virtuoso. Cancellare una volta per tutto progetti che sembrano portare ricchezza nel breve termine ma che hanno respiro corto o cortissimo. La caccia non è praticabile, può essere adottata una gestione faunistica che operi solo quando si verifichino condizioni di rischio per l’ecosistema e si basi su finalità scientifiche e non venatorie.
ATTENZIONE: anche le attività turistiche/sportive/ricreative, sempre più numerose e diversificate, devono essere valutate ognuna per il loro impatto e di conseguenza regolamentate. La presenza massiccia e continuativa dell’uomo negli ambienti naturali, riduce drasticamente gli ambienti indisturbati che gli animali utilizzano per svolgere fasi importanti e delicate del loro ciclo biologico. Il disturbo è ovviamente insostenibile se queste attività prevedono l’utilizzo di mezzi motorizzati.
RICERCA = il Parco è un luogo di ricerca e studio. Il collegamento con ricercatori, musei, scuole e università deve essere promosso e incentivato. L’evoluzione di un Parco, dei suoi Percorsi, dei suoi Accessi, delle sue Regole, della Sostenibilità delle attività che vi si praticano non deve essere stabilita da sensazioni soggettive, da portatori di interesse o da opinioni politiche ma esclusivamente dai risultati di studi scientifici.
COMUNITA’ = il Parco non esclude l’UOMO ma lo rimette in equilibrio con il sistema naturale. A questo punto il Parco ha l’obbligo di mettere in risalto, immortalare e rinnovare i legami vecchi e nuovi tra Comunità e territorio. I segni dell’uomo e il suo lavoro diventano parte integrante della ricchezza del Parco al pari di un albero secolare. La Comunità si unisce per tutelare non più un pezzo di territorio ma sé stessa. La Comunità diventa consapevole del bene comune di cui gode e di cui godranno anche i figli.
DA FARE: un importante percorso partecipativo che sviluppi una MAPPA DI COMUNITA’ del territorio e che faccia da substrato fertile per la nascita dell’idea di Parco; modalità per far partecipare cittadini e associazioni alla vita del Parco (adozione di sentieri; canali di segnalazione; iniziative condivise ecc…).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aderenti al progetto "gli occhi sulle colline" ed ambito di interesse.
|
Attività |
Descrizione |
Associazione di riferimento o proponente l’attività |
Disponibilità e interesse a partecipare |
|
1 - 2 |
Corso cartografia elettronica e piattaforma WEB. Creazione e gestione sito. |
GULLI |
Agire Verde / MTB Porto / WWF / Unicorno / Inbar / Carnieri / Lipu / /2 esterni: Uaar e Misericordia) |
|
3 |
Raccolta materiale e documenti da caricare sulla piattaforma WEB |
|
Agire Verde / MTB Porto / WWF / Gruppo Arch. / G. Botanico / L. Sturmann / Giros / Gaia |
|
4 |
Raccolta e studio normative che regolano il territorio delle Colline Livornesi |
|
Giros / InItinere / Unicorno / Gaia |
|
5 |
Processi partecipativi. Formazione Comunità. Mappa di Comunità. |
|
G.Brugnoni / Claudia WWF / Unicorno |
|
6 |
Interfaccia con enti e ricerca dei finanziamenti |
Aalscitec |
Unicorno / Gaia |
|
7 |
Presentazione alla cittadinanza. Creazione evento inaugurale e conferenza stampa. Calendario unificato iniziative delle associazioni. |
|
Agire Verde / WWF / Unicorno / Gaia |
|
8 |
Organizzazione di prime esplorazioni del territorio finalizzate a mappatura/segnalazione abusi/studio... |
|
Lipu / Agire Verde / MTB Porto / WWF / G. Arch. / G. Botanico / Legambiente / InItinere / Giros / Unicorno / Gaia |
nota: chi fosse interessato a partecipare alle diverse attività previste per la piena attuazione del progetto, vòlto ad avere a disposizione della comunità un Parco dei Monti Livornesi pienamente fruibile, può contattarci per info su agireverde@tin.it.
Aggiornamenti sul progetto e sintesi, al 31.12.2011
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
La comunità deve “crearsi”, “collaborare”, “discutere” attorno a 3 linee progettuali specifiche che
saranno illustrate di seguito.
1 - Mappatura e monitoraggio dei sentieri.
2 - La segnalazione degli abusi e delle infrazioni.
3 - Centro di documentazione sul Territorio delle Colline Livornesi
Ogni linea progettuale dovrà favorire e prevedere due momenti importanti:
A – la comunità condivide conoscenze e informazioni su una piattaforma web interattiva (ad
esempio mappe online e forum).
B - la comunità si conosce, si incontra, progetta, si attiva sul territorio (gruppi di
volontariato, gruppi di studio, iniziative comuni ecc…).
Per le mappe online interattive sarà usata la piattaforma OpenStreetMap (una wiki-mappa
liberamente modificabile dell'intero pianeta).
Attualmente la “comunità” che “collabora” e “discute” è composta da 16 associazioni - WWF
Livorno, Lipu Livorno, Legambiente Livorno, Associazione Culturale Gaia, Gruppo Botanico
Livornese, Gruppo Archeologico Paleontologico, GIROS Livorno (Orchidee spontanee), GULLi
(Gruppo Utenti Linux Livorno), Aalscitec (Associazione di associazioni per la Scienza e la
Tecnologia), Agire Verde, Circolo Porto Sez. Mountain Bike, Circolo Ippico Unicorno, Initinere,
Inbar (Istituto Nazionale Bioarchitettura sez. Livorno), UAAR (unione atei agnostici razionalisti),
ASD Il Mandriolo – più 3 individui singoli. Ci sono contatti con almeno altri 5 gruppi e
associazioni (CAI Livorno con un incontro specifico, Ass. Italia-Nicaragua, Reset Livorno, Teatro
Agricolo, Giubbe Verdi Rosignano).
Ci sono state riunioni plenarie ogni mese a partire da Marzo 2011 (con l’unica eccezione di
agosto), più 4 riunioni tecniche o momenti formativi. Le sedi utilizzate sono quelle di AALSciTec in
via Roma e del WWF Livorno in via Corsica.
Nella sede WWF è stata allestita dal GULLi una postazione informatica e una connessione internet
(concessa gratuitamente dalla ProLoco SantJacopo).
Le associazioni dialogano in un gruppo GOOGLE di discussione
sguardocolline@googlegroups.com .
Il progetto è stato presentato pubblicamente in tre occasioni: Giornata delle foreste (AALSciTec);
Linux Day (GULLi), Tavola Rotonda (Agire Verde). E’ stato realizzato un volantino fronte-retro
con i loghi di tutte le associazioni e una breve descrizione del progetto.
Alle istituzioni il progetto è stato presentato: dettagliatamente all’Assessore Provinciale alla Aree
Protette Bisti, e poi con brevi cenni agli assessori Grassi e Cantù del Comune di Livorno (Ambiente
e Associazionismo). E’ in programma l’avvio di un Tavolo Tecnico con la Provincia.
E’ stata scelta la modalità e la struttura di base con cui un gruppo ristretto dei componenti delle
varie associazioni con maggiore esperienza informatica, guidate dal GULLi, possa cominciare la
costruzione del sito web.
Sono già stati registrati i domini: www.occhisullecolline.it e www.occhisullecolline.com, l’indirizzo
di posta elettronica info@occhisullecolline.it e gli account
http://www.youtube.com/user/occhisullecolline http://vimeo.com/occhisullecolline
http://www.facebook.com/occhisullecolline
1) Mappatura e monitoraggio dei sentieri.
- STEP 1.1: creazione di una mappa interattiva all’interno dello spazio web dove gli utenti
possono caricare da subito mappe di percorsi da realizzare nel territorio (esclusivamente a
piedi, in bicicletta o a cavallo) con descrizione dettagliata e possibilmente con allegato il file
con la traccia GPS da utilizzare con navigatori satellitari.
Con due serate formative organizzate del GULLi sono state fornite le basi per poter inserire
un percorso nella cartografia di OpenStreetMap alla quale può accedere e inserire
informazioni chiunque si registri (funziona con le stesse modalità di Wikipedia). Da
OpenStreetMap sarà poi in futuro possibile estrapolare i dati che riterremo utili per il
nostro sito web.
Sono state studiate alcune schede per la Rilevazione e la Descrizione di Sentieri per poterne
creare una standard da utilizzare all’interno del nostro Progetto (il modello base è quello
utilizzato per la Registrazione di un Itinerario nella Rete Escursionistica Toscana).
Il Territorio delle Colline Livornesi nella sua interezza è stato suddiviso in aree di studio
per caratteristiche di omogeneità geografiche e ecosistemiche.
- STEP 1.2: creazione all’interno dello spazio web di una “bacheca” (per esempio sotto
forma di forum o blog) dove gli escursionisti possono incontrarsi e organizzare insieme
esplorazioni del territorio (esclusivamente a piedi, in bicicletta o a cavallo).
- STEP 1.3 (con eventuale finanziamento): con l’assistenza e l’autorizzazione della
Provincia, creazione di un gruppo di volontari che possa compiere semplici operazioni di
manutenzione della sentieristica e della segnaletica. Un finanziamento potrebbe essere utile
per fornire il gruppo di idoneo materiale per apporre la segnaletica e di un navigatore GPS.
Abbiamo discusso la questione nei primi contatti con la Provincia e siamo in attesa di
superare alcuni vincoli assicurativi-giuridici. Sarà tema di discussione del futuro Tavolo
Tecnico. Durante le riunioni è stata rilevata la necessita a livello normativo di poter
operare solo su sentieri già registrati nella Rete Escursionistica Toscana (RET): è stato
dunque elaborato un percorso di lavoro per poter affiancare la Provincia nell’iter di
registrazione di un sentiero nella RET (partendo ad esempio da un singolo itinerario
scelto).
- STEP 1.4 (con eventuale finanziamento): selezione e controllo di tutte le informazioni
raccolte per elaborare una guida e una carta (anche a fini turistici) e un sito professionale per
favorire la fruizione dei migliori percorsi del territorio.
2) La segnalazione degli abusi e delle infrazioni.
- STEP 2.1: creazione di una mappa specifica all’interno dello spazio web, per esempio sotto
forma di geoblog, dove inserire tutte le segnalazioni pervenute (ora e data, descrizione ed
eventuale foto, nome del segnalatore) riguardanti infrazioni nel parco come sentieri
inagibili, sentieri chiusi, caccia illegale, discariche abusive, opere edilizie non autorizzate,
distruzione di habitat ecc…
Alle riunioni e in mailing list vengono già esposte molte segnalazioni di abusi e infrazioni.
Non è stato creata però ancora una modalità standard di raccolta delle segnalazioni.
- STEP 2.2: informazione e formazione sugli aspetti normativi che regolano i vari ambiti del
territorio.
Lo studio delle normative per ora non è stata affrontata in maniera sistematica. Sono stati
via via esaminati durante le discussioni alcuni aspetti del Piano del Parco Provinciale e
della normativa che regola la Sentieristica e la Rete Escursionistica Toscana ecc…
- STEP 2.3: contatto con enti provinciali e comunali, Polizia Provinciale e Guardie
Ambientali Volontarie delle Associazioni Ambientaliste a cui far pervenire attraverso un
canale preferenziale le segnalazioni accertate, eventualmente con utilizzo di posta
elettronica certificata.
Le GAV della Lipu e di Legambiente già fanno parte del Progetto. E’ stato chiesto alla
Provincia di fornire un referente per ricevere le nostre segnalazioni e sarà tema del futuro
Tavolo Tecnico. Un breve esempio di raccolta segnalazioni fatti pervenire a Emiliano
Carnieri (Provincia di Livorno) è stato fatto sul tema degli accessi al Parco dei Monti
Livornesi.
3) Centro di documentazione sul Territorio delle Colline Livornesi
- STEP 3.1 (con eventuale finanziamento): creazione di un database pubblico consultabile
dallo spazio web in cui censire le varie realtà che operano in modo sostenibile nel territorio
delle Colline Livornesi, con elenchi di indirizzi utili, di documenti che riguardano il
territorio e le iniziative e le attività della Comunità. L’accuratezza del database dipenderà
anche dalle risorse e dalle competenze disponibili per la sua creazione.
E’ stato fatto in piccolo per le associazioni che fanno parte attualmente del Progetto (elenco
indirizzi e recapiti). Alcune associazioni singolarmente stanno già raccogliendo il proprio
materiale e i propri documenti a disposizione, alcune l’hanno già pubblicato nei propri siti
internet (in attesa del sito web del Progetto).
- STEP 3.2: agevolare l’apertura di un canale di comunicazione tra tutte le realtà, con
interviste e momenti di incontro. Favorire la connessione tra le varie realtà attraverso la
creazione di una mailing list di divulgazione e/o di un piccolo ufficio stampa che diffonda il
calendario delle iniziative delle associazioni e degli operatori coinvolti.
E’ stato fatto in piccolo per le associazioni che fanno parte attualmente del Progetto
(mailinglist) e stiamo provando a far nascere un calendario unico di iniziative per il 2012 e
a creare un evento unico inaugurale.
C) Creazione di una Mappa di Comunità.
Le informazioni e le conoscenze raccolte attraverso queste tre linee progettuali permetterà alle varie
realtà della comunità di arrivare a progettare ed affrontare un percorso partecipato e condiviso che
porti alla costruzione di una MAPPA DI COMUNITA’.
Una “Mappa di Comunità” riassume in una carta tutte le “bellezze” e le “bruttezze” del territorio,
tutte le “opportunità” e tutti i “difetti”, e che inoltre rappresenti il legame uomo-ambiente e l’aspetto
emozionale che ne deriva. La Mappa di Comunità dovrà contenere le invarianti strutturali del
territorio delle Colline, ovvero gli elementi costitutivi dell’identità dell’area dal punto di vista
storico, economico, ambientale e percettivo, che siano di riferimento per valutare ogni tipo di
proposta di trasformazione, per creare una sorta di carta costituzionale del territorio (vedi come
esempio il sito http://www.casentino.toscana.it/ecomuseo/mappe.htm)
Esistono varie modalità per attuare questa parte del progetto (processi partecipativi più o meno
strutturati, utilizzo di software, mappe on-line o cartacee, ecc…) la cui scelta dipenderà
esclusivamente dalle risorse e dalle competenze disponibili.
Il percorso che porterà alla Mappa di Comunità prevederà anche un LABORATORIO PER IL
PARCO DEL FUTURO. Gruppi di studio si occuperanno di valutare possibili strategie per
analizzare e migliorare la situazione attuale con il duplice scopo:
• di aumentare la tutela del territorio
• di promuovere la nascita di opportunità economiche che ne utilizzino in maniera
sostenibile le risorse.
I gruppi di studio dovranno da una parte analizzare la situazione attuale, visionare le proposte
presenti nel Piano del Parco dei Monti Livornesi e i regolamenti delle ANPIL e dall’altra ipotizzare
modi per allargare la tutela del Parco ai territori attualmente non inclusi nei confini dell’area
protetta, studiando strategie virtuose già utilizzate con successo in altre aree protette.
Lo studio della PARTECIPAZIONE e degli STRUMENTI PARTECIPATIVI non è ancora stato
affrontato. Sono stati fatti per adesso girare in mailinglist alcuni primi documenti sulla questione.
Questo è il protocollo d'intesa, raggiunto per una fattiva collaborazione alla sostenibilità del Parco:
PROTOCOLLO D’INTESA PER L’ADOZIONE DI CRITERI CONDIVISI NELLA DEFINIZIONE DELLA SENTIERISTICA E NELLA REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA NELL’AREA DELLE COLLINE LIVORNESI (NOTA: ATTUALMENTE IL PROTOCOLLO VA RIELABORATO E REINDIRIZZATO IN AMBITO REGIONALE, IN FUNZIONE DELLA NUOVA LEGGE REGIONALE SU PARCHI ED AREE PROTETTE con delega non più provinciale ma regionale)
TRA GLI ENTI
· La Provincia di Livorno
· Il Comune di Collesalvetti
· Il Comune di Livorno
· Il Comune di Rosignano Marittimo
E LE ASSOCIAZIONI
· I soggetti aderenti al Progetto “Occhi sulle Colline” e altri soggetti operanti nell’ambito della divulgazione e ottimizzazione delle conoscenze e della tutela e fruizione sostenibile del territorio delle Colline Livornesi
· La Sezione CAI di Livorno
(ENTI e ASSOCIAZIONI d’ora innanzi denominati congiuntamente «soggetti sottoscrittori» del protocollo d’intesa, contenuti e firmatari dell’elenco di cui all’ALLEGATO A, aggiornabile secondo le regole contenute nel presente protocollo all'Art. 3)
Premesso che
Con riferimento all’Area delle Colline Livornesi, lo scopo del presente protocollo d’intesa è quello di stabilire i criteri e le modalità per costituire una rete di sentieri contrassegnati da numerazione condivisa e da segnaletica orizzontale, anche in prospettiva di un eventuale processo futuro di inserimento dei suddetti sentieri nella RET (Rete Escursionistica Toscana disciplinata dalla LR 17/1998 e da Regolamento di attuazione approvato con DPGR 1/R del 9 gennaio 2013).
L’Area delle Colline Livornesi costituisce un patrimonio da tutelare e da rendere maggiormente accessibile sia in termini di disponibilità delle conoscenze sul territorio sia in termini di fruizione sostenibile del territorio da parte degli escursionisti, residenti o non residenti (visitatori/turisti) anche prevedendo Centri di accoglienza e informazione e documentazione della RET come previsto dal Regolamento suddetto .
Scopo ultimo del presente protocollo d’intesa è quindi favorire l’escursionismo quale attività in linea con la conservazione dell’ambiente e la conoscenza rispettosa delle risorse del territorio.
L’Area delle Colline Livornesi rappresenta un’ area:
· geograficamente e geologicamente ben definita che interessa i Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo, delimitata a ovest dalla città di Livorno e dal Mar Ligure, a Nord dalla SS 555, a est dai due corsi d’acqua (Tora e Fine) e a sud dal rilievo di Poggio Pipistrello e ancora dal corso del Fiume Fine;
· interessata da un ricco sistema di aree naturali protette sia nazionali (Riserva Naturale dello Stato di Calafuria), sia provinciali (Parco Provinciale dei Monti Livornesi - ambiti territoriali della Foresta di Valle Benedetta, Foresta di Montenero e Parco dei Poggetti - e Riserva Naturale Oasi della Contessa), sia comunali (6 ANPIL, Aree Naturali di Interesse Locale: Foresta di Montenero, Foresta di Valle Benedetta, Parrana S.Martino, Colognole, Torrente Chioma, Parco del Chioma);
· interessata da Siti di Importanza Regionale (SIR) di cui alla LR 56/2000 e s.m.i.: SIR 47 Padule di Suese e Biscottino, SIR B09 Calafuria e SIR B10 Monte Pelato.
L’Area delle Colline Livornesi è identificata come “Zona 15-Colline Livornesi” nella Pianificazione delle aree effettuata dalla Regione Toscana ai fini della pianificazione della Rete Escursionistica Toscana (RET) (ALLEGATO B).
Nell’ambito di questa area così ben definita risulta prioritario:
1) sviluppare una rete di sentieri con una numerazione coerente tra loro al fine di creare un sistema di sentieri facilmente fruibili dagli escursionisti;
2) utilizzare un modello di segnaletica (coerente con i criteri tecnici e i materiali standard previsti dalla Commissione Centrale per l'Escursionismo del CAI di cui all’ALLEGATO C) e di individuazione dei sentieri rispondente a criteri di funzionalità, chiarezza e semplicità che ne garantiscano la fruibilità;
3) attivare un sistema di controllo, tutela e segnalazione per l'effettiva e corretta fruibilità di tale sentieristica (effettiva accessibilità e percorribilità dei sentieri, effettiva presenza della segnaletica, controllo e sanzionamento da parte dei soggetti preposti nei casi di errata fruizione).
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1–PREMESSE.
Le premesse e gli ALLEGATI A-B-C-D costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’intesa. Il presente Protocollo d’intesa viene sottoscritto in ragione del riconoscimento delle finalità istituzionali delle realtà operanti sul territorio delle Colline Livornesi e del valore del volontariato svolto nell’ambito della tutela del patrimonio territoriale, dell’escursionismo, della manutenzione e tracciamento dei sentieri nonché della ricerca e promozione delle molteplici conoscenze relative agli aspetti naturalistici, scientifici, storici e culturali caratterizzanti il territorio.
Articolo 2–OGGETTO DEL PROTOCOLLO D’INTESA.
Il Protocollo di Intesa viene stipulato nell’ambito degli interessi istituzionali dei soggetti sottoscrittori e ai fini dell’attuazione degli interventi e delle azioni necessari alla promozione di un moderno escursionismo (a piedi, in bicicletta, a cavallo), rispettoso del territorio e delle sue valenze culturali e naturalistiche, che renda accessibili la viabilità antica e le località interessate dal sistema delle Aree Protette del patrimonio escursionistico, naturalistico, scientifico, storico e culturale del Territorio delle Colline Livornesi.
I soggetti sottoscrittori (ENTI e ASSOCIAZIONI) all'unanimità potranno approvare l'inserimento nell’Allegato A di nuovi soggetti sottoscrittori.
Articolo 3–DEFINIZIONE DEL “GRUPPO DI LAVORO SENTIERISTICA”
Con la sottoscrizione del presente Protocollo d’intesa, tutti i soggetti sottoscrittori (ENTI e ASSOCIAZIONI) s’impegnano a nominare un “Referente per la sentieristica” e a comunicare un indirizzo email di riferimento (ogni soggetto sottoscrittore avrà cura dell’eventuale aggiornamento del nominativo e indirizzo); i “Referenti per la sentieristica” così individuati costituiscono il “Gruppo di lavoro Sentieristica”.
L’attività del “Gruppo di lavoro Sentieristica” potrà svolgersi:
- sia tramite contatti mail (organizzati tramite mailing list tra gli indirizzi email di riferimento)
-
sia tramite convocazione c/o locali istituzionali della
Provincia di Livorno di un tavolo tecnico: il tavolo tecnico è presieduto
dalla Provincia di Livorno (o eventuale soggetto sottoscrittore delegato)
e tutti i soggetti sottoscrittori si impegnano a prenderne parte.
Il tavolo tecnico, come indicato nel
seguente Articolo 4, potrà essere appositamente convocato nel corso
dell’attività di definizione della sentieristica; in tal caso, sentiti tutti
i soggetti sottoscrittori per concordare modalità e tempistica, il tavolo
tecnico sarà convocato dal soggetto proponente comunque entro 30 giorni
dalla mail “Proposta di sentiero”.
La Provincia di Livorno (anche tramite eventuale soggetto
sottoscrittore delegato) si impegna inoltre a convocare il tavolo tecnico
con periodicità almeno quadrimestrale concordandone modalità e tempistica
con tutti i soggetti sottoscrittori . In caso di impossibilità i referenti
possono delegare o un altro componente della propria associazione o un altro
referente di un soggetto sottoscrittore.
Articolo 4–Attività del “Gruppo di lavoro Sentieristica” PER LA definizione della sentieristica e PER LA realizzazione della segnaletica orizzontale dei sentieri
Per effetto del presente Protocollo d’intesa, per l’inserimento di un sentiero nella rete sentieristica e per procedere alla realizzazione della segnaletica orizzontale, tutti i soggetti sottoscrittori (ENTI e ASSOCIAZIONI) s’impegnano all’attuazione dei criteri condivisi di seguito riportati (sintetizzati nell’ALLEGATO D), in modo tale che ciascun nuovo inserimento dovrà essere condiviso dalle Amministrazioni pubbliche territorialmente competenti firmatarie del presente protocollo d’intesa:
1) ogni soggetto sottoscrittore, una volta identificato un sentiero esistente da inserire nella rete sentieristica delle Colline Livornesi, ne dà comunicazione a tutti gli altri soggetti sottoscrittori inoltrando una email a tutti gli indirizzi di riferimento con oggetto “Proposta di sentiero” avente in allegato una carta esaustivamente rappresentativa del tracciato proposto (in formato .pdf o .jpg e qualora disponibile in formato .shp o .gpx) e la corrispondente numerazione a 2 cifre proposta (dispari ad est dello 00 e pari ad ovest dello 00);
2) per tener conto di eventuali proposte di varianti/modifiche, gli altri soggetti sottoscrittori, entro 15 giorni dalla data di trasmissione della email di “Proposta di sentiero”, possono inoltrare eventuali osservazioni e/o richieste di convocazione del tavolo tecnico nel rispetto delle seguenti modalità:
CASO A: nel caso in cui, entro i suddetti 15 giorni, non ci siano osservazioni e/o richieste di convocazione del tavolo tecnico, il proponente può procedere alla realizzazione della segnaletica orizzontale applicando la numerazione proposta e adottando i criteri tecnici e i materiali standard previsti dalla Commissione Centrale per l'Escursionismo del CAI di cui all’ALLEGATO C;
CASO B: nel caso in cui ci siano osservazioni, tutti i Referenti per la sentieristica interessati si confrontano tramite i contatti email di riferimento al fine di procedere o ad una validazione della proposta o ad una revisione sostanziale della stessa; entro 30 giorni dalla trasmissione della email di “Proposta sentiero” la proposta è sottoposta a votazione tramite i contatti email secondo il criterio di maggioranza semplice (e quindi con l’ assenso delle Amministrazioni pubbliche territorialmente competenti firmatarie del presente protocollo d’intesa):
- qualora la proposta sia validata il proponente può procedere alla realizzazione della segnaletica orizzontale applicando la numerazione proposta e adottando i criteri tecnici e i materiali standard previsti dalla Commissione Centrale per l'Escursionismo del CAI di cui all’ALLEGATO C;
- qualora la proposta non sia validata il proponente procederà ad una nuova elaborazione del materiale e ripercorrerà la procedura a partire dal punto 2);
CASO C: nel caso in cui risulti esserci almeno una richiesta di convocazione di tavolo tecnico il “Gruppo di lavoro Sentieristica” si riunisce al fine di procedere ad una revisione sostanziale della proposta; in questa sede la revisione della proposta è sottoposta a votazione secondo il criterio di maggioranza semplice:
- qualora la proposta sia validata il proponente può procedere alla realizzazione della segnaletica orizzontale applicando la numerazione proposta e adottando gli standard previsti dalla Commissione Centrale per l'Escursionismo del CAI di cui all’ALLEGATO C;
- qualora la proposta non sia validata il proponente procederà ad una nuova elaborazione del materiale e ripercorrerà la procedura a partire dal punto 2).
3) durante la realizzazione della segnaletica orizzontale potranno essere effettuate piccole attività di ripulitura dalla sola vegetazione che ostruisca il sentiero o che impedisca la leggibilità della segnaletica orizzontale stessa (interventi di manutenzione ordinaria limitati al taglio di sterpaglia e di ramaglie di piccoli arbusti, prestando attenzione alla presenza di biodiversità da tutelare), utilizzando se necessario mezzi motorizzati di appoggio per l’accesso ai luoghi di intervento previa comunicazione (fax o email) all'ufficio competente.
4) una volta ultimata l’attività di segnatura, il soggetto proponente ne dà comunicazione a tutti gli altri soggetti e, al fine di rendere disponibili le informazioni utili per un eventuale futuro processo di inserimento del sentiero in RET, mette a disposizione degli altri soggetti sottoscrittori il materiale raccolto e prodotto in formato propedeutico all'inserimento in RET. Le informazioni verranno fornite con il solo scopo di supportare la definizione della sentieristica. I sottoscrittori si impegnano a controllare l'accuratezza e l'aggiornamento delle informazioni e dei dati che verranno forniti. Tuttavia i sottoscrittori non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni provocati direttamente o indirettamente a cose e/o persone da imprecisioni o errori nelle informazioni e nei dati che verranno forniti. Nel dettaglio, per quanto riguarda l’utilizzo della piattaforma Open Street Map, i dati del progetto Open Street Map sono rilasciati su licenza Open Data Commons Open Database License (ODBL, http://opendatacommons.org/licenses/odbl/summary/).
Questi stessi criteri condivisi (sintetizzati nell’ALLEGATO D) sono applicati anche per ogni eventuale proposta di modifica funzionale a migliorare la fruibilità della rete sentieristica (ripercorrendoli a partire dall’inoltro di una email a tutti gli indirizzi di riferimento con oggetto “Modifica di sentiero”).
Articolo 5–ALTRE
ATTIVITA’ DEL “GRUPPO DI LAVORO SENTIERISTICA”
Con la sottoscrizione del presente Protocollo d’intesa, al fine di attivare un processo di confronto e monitoraggio, tutti i soggetti sottoscrittori (ENTI e ASSOCIAZIONI) s’impegnano a collaborare per:
a) definire un
“Disciplinare per la manutenzione della sentieristica delle Colline
Livornesi” in modo tale che gli ENTI sottoscrittori possano deliberarne
l’approvazione entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo
d’Intesa; il disciplinare sarà finalizzato a regolamentare le
tipologie di intervento mirate agli aspetti della sorveglianza, custodia,
regolare assistenza e supporto operativo (in termini di definizione delle
modalità di controllo della percorribilità dei sentieri, della presenza di
eventuali ostacoli lungo i sentieri e della necessità di ripristino della
segnaletica, anche tramite l’eventuale attivazione di piattaforme on-line e
l’attivazione di interventi di manutenzione straordinaria con disponibilità
di personale e mezzi delle pubbliche amministrazioni di competenza);
b) la produzione, la condivisione e la pubblicazione sui siti istituzionali di materiale informativo inerente la sentieristica e la segnaletica (privilegiando l’impiego di formati informatici facilmente divulgabili e aggiornabili);
c) produrre il materiale necessario alla predisposizione di un progetto esecutivo per l’inserimento dei dati nel Catasto dei Sentieri in armonia con quanto previsto dalla Regione Toscana per la Rete Escursionistica Toscana (RET);
d) garantire la salvaguardia delle porte di accesso alla rete sentieristica individuata, affinché tali porte siano ben individuabili, sicure e permanenti per gli escursionisti a piedi, a cavallo e in bicicletta, specie laddove l’accesso del sentiero non sia su strada demaniale o vicinale ad uso pubblico, ma su strada privata o vicinale ad uso privato;
e) individuare
le criticità relative alla fruibilità del territorio a causa del passaggio
di mezzi motorizzati in aree dove la percorrenza non è permessa a tali
tipo di mezzi, nonché a collaborare per lo studio e l’applicazione di
misure atte all’impedimento dell’accesso di mezzi motorizzati dove non
consentito (quali un’apposita cartellonistica, un maggior controllo sul
territorio e/o eventuali “barriere fisiche”);
f) progettare modalità di inserimento di una segnaletica verticale, rispettosa delle specie vegetali e animali, che risponda a criteri di funzionalità, chiarezza, tale da semplificare ed arricchire la fruibilità della rete sentieristica;
g) condividere eventuali processi di cambiamento relativi alla pianificazione delle aree ricadenti nell’Area delle Colline Livornesi e/o eventuali progetti in corso o in attivazione;
h) la ricerca di specifici finanziamenti per far fronte agli oneri connessi alla realizzazione delle azioni di cui al precedenti punti.
Livorno, 25 Marzo 2013
ALLEGATO A
Soggetti sottoscrittori: ENTI
|
Nominativo |
Nominativo Referente per la sentieristica |
Indirizzo email Referente per la sentieristica |
Nominativo Rappresentante/i |
Data e Firma Rappresentante per sottoscrizione |
|
Provincia di Livorno |
|
|
Paolo Pacini Assessore ai Parchi, Agricoltura, Turismo, Pesca |
|
|
Comune di Collesalvetti |
|
|
|
|
|
Comune di Livorno |
Alessandro Ursi |
Massimo Gulì Assessore all’Ambiente, Protezione Civile, Associazionismo |
|
|
|
Comune di Rosignano M.mo |
|
|
|
|
Soggetti sottoscrittori: Soggetti aderenti al Progetto “Occhi sulle Colline” (i nominativi indicati potrebbero attualmente non essere più gli stessi)
|
Nominativo |
Nominativo Referente per la sentieristica |
Indirizzo email Referente per la sentieristica |
Nominativo Rappresentante/i |
Data e Firma Rappresentante per sottoscrizione |
|
AALSciteC (Livorno) |
Carmela Sturmann |
Carmela Sturmann |
|
|
|
Agire Verde (Livorno) |
Luciano Suggi |
Luciano Suggi |
|
|
|
Circolo Porto - Sezione MTB (Livorno) |
Fabrizio Petri |
Fabrizio Petri |
|
|
|
GAIA (Collesalvetti) |
Francesca Ruggeri |
Francesca Ruggeri |
|
|
|
Gruppo Archeologico Paleontologico Livornese (Livorno) |
Roberto Branchetti |
Roberto Branchetti |
|
|
|
G.I.R.O.S.-Sezione di Livorno (Livorno) |
Iolanda Legitimo |
Iolanda Legitimo |
|
|
|
G.U.L.Li * (Livorno) |
Fabrizio Carrai |
Diego Banti |
|
|
|
Istituto Nazionale Bioarchitettura (Livorno) |
Simona Comelato |
Simona Comelato |
|
|
|
INITINERE (Rosignano M.mo) |
Barbara Sandri |
Barbara Sandri |
|
|
|
Legambiente -Sezione di Livorno (Livorno) |
Achille Luckenbach |
Achille Luckenbach |
|
|
|
LIPU- Sezione di Livorno / GAV (Livorno) |
Fabio Cagliata |
Fabio Cagliata |
|
|
|
Il Mandriolo (Rosignano M.mo) |
Euro Giusti |
Euro Giusti |
|
|
|
UAAR Circolo di Livorno (Livorno) |
Carmela Sturmann |
Carmela Sturmann |
|
|
|
Unicorno (Livorno) |
Cristina Pasquini |
Cristina Pasquini |
|
|
|
WWF -Sezione di Livorno (Livorno) |
Diego Guerri |
Diego Guerri |
|
* Il G.U.L.Li sottoscrive il presente protocollo con le sole finalità specifiche di dare supporto tecnologico per la preparazione delle informazioni necessarie al processo di definizione dei sentieri e di contribuire al trasferimento delle informazioni relative alla sentieristica definita sul portale del progetto cartografico Open Street Map. Al fine di rimanere attivo nello specifico ambito di attività, il G.U.L.Li contribuirà ad un efficiente svolgimento dei confronti email per gli aspetti di propria competenza e delle convocazioni del “Tavolo Tecnico Sentieristica”, supportando le discussioni e presenziando agli incontri, ma non prenderà parte alle votazioni del “Tavolo Tecnico Sentieristica”.
Soggetti sottoscrittori: altri soggetti operanti nell’ambito della divulgazione e ottimizzazione delle conoscenze e della tutela e fruizione sostenibile del territorio delle Colline Livornesi
|
Nominativo |
Nominativo Referente per la sentieristica |
Indirizzo email Referente per la sentieristica |
Nominativo Rappresentante/i |
Data e Firma Rappresentante per sottoscrizione |
|
Sezione CAI di Livorno** (Livorno) |
Osvaldo RIGHINI |
righini.osvaldo@alice.it |
Osvaldo RIGHINI |
|
|
Gruppo Botanico Livornese (Livorno) |
|
|
|
|
|
Associazione Trekking Libertas (Rosignano M.mo) |
|
|
|
|
|
Associazione Amici della Natura (Rosignano M.mo) |
|
|
|
|
|
Gruppo MTB Rosignano (Rosignano M.mo) |
|
|
|
|
** La Sezione CAI di Livorno sottoscrive il presente protocollo anche in qualità di garante tecnico dell’adozione degli standard previsti dalla Commissione Centrale per l'Escursionismo del CAI fatti propri dal DPGRT 61/R/2006 (Regolamento di attuazione della LR 17/1998 “RET e disciplina delle attività escursionistiche”)(ALLEGATO C
NOTA: per seguire l'evoluzione di questo progetto e per maggior completezza, vi rimandiamo direttamente al sito appositamente costruito e deputato a questo: