ANELLO N. 3
GREPPOLUNGO - LA CULLA – ROCCIA DEI PENNATI – GREPPOLUNGO
Grado di difficoltà CAI: T=turistico, EE=escursionisti esperti
Km. 8 circa
Tempo di percorrenza ore 3,30
Percorso su strade e sentieri
Quota iniziale metri 340 (Greppolungo)
Quota massima metri 680 (Bacino Setriana)
Difficoltà sul percorso: Ci sono
alcuni tratti in forte salita.
Nel tratto che dal Castellaccio
conduce alla Culla si deve
superare un breve tratto stretto
e tra le rocce, da affrontare
con prudenza, soprattutto se non
si è molto allenati. Nei periodi
caldi è necessario portarsi una
buona riserva di acqua, perché
soprattutto dopo Greppolungo non
ci sono sorgenti.
Dove parcheggiare: Paese di
Greppolungo (limitato nel
periodo estivo)
PUNTI DI INTERESSE
BORGO DI GREPPOLUNGO, nel XIII secolo fu sede di un castello feudale, poi ripopolato nel XV secolo. Intressanti due macine a bascula poco sopra strada (proprietà privata)
RUDERI CASTELLO DI MONTEBELLO, costruito intorno al XII secolo. Di esso si conserva (proprietà privata), il basamento della torre, due macine a bascula, tratti del muro di cinta e di alcune abitazioni.
VILLAGGIO DEI LECCI, villaggio abbandonato del XVI secolo posto nel Comune di Stazzema. Interessanti i ruderi che ancora conservano tratti murari originali.
ROCCIA DEI PENNATI, si tratta di un grande masso calcareo dove recentemente il Gruppo Archeologico Camaiore ha individuato diverse incisioni raffiguranti antichi Pennati, probabilmente riconducibili alle popolazioni dei Liguri Apuani che stazionavano sulle montagne camaioresi.
Domenica 26 maggio: nel Montalbano, terra di Leonardo -
L’escursione ci porterà ad
attraversare i bellissimi oliveti del
Montalbano, nei luoghi che hanno dato i natali a Leonardo, il grande
ingegnere, pittore e scienziato italiano. Partiremo da
Vinci (97 m s.l.m.) e saliremo verso Anchiano, dove è situata la sua
casa natale, proseguendo poi per il crinale boscoso delle colline sovrastanti
fino a raggiungere il borgo di Faltognano ed il suo maestoso leccio monumentale,
dall’ età stimata in circa 300 anni, proprio di fronte alla chiesetta di S.Maria
Assunta, edificata nel XIII secolo, con un bellissimo affaccio panoramico sulla
pianura del Valdarno Inferiore e sul sottostante borgo di Vinci. Il trekking non
è difficile e ci impegnerà per circa 3 ore a/r, cui si aggiungeranno i tempi
necessari per una visita al Museo Leonardiano di Vinci, nelle sedi espositive di
palazzina Uzielli e del Castello dei Conti Guidi, alla casa natale di Anchiano
ed anche, se aperta, alla “Mostra
Impossibile”, a villa Ferrale, con la raccolta di tutte le opere
dell'artista, riprodotte in alta definizione. S.14 (Vinci – Anchiano –
Santa Lucia – Faltognano – Vinci) lunghezza: 7,5km | tempo
di percorrenza a/r: 3h | Difficoltà:
media
http://www.marcopolo.tv/articoli/vinci-toscana/ info varie
Variante breve:
Siccome molti sentieri sono spesso in manutenzione ed i tratti dei percorsi sono ora su sterrato, ora su asfaltata di collegamento, consigliamo questa variante, più breve ma altrettanto soddisfacente, che ci permetterà nello stesso (e meno faticoso!) modo di apprezzare questi luoghi -
Vinci, città di Leonardo
L’escursione ci porterà ad attraversare i bellissimi oliveti del
Montalbano, nei luoghi che hanno dato i natali a Leonardo, il grande ingegnere, pittore e scienziato italiano. Da Vinci saliremo verso Anchiano, dopo aver visitato il borgo, il Museo in palazzina Uzielli e la terrazza panoramica della torre nel castello dei conti Guidi, per un percorso botanico immerso nel verde di vigne ed olivi. Sosta alla casa natale e quindi il ritorno, passando per villa Ferrale e la sua mostra impossibile: l’esposizione delle opere pittoriche di Leonardo a grandezza naturale ed in altissima risoluzione, tant’è che si percepiscono le pennellate come fosse il quadro autentico. In ultimo raggiungeremo il borgo di Faltognano ed il suo maestoso leccio monumentale, dall’ età stimata in circa 300 anni. L’escursione è di tipo storico/naturalistico e da gustarsi rigorosamente senza fretta.Tempi: in auto h.1 // visita al museo e al borgo h.1,30// sentiero verde e casa natale h.1,30// discesa a villa Ferrale e visita h.1,30// in auto a Faltognano h.0,20// al leccio (a piedi) h.0,20 + 0.20// ritorno in auto h.1.

« Fu tanto raro e universale, che dalla natura per suo miracolo esser produtto dire si puote: la quale non solo della bellezza del corpo, che molto bene gli concedette, volse dotarlo, ma di molte rare virtù volse anchora farlo maestro. Assai valse in matematica et in prospettiva non meno, et operò di scultura, et in disegno passò di gran lunga tutti li altri. Hebbe bellissime inventioni, ma non colorì molte cose, perché si dice mai a sé medesimo avere satisfatto, et però sono tante rare le opere sue. Fu nel parlare eloquentissimo et raro sonatore di lira [...] et fu valentissimo in tirari et in edifizi d'acque, et altri ghiribizzi, né mai co l'animo suo si quietava, ma sempre con l'ingegno fabricava cose nuove. » (Anonimo Gaddiano, 1542)
Per approfondimenti su Leonardo da Vinci, andare alla pagina:
1) https://www.google.com/search?q=la+vita+di+leonardo+da+vinci&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
2) https://it.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
Il Montalbano
Il
paesaggio del Montalbano racchiude insieme i caratteri di un’antica bellezza,
quasi solenne, fatta di storia e memoria, e quelli di un’evoluzione vitale che
nel corso dei secoli fino ai giorni nostri è visibile sia nelle testimonianze
materiali e immateriali del territorio che nelle attività della sua gente.
Gli elementi strutturali di questo, come di ogni paesaggio storicizzato, sono
riscontrabili negli elementi fondanti della morfologia del luogo, nella sua
composizione geologica e nel suo sistema territoriale (aree naturali e boscate,
reticolo idrico e sistema insediativo) che appaiono saldamente evidenti e
riconoscibili. Ed è in questa loro riconoscibilità, in questa loro capacità di
essere stati tramandati attraverso i secoli e nel sapersi porre ancora oggi come
capisaldi fondativi e costitutivi dei luoghi che va letta la particolarità
essenziale, il genius loci del Montalbano.
Un paesaggio che si presenta al tempo stesso dolce e rude: dolce come l’icona
del paesaggio toscano con le “colline create perché sovra ognuna vi fosse un
castello… coi pendii coperti di cipressi, …boschetti di querce, boschetti di
acacie, ghirlande di vite” (K.Capek 1923), ma anche solido come la terra in cui
l’uomo ha saputo indurre le forme dell’economia e delle tecniche “organicamente
adeguate al nuovo grado di sviluppo che le forze produttive e sociali hanno
raggiunto in agricoltura” (Sereni, 1961) senza per questo disperderne l’innata
bellezza.
Un paesaggio modellato dalla sapiente saggezza e contadini-artigiani, dove “il
potare gli olivi e le viti, il piegare i capi, è un’arte” (R. Bianchi Bandinelli,
1964), ma anche usato per il tempo libero e lo svago ed anche per la caccia,
praticata per fame, per diletto e dal Rinascimento ad oggi, regolamentata e
limitata ad ambiti ristretti e definiti dagli enti locali. Una tradizione che
continua nel tempo. Così i Barchi si susseguono ai campi, i giardini alle ville
ai paesi in un continuum che ha la naturalezza di un paesaggio costruito con
amore e fatica nei secoli.
La catena collinare del
Montalbano, è una diramazione dell’Appennino Tosco Emiliano, estesa per circa
16000 ettari, che si diparte dal Passo di Serravalle, si snoda in direzione Nord
Ovest – Sud Est ed arriva sino alle Gole della Gonfolina, fungendo da
spartiacque tra due ampie pianure, la Pianura Pistoiese-Fiorentina e la
Valdinievole.
Il crinale è relativamente basso, senza forti variazioni altimetriche e si
attesta a quote introno i 400 -600 m: più in particolare il tratto compreso tra
il Passo di Serravalle ed il Valico di San Baronato ha cime di minore altitudine
oscillanti mediamente tra i 300 e i 400 m s.l.m. anche se si raggiunge quote più
elevate in corrispondenza di tre promontori e si scende a quote inferiori in
corrispondenza dei valichi , mentre il tratto a sud di San Baronto si attesta
tutto sopra i 500 m s.l.m., raggiungendo l’altezza massima in corrispondenza del
Monte Cupola con 633 m s.l.m. Tale promontorio insieme alla cime del Monte
Capolino (644 m s.l.m.) e al Poggio Ciliegio (615 m. s.l.m.) costituiscono la
sommità indicata dal Repetti, nel suo dizionario Dizionario Geografico Fisico
della Toscana (1833) in Pietra Marina e S.Alluccio.
Sempre Repetti sottolinea “La natura del terreno partecipa nella massima parte
di quello di sedimento inferiore, coperto nella base orientale da sedimenti
palustri, e nel suo fianco occidentale da immensi depositi di ciottoli e ghiaje
che ricuoprono una marna ricca di fossili terrestri e marini. Alla parte
australe di questa diramazione fu dato il nome dei monti del Barco Reale per un
vasto parco vestito di selve, fatto circondare di mura dal Gran-Duca Ferdinando
II ad uso di Caccia.” (Tomo, Albano Monte, pag. 60)
I due versanti, orientale ed occidentale, presentano una netta differenziazione
dal punto di vista dell’acclività: il versante occidentale infatti si presenta
più uniforme degradando dolcemente sino a lasciare posto alle basse colline
(tutte intorno ai 100 m ) denominate “Cerbaie” alla cui base si trova la pianura
occupata dal Padule di Fucecchio.
Il versante orientale, invece, presenta lungo quasi tutta la sua lunghezza una
scarpata più ripida che dal crinale arriva sino a mezza costa dove viene
sostituita da un’alternanza irregolare di pendii più dolci.
testo da www.montalbano.toscana.it
per esplorare percorsi - 1) http://www.montalbano.toscana.it/trekking
2) http://www.toscananelcuore.it/i-sentieri/
GIUGNO – escursione per amanti della montagna (da concordare col referente)
Questo mese è dedicato all’escursionismo di montagna, per toccare vette che solitamente non vengono interessate dalle nostre iniziative, elaborate per essere alla portata di tutti i soci. Attualmente si sta pensando alla Pania della Croce, passando per il rifugio Rossi, come ai m.1946 del Pisanino ma anche sia alla Tambura per la Vandelli come al Pizzo d’Uccello in val Serenaia ed al m.Altissimo, per il passo degli Uncini. La data esatta, come anche la mèta, saranno concordate tra i partecipanti, una volta contattato il referente, i primi di giugno. Nota: poiché il dislivello da superare sarà impegnativo ed anche è presumibile che l’escursione sia lunga, si invita alla partecipazione solo chi se la sente ed ha buona gamba. Info : Rossano Poggi - 0586 375131 (ore serali) o 331 1131900
Dal 20 al 27 luglio: luglio - gitone in Alta Valtellina, nel Parco naturale dello Stelvio
Il
Parco Nazionale dello Stelvio è
il più grande dei
parchi storici
italiani, tuttora il più esteso
dell’Arco Alpino ed occupa gran
parte del territorio dell'alta
Valtellina, toccando tre
regioni: la Lombardia, il
Trentino e l’Alto Adige,
confinando a nord con il Parco
Nazionale Svizzero ed a sud con
il Parco Regionale
dell’Adamello. Impossibile non
lasciarsi sorprendere
dall'inestimabile patrimonio
naturale che è possibile
scoprire sia grazie alle
numerose escursioni fattibili
durante tutto l'arco dell'anno,
come pure per l’ ampia varietà
morfologica del territorio,
determinata da cospicui
dislivelli altimetrici che
consentono l’esistenza di ampi
ecosistemi con numerose specie
rare e di animali e di piante. 
Villaggi, contrade e tipiche
baite completano poi lo
scenario, costituendo delle
affascinanti testimonianze di
architettura rurale e sacra, in
completo equilibrio con
l’ambiente. Il nostro programma,
prevede diversi tipi di
iniziative escursionistiche che
spaziano dalla Valfurva, dove
troveremo il ghiacciaio di tipo
vallivo più esteso in Italia,
il ghiacciaio dei Forni, alla Val
Zebrù, una delle zone con la più
alta concentrazione di cervi ma
anche ai passi dello Stelvio o
di Gavia oppure al gruppo
montuoso Ortles-Cevedale,
Info e prenotazioni: Rossano Poggi - 0586 375131 (ore serali) o 331 1131900
Come accennato prima, le iniziative proposte saranno alla portata di tutti poichè diversificate per difficoltà (dislivelli e lunghezza) ed andranno ad interessare zone differenti del Parco, tutte nei dintorni di Bormio, dove alloggeremo, tenendo conto non solo dei tempi di spostamento ma anche della necessità di un acclimatamento: in quota (sopra i m.1.500) la pO2 diminuisce rispetto al livello del mare e quindi la fatica, prima che intervengano i meccanismi di adattamento dell'organismo, può essere sentita prima del solito e per percorsi più brevi.
ipotesi di programma (da valutarsi tutti insieme quando ci si troverà per confermare la propria adesione:
1) La Pedemontana del Reit: Tempo di percorrenza/km: ore 2.00/ km 6 Dislivello: 150 m Difficoltà: T
La Pedemontana è una facile e tranquilla passeggiata che percorre la base della Réit e che attraversa boschi di mughi e larici. Il toponimo Réit deriva infatti da laricetum, cioè lariceto. L’imbocco si trova in località Pravasivo e il sentiero parte in leggera salita per poi diventare quasi interamente pianeggiante. Prima di raggiungere il bivio dal quale si diparte il sentiero che conduce alla Croce della Réit, la Pedemontana incontra una deviazione che permette di raggiungere il Giardino Botanico Rezia, che raccoglie e conserva le specie vegetali della flora alpina. Il percorso porta in breve ad un’ampia radura erbosa, attrezzata ad area pic-nic, detta “Planon dei Laresc”; prosegue poi sino ad arrivare alla Val d’Uzza in località Prati di Sotto. Il rientro avviene lungo il tragitto d’andata o direttamente a Bormio passando da Pramezzano e dai ruderi del Castello di San Pietro (detto anche Gesa Rota).
Info dettagliate su immagini, punti info e percorsi -
da: http://lombardia.stelviopark.it
http://lombardia.stelviopark.it/il-parco-in-lombardia/
http://lombardia.stelviopark.it/giardino-botanico/
http://lombardia.stelviopark.it/escursioni/
http://lombardia.stelviopark.it/centri-visite/
http://lombardia.stelviopark.it/le-impronte-delluomo/
Il Forte Venini di Oga
Il Forte Venini, dal nome del
capitano valtellinese al quale è
stato dedicato, si trova a pochi
chilometri da Bormio, nelle
vicinanze della frazione di Oga.
Dotato di quattro cannoni a
lunga gittata – oggi rimossi –
venne realizzato tra il 1911 e
il 1913 allo scopo di proteggere
le strade dello Stelvio e del
Foscagno da una eventuale
penetrazione austriaca. La
struttura fu dismessa
dall’Esercito nel 1958 e sebbene
tutte le aperture fossero state
murate, negli anni successivi fu
saccheggiato e depredato dei
preziosi reperti storici.
A partire dal 1985 è stato restaurato e riaperto al pubblico.
Loc. Dossaccio
23030 VALDISOTTO SO
Tel. 0342950166 (Pro Loco
Valdisotto)
“ Centro storico di Bormio „
Il ricco passato di Contea si respira ancor oggi a Bormio passeggiando nel centro storico immersi tra le innumerevoli testimonianze del suo glorioso passato.
In ognuna delle cinque contrade (o reparti) in cui è suddivisa Bormio si può ancora ammirare il grande patrimonio artistico frutto di una storia secolare che rende questa zona unica rispetto alla gran parte delle altre località turistiche montane.
Il liber stratorum, risalente al 1304, rappresenta il più antico documento dello sviluppo urbanistico di Bormio: a quei tempi due erano le sole grandi aree occupate: quella che oggi corrisponde alla Piazza del Kuerc e quella attorno alla chiesa di Sant’Antonio nel cuore del reparto Combo.
Ancor oggi queste due zone, perfettamente conservate, offrono la possibilità di godere di innumerevoli scorci tra le case e gli incantevoli angoli rimasti come un tempo.
Numerosi sono anche gli affreschi che, la gran parte restaurati, adornano le facciate di molte case del centro storico di Bormio così come gli splendidi portali intagliati nel legno.
Nel XIV secolo, periodo in cui era fiorente il commercio e il transito, Bormio contava ben 32 torri, simbolo della potenza dei casati, la cui quasi totalità sono però andate distrutte. Rimangono, oltre quella del Kuerc simbolo stesso di Bormio, la Torre degli Alberti, nel cuore della Via Roma, e quella annessa al Palazzo De Simoni.
I monumenti di Bormio :
Le chiese di Bormio :
Altre idee per passeggiate defatiganti, alternative ad escursioni proposte o anche come idee di acclimatamento:
Bienno: uno dei borghi più belli d’Italia
Il primo giorno ci siamo fermati a Bienno, il Borgo dei Magli e degli Artisti, insignito deltitolo di “Uno dei borghi più belli d’Italia” ; è un paese medievale nella Valle Camonica in provincia di Brescia. Un borgo fatto di acqua e pietra, la cui peculiarità è quella di lavorare il ferro. Lasciatevi trasportare in un posto dove il tempo sembra essersi fermato e riscoprite la bellezza dei suoi vicoli, dei mulini ad acqua, dei palazzi, delle chiese, dei musei e delle opere dei vari artisti.
Visitare il lago bianco e Livigno
Proseguendo per Bormio ci siamo fermati anche a vedere il lago bianco, presso il passo del Bernina, in Svizzera; il nome del lago è dovuto al colore biancastro che viene conferito dall’acqua e dalla sabbia del ghiacciaio. Abbiamo poi visitato Livigno dove abbiamo fatto una passeggiata per le vie centrali di questo paese, in provincia di Sondrio, in cui gli acquisti sono agevolati dalla zona extra-doganale.
Alla scoperta della Valtellina e dei sui dintorni
La zona di Bormio è ricca di paesaggi e di attività per tutti i gusti, da quelle sportive a quelle culturali, senza dimenticare la natura, la cucina e le tradizioni. Ci sono però anche dei luoghi particolari nei dintorni che meritano sicuramente una visita.
In particolar modo, in Valtellina, possiamo citare, tra gli altri, Livigno, Tirano, Grosio, senza dimenticare i terrazzamenti che caratterizzano tutto il versante retico della valle. E anche allontanandosi dalla provincia di Sondrio e, talvolta, dall’Italia, potrete trovare dei veri e propri gioiellini: Glorenza, St.Moritz, il Trenino Rosso del Bernina o anche il Castello di Neuschwanstein.
Escursioni da non perdere nei dintorni di Bormio
- Grosio e il Parco delle Incisioni Rupestri
- Il Castello di Neuschwanstein
- Il fiume Adda, il rafting e la canoa
- Il Santuario della Madonna di Tirano
- Il Trenino Rosso del Bernina e St. Moritz
- Il vino della Valtellina e la Via dei Terrazzamenti
- L’Eco-Museo del Bitto e il Fly Emotion
- La Val Venosta e Glorenza
2) in val Fraele
http://lombardia.stelviopark.it/wp-content/uploads/2016/09/DD_Valle_di_Fraele.pdf
Ampia e suggestiva vallata di origine glaciale la Valle di Fraele è oggi caratterizzata dalla presenza di due grandi bacini artificiali. Entrata a far parte del Parco Nazionale dello Stelvio con l’ampliamento del 1977, è l’ideale punto di partenza per escursioni nelle valli limitrofe alcune delle quali particolarmente selvagge e incontaminate.
Giornata in val di Fraele (laghi di Cancano/sorgenti dell’Adda). Questo itinerario ci condurrà in Val Alpisella, in provincia di Sondrio, sviluppandosi lungo un percorso costellato da laghetti alpini ed arrivando alle sorgenti dell’Adda, uno dei fiumi più importanti della Lombardia.
1) Trekking (A/R): h 2.40 circa - Dislivello: 365 m - Difficoltà: medio facile. Nota: un'alternativa possibile (per chi non avesse voglia di fare salite) può essere il lungolago Km. 17. percorso in MTB su sterrato , oppure i percorsi di nordic, utilizzando i bus/navetta che diminuiscono a volontà il chilometraggio da farsi.
Percorso n°1)
Questo itinerario ci conduce in Val Alpisella, in provincia di Sondrio, sviluppandosi lungo un percorso costellato da laghetti alpini e raggiungendo le sorgenti dell’Adda, uno dei fiumi più importanti della Lombardia.
In auto si oltrepassa Bormio e si devia a Fior d’Alpe Turripiano e, seguendo le indicazioni per i Laghi di Cancano e le Torri di Fraele. Si costeggiano i due laghi fino a raggiungere il Ristoro San Giacomo, poco oltre il quale parcheggiamo.
In prossimità di un ponticello sull’Adda prendiamo la stradina che risale gradualmente la Val Alpisella a tornanti. Incontriamo tre laghetti tra i quali si trova una delle sorgenti dell’Adda in alcune pozze rossastre. Le sorgenti di maggior portata si trovano sul versante opposto della valle che si percorre al ritorno. Dopo un’ora di cammino si giunge al passo di Val Alpisella (m. 2.285) dove si trovano un grazioso laghetto e una malga.
Dopo una sosta per ammirare il panorama, si scende fino ad incontrare sulla sinistra un largo sentiero che discende la valle sul versante opposto a quello fatto salendo, con le indicazioni Sorgenti dell’Adda a 15 minuti. Si seguono le indicazioni fino a una serie di sorgenti che scaturiscono dal sottosuolo e si riprende poi la discesa fino al parcheggio.
2) laghetti di Cancano (opzione bike al punto info)
Sorpassate
le torri di Fraele, antiche e
possenti costruzioni di epoca
trecentesca, si raggiungono i
laghetti artificiali di Cancano,
creati nel secolo scorso ( i
lavori per la diga di Cancano
furono ultimati nel 1956 ) per
la produzione di energia
elettrica ed oggi gestiti da
AEM, e che hanno portato alla
creazione di un ambiente unico,
ideale per passeggiate a piedi,
trekking e in mountain bike tra
i boschi dell’alta montagna
valtellinese.
I laghi sono alimentati di acqua dallo Spòl, dai torrenti Alpe, Gavia, Frodolfo, Zebrù, Braulio, Viola e Forcola e, anche dal più celebre fiume Adda che ha poco lontano le sue sorgenti e sono in grado di contenere fino ad oltre 190 milioni di metri cubi di acqua in massima portata.
Per raggiungere i laghetti di
Cancano è sufficiente seguire le
apposite indicazioni posizionate
lungo la strada che da Bormio
porta verso Livigno, deviando
nei pressi dell’abitato di
Premadio lungo una strada che
sale ripida sino al passo di
Fraele.
In sintesi:
arrivare in auto fino ai
parcheggi nei pressi della
Palazzina A2A, proseguendo
verso le Torri di Fraele
acquistando un ticket al costo
di € 5,00, inclusivo del costo
del parcheggio.
http://lombardia.stelviopark.it/escursioni/
http://lombardia.stelviopark.it/centri-visite/
https://www.bormio.info/scoprire_bormio/laghetti-di-cancano/
https://sentieridautore.it/2017/08/17/il-tibet-di-lombardia-ai-laghi-di-cancano/
Le navette saranno in funzione
dalle ore 9:00 alle ore 17:30
secondo le seguenti tratte:
– Palazzina A2A – Diga di San
Giacomo
– Strada coronamento lago di San
Giacomo
Il costo per il bus navetta è di
€ 1,00 per la singola tratta.
DESCRITTIVO: Itinerario circolare in mountain bike attorno ai laghi di Cancano e di S.Giacomo nel settore lombardo del Parco dello Stelvio. Nel suo piccolo anche il Parco nazionale dello Stelvio, come il Tibet, ha il suo ‘tetto del mondo’. Si chiama Valle di Fraele: è un largo altopiano che ricopre la porzione più settentrionale della regione; dal 1977 è incluso nel Parco nazionale dello Stelvio allo scopo di ottenere un collegamento con l’attiguo Parco nazionale svizzero dell’Engadina. Una buona scelta per far sì che la fauna selvatica si possa spostare tranquilla senza la minaccia di una doppietta. Per la sua collocazione ad alta quota e per essere lontana dalle più frequentate strade turistiche del parco, la Valle di Fraele mostra un volto del tutto particolare, quasi magico, una bellezza da giardino alpino nonostante la presenza di due laghi artificiali, forti intromissioni dell’uomo nell’ambiente. Qui, lungo i rilievi che a nord fanno da confine con la Svizzera e a sud con la Valdidentro, si estende la boscaglia di pino mugo più vasta d’Italia. La presenza umana si limita a qualche baita e alle strutture di controllo degli invasi. Il paesaggio agrario è limitato a soffici praterie dalle stupefacenti fioriture.
Utilizzando l’auto si può raggiungere l’ingresso della valle e da lì, in mountain-bike, effettuare il circuito dei laghi su una strada sterrata che presenta solo qualche breve rampa in salita e un paio di gallerie.
L’anello dei laghi – Punto di partenza e di arrivo: Cancano (m 1950). Si raggiunge da Bormio seguendo la direzione per Premadio e quindi imboccando la strada ex-militare, asfaltata, delle Scale di Fraele. Cancano si trova circa 1.5 km dopo le Torri di Fraele.
Lunghezza: 17.3 km - Dislivello: 50 metri circa – Condizioni del percorso: facile tracciato intorno ai laghi su strade sterrate
1) Lasciato il Centro Bike Cancano, si tiene la direzione di sinistra (segnavia 199) per seguire la sponda meridionale del Lago di Cancano lungo le propaggini delle Cime di Plator. La Valle di Fraele è uno splendido ambiente alpino, una conca di origine glaciale. Il paesaggio si identifica in tre fondamentali aspetti. Il primo è stato determinato dall’uomo con la realizzazione di due laghi artificiali. Gli altri sono tipici delle alte quote: il pino mugo fino a una certa altezza e, al di sopra, la prateria alpina interrotta da ghiaioni, rocce e detriti franosi. Dove fino a quasi cent’anni fa c’erano verdissime praterie ora c’è un lago il cui aspetto dipende molto dalla variabilità del livello delle acque. Nei momenti di ‘magra’, una cornice di sponde erose e di fondali limacciosi rende più malinconico il paesaggio. Al contrario lo ravviva quando le acque, dopo il disgelo, raggiungono la massima altezza, contenute dalle dighe. Il Lago di Cancano fu realizzato a partire dal 1922, mentre il lago superiore di S. Giacomo, che si vede sul fondo della valle, fra il 1940 e il 1950. 2. Al km 3.9 si avvicina la diga di questo secondo lago. Si continua sempre nella stessa direzione tenendo sulla destra le cerulee acque del lago. Più avanti però la strada si stacca dalla sponda e aggira un dosso di prati e boschi. È il luogo adatto per una sosta, complice un accogliente ristoro. A 2000 metri d’altezza, nel regno della natura alpina, le attività agricole sono sporadiche e limitate alla breve stagione estiva. Prima della costruzione degli invasi artificiali, la Valle di Fraele era una delle più ricche di prati e pascoli dove si praticavano abbondanti fienagioni e dove si tenevano, da giugno a settembre, le mandrie di bovini per l’alpeggio. Di quell’assetto oggi restano i bellissimi prati da sfalcio sul pendio a sud del Lago di S.Giacomo, il cui patchwork di toni fra il verde e il giallo, a seconda delle fasi di taglio, rivela l’accentuata suddivisione delle proprietà. Gli insediamenti si limitano a isolate baite, localmente dette ‘tèa’, molte delle quali oggi ristrutturate come case di vacanza, ma che discendono dal modello della dimora temporanea alpina con una accentuazione della struttura muraria al piano terra, usato come stalle, e del legno al piano superiore. 3. Al culmine del percorso, in capo al lago, si avvicinano i ruderi dell’unico villaggio della valle, S.Giacomo di Fraele. La chiesetta e le fondamenta di alcuni edifici sono le ultime tracce di un insediamento umano posto a quasi 2000 metri d’altezza. Nel villaggio, sommerso dalle acque del lago, vivevano boscaioli, minatori e carbonai che mantenevano contatti con la valle dell’Inn, fino a Innsbruck. I viandanti erano usi ritrovarsi nell’Osteria della Luisa, provvidenziale punto di sosta sul tracciato della già citata Strada Imperiale d’Alemagna. Il vicinissimo Passo di Fraele indica lo spartiacque alpino e il passaggio dell’antica strada. Ora tornando a ritroso verso Cancano si percorre la strada che costeggia le sponde settentrionali dei due laghi, inframmezzata dal Rifugio Val Fraele e dal Ristoro Solena (breve deviazione), altri punti di sosta. 4. Nell’ultimo tratto la strada (a rigore accessibile solo ai mezzi di servizio degli impianti) diventa poco più accidentata e penetra in due gallerie dove è utile avere con sé una torcia elettrica.
5. Passando sul colmo della diga di Cancano si fa infine ritorno al piazzale del Ristoro Monte Scale con l’unico breve tratto di salita di tutto l’itinerario.
3) La Val Zebrù
http://lombardia.stelviopark.it/wp-content/uploads/2016/06/DD_Val_Zebrù.pdf
La Val Zebrù è una lunga e suggestiva valle di circa 12km interamente compresa nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio, raggiungibile proseguendo da Bormio in direzione di Valfurva fino all’abitato di Madonna dei Monti. La Valle è tipicamente di origine glaciale ed è attraversata da un omonimo torrente che prende origine proprio dal ghiacciaio sovrastante. Caratteristica morfologica interessante della valle è dovuta alla linea di faglia dello Zebrù che corre proprio lungo il fondovalle, che rende notevole la differenza tra i due versanti della valle stessa: uno roccioso con alte pareti che cadono a picco sulla valle e l’altro più morbido e ricco di vegetazione, con molti pascoli d’alta quota che arrivano fino agli oltre 3.000 metri di altitudine. Delle vette montuose che circondano la Val Zebrù, le più alte e facilmente identificabili sono il Gran Zebrù, di 3.851m e la cima Pale Rosse con i suoi 3.446m. La valle è percorribile solo a piedi o in mountainbike ( possibilità di parcheggio per l’auto nella frazione Niblogo, all’imbocco della valle ) ed è rimasta quindi splendidamente conservata nella sua rigogliosa natura alpina. Nota: in Val Zebrù è presente una delle più vaste colonie di ungulati dell’Alta Valtellina e non sarà difficile per il visitatore imbattersi in branchi di camosci, stambecchi e cervi, oltre alle caratteristiche greggi di animali domestici al pascolo, tra antiche baite rurali in legno meta dell’alpeggio estivo.
da Bormio, percorrendo la SS 300 in direzione di S. Caterina Valfurva, si giunge a S. Nicolò Valfurva, dove delle indicazioni segnalano il Parco Nazionale dello Stelvio e il Rifugio V Alpini, giungendo dopo pochi km alla frazione di Niblogo (1600 m.). Da qui parte il sentiero n. 29 seguendo una carrareccia che si addentra nella Val Zebrù, passando prima dal Rifugio Campo (2000 m.) in circa 2 ore e quindi alla Baita del Pastore (2166 m.) nota: possibilità di usufruire di un servizio Jeep fino alla baita del Pastore, dalla frazione di Niblogo). La strada prosegue con una serie di tornanti, il paesaggio cambia passando da pascoli verdi fino alla grande morena della Val Rio Marè dove un comodo sentiero porta al rifugio V° Alpini ben visibile sul costone roccioso ai piedi del Monte Zebrù e sullo sfondo l’imponente cresta dell’Ortles.
https://www.valtellina.it/it/attivita/trekking/valfurva
http://www.paesidivaltellina.it/giroconfinale/index.htm
https://www.bormio.info/scoprire_bormio/escursione-in-val-zebru-alta-valtellina/
1) Dalla frazione di Niblogo (m.1600), a Madonna dei Monti, si imbocca la strada carrabile per la Val Zebrù fino alle Baite di Campo (m.1948). Il percorso è agevole ed è caratterizzato inizialmente da fitti boschi, interrotti poi da terrazzi verdi con caratteristiche baite. Lungo il percorso si potranno osservare colonie di stambecchi che popolano la zona come, in alto, la maestosa aquila reale e il gipeto
escursione turistica –
percorrenza h.2.oo – dislivello
m.300
Arrivati alle frazioni
(comprensorio S.Caterina
Valfurva) denominate
Madonna dei Monti e
Niblogo
(m. 1600), dove la strada aperta
al traffico termina ad un
parcheggio, ci incamminiamo su
una percorso sterrato.
Attraversiamo il letto del rio
d'Ardof e siamo ad una radura
pianeggiante, che presenta un
dosso verde coperto di mughi
detto
Piano delle Tre Croci.
Ignorata la deviazione per
Pradaccio proseguiamo
raggiungendo il
pont di Plaz,
che scavalca il torrente Zebrù,
portandoci dalla parte sinistra
a quella destra (per chi sale)
della valle. Dopo una salita
siamo
ai Piaz
(m. 1660), dove si trova anche
il
ristoro Zebrù.
A circa 1800 m. un terzo ponte
ci riporta sul lato sinistro
(per noi) della valle, dove
troviamo una nuova coppia di
tornanti, superati i quali ed
ignorata una deviazione sulla
sinistra per la Valle Ardof e
l’alpe Solaz, siamo alle baite
di
Zebrù di fuori
(m. 1828). La valle intanto si
fa più ampia e pianeggiante, ed
in breve siamo alle baite di
Chitomàs
(m. 1881). La strada propone
qualche saliscendi e si porta a
destra e poi ancora a sinistra
della valle (sempre per chi
sale), con due ponti, e
raggiunge la località
Campo
di Fuori
(m. 1947). Poco oltre, troviamo
l’azienda agrituristica
Ristoro La Baita
(m. 1980). Dopo breve tratto
siamo al
rifugio Campo
(m. 2000).
Qui si fermerà il primo
gruppo,
in località Campo di Dentro.
2 VARIANTE LUNGA -
Chi volesse proseguire (eventuale secondo gruppo) troverà un bivio e seguirà le indicazioni per la Baita del Pastore, superando sulla sinistra il grande conoide della val di Campo, colonizzato da cespugli di rododendro e mugo, e sulla destra il rio del Rabbioso (Rinec). La strada attraversa adesso l'ultimo ponte sul torrente Zebrù, che corre ora alla nostra destra e porta, dopo una lunga salita, alla Baita del Pastore (m. 2168, ad 8 km da Niblogo). Una sorta di tratturo che inizia ad inerpicarsi su un largo dosso erboso, con tornanti regolari e pendenza piuttosto severa. La pista, attraversata una valletta, riprende a salire con inesorabile severità ed al termine di una rampa micidiale, volge a sinistra e raggiunge in breve la cima di un ampio dosso, lasciando il posto ad un sentiero che sale con qualche serpentina sul corpo della morena. Arrivati ad un grande masso, poco sotto il grande sperone su cui è posto il rifugio, ad una quota di circa 2750 metri, troviamo l’ultimo cartello, che segnala anche un importante bivio: alla nostra destra parte un sentiero che sale ai passi di Val Zebrù, ma seguiremo invece il sentiero che volge a sinistra, raggiunge il piede dello sperone, e piegando poi a destra, tagliando un nevaietto. Poco sopra si tornerà a tagliarlo da destra a sinistra, poi ancora a destra ed infine a sinistra, prima dell’ultimo traverso pianeggiante che ci permetterà di approdare, dopo aver attraversato le acque inquiete di un ramo del Rin Marè, la spianata del rifugio V Alpini, a 2877 metri di quota. Occhio però che per arrivare qui da Neblogo saranno circa Km.12 e m.1300 di dislivello!
PS: a Niblogo (m. 1600), dove la strada aperta al traffico termina ad un parcheggio presso un edificio adibito a punto di informazioni del Parco Nazionale dello Stelvio. Teniamo presente che, date le ridotte dimensioni del parcheggio, nei periodi di punta dopo una certa ora questo si riempie, per cui siamo costretti a scendere sperando in miglior fortuna a Plazzola. Inoltre a Niblogo è possibile trovare veicoli autorizzati a fare la spola negli 8 km che separano il parcheggio dal Baitìn del Pastore. I tempi di attesa possono, però, essere prolungati, perché il servizio viene prestato quando i mezzi sono pieni (5 persone).
4) la val viola
La vallata è dominata dalle montagne che fanno parte del gruppo della Cima Piazzi e della Corna di Campo, svettando infatti su di essa, in un ambiente naturale incontaminato, la Cima Piazzi (3.439 metri), la Cima Viola (3.374 metri) e la Cima Dosdé (3.280 metri).
Tutta la valle è incastonata in una serie di cime, tutte oltre i tremila metri, che creano una cornice naturale che offre dei panorami mozzafiato rendendola veramente interessante soprattutto dal punto di vista paesaggistico.
Arnoga - Rifugio Viola
Dati: Dislivello:440 m - Durata: 2h - Impegno Fisico:Basso - Difficoltà :E
Descrizione:
La partenza di questa bellissima escursione è posta ad Arnoga,in prossimità del tornante lungo la statale che sale verso il passo Foscagno in prossimità di alcune strutture albeghiere qui poste,svolteremo a sinistra e poi terremo la sinistra prendendo una stradina in discesa che ci conduce sino ad un ampio parcheggio
Da questo punto una volta posteggiata la nostra autovettura possiamo avere due alternative: o salire sino al rifugio percorrendo il percorso basso, più lungo, oppure risalire per pochi metri lungo un piccolo sentiero sino a reincontrare la strada asfaltata che si addentra nella valle.
Per chi non volesse partire da questo punto lungo la valle vi sono molteplici zone dove parcheggiare tuttavia nei periodi estivi Luglio-Agosto-Settembre,appena dopo la svolta incontreremo subito delle guardie forestali che ci femeranno e chiederanno 3 € per poterci addentrare con le nostre vetture nella valle.
Salendo a piedi invece non dovremo pagare alcun tipo di tassa,partendo dal nostro parcheggio affronteremo lungo la stradina asfaltata i primi metri con scarsa pendenza primadi affrontare un tratto impegnativo con pendenze elevati e successivamenteun altrettanto breve ma impegnativa discesa, tuttavia all'inizio della salitella troveremo sulla sinistra una piccola traccia che ci permetterà di evitare questa breve salita sino ad reincontrarci con la carrareccia nella zona della prima area paracheggio all'interno della valle.
Da questa prima area di parcheggio saliremo sempre lungo la stradina con pendenze sempre lievi o a volte pressochè nulle, ammirrando di già la bellissima vallata.
Continueremo su questa strada poco trafficata,oltrepassando piccoli torrenti, ponticelli, sempre immersi tra i boschi di larici e abeti sino all'ultimo parcheggio posto in localita Altumeira a quota 2100m.s.l.m, dove la strada asfaltata termina e da dove ora in avanti non è più concesso il transito alle autovetture. Continueremo su questa strada poco trafficata,oltrepassando piccoli torrenti,ponticelli,sempre immersi tra i boschi di larici e abeti sino all'ultimo parcheggio posto in localita Altumeira a quota 2100m.s.l.m,dove la strada asfaltata termina e da dove ora in avanti non è più concesso il transito alle autovetture. Le pendenze rimangono sempre lievi sino al bivio verso la capanna Dosdè,passo Dosdè,da ora per circa 500 m le pendenze diventano leggermente più elevate e percorreremo due piccoli colli. Al termine di questi due colli le pendenze tornano ad essere quasi praticamente nulle,e siamo già in grado di vedere il rifugio in lontananza e i due laghi posti in prossimità. I cartelli ci indicano un tempo di 30' per raggiungerlo,ma anche se ancora abbastanza lontano in circa 10' e camminando tranquillamente lo riusciremo a raggiungere.
In prossimità di una deviazione verso gli alpeggi della val viola il nostro sentiero si divide: una piccola traccia va in discesa mentre il sentiero principale continua in piano e prendere l'uno o l'altro è indifferente,tuttavia consiglio di prendere il primo in discesa. Affronteremo un piccolo ponticello in legno lungo i molteplici fiumi/ruscelli, per arrivare finalmente al rifugio
Nonostante il percorso presenti un dislivello quasi nullo, potrebbe risultare ostico per via della notevole lunghezza, soprattutto la discesa potrebbe risultare estremamente stancante.
altro dettaglio del percorso, tratto da: http://www.bormio3.it/val-viola/
La Val Viola nei pressi di Bormio
Informazioni sulla Val Viola a 20 minuti da Bormio:
Caratteristiche della Valle
La Val Viola, itinerario di grande bellezza paesaggistica, è raggiungibile in auto presso la località Arnoga: l’imbocco si trova lungo la strada statale n. 301 che collega Bormio a Livigno.
Di qui comincia la vallata dominata dalle montagne che fanno parte del gruppo della Cima Piazzi e della Corna di Campo: svettano infatti su di essa, in un ambiente naturale incontaminato, la Cima Piazzi (3.439 metri), la Cima Viola (3.374 metri) e la Cima Dosdé (3.280 metri).
Tutta la valle è infatti incastonata in una serie di cime, tutte oltre i tremila metri, che creano una cornice naturale che offre dei panorami mozzafiato rendendola veramente interessante soprattutto dal punto di vista paesaggistico.
E’ possibile compiere l’itinerario che attraversa la valle compierlo anche con la mountain bike.
Con tutta probabilità la Val Viola deve il suo nome ad un errore dei cartografi che, nell’ottocento, scambiarono il nome “Albiola” (derivante dal termine latino albus = bianco) con “Viola”che rimase.
Il versante bormino della Val Viola termina, dopo circa 11 km, con l’omonimo Passo il quale permette di dominare il panorama della Val Viola Poschiavina, in territorio elvetico.
Confluiscono in essa numerose altre vallate che permettono una serie infinita di possibili escursioni: oltre al menzionato Passo di Val Viola che consente di raggiungere la Val Viola Poschiavina (Val di Campo), lungo il suo percorso si trovano anche i sentieri che conducono al passo della Vallaccia che la collega alla Valle del Foscagno, al passo di Dosdé che sbocca nella Val d'Avedo e al passo di Verva che immette nella omonima valle collegata con la Val Grosina.
Il percorso è costellato di gruppi di tipiche baite montane interamente realizzate in pietra e legno: gli insediamenti più grandi e meglio conservati sono in località Dosso, Premoglio, Campo, Prato, Paluetta, Caprena, Stagimel, Caricc e Altumeira ove è ancora possibile vedere le abitazioni che venivano utilizzate dai contadini per trascorrere l’estate al pascolo con il bestiame e dedicarsi alla coltivazione del grano e soprattutto della segale, molto diffusa in questa zona.
La vegetazione della Val Viola è quella caratteristica degli ambienti montani d’alta quota: la flora è composta da colorati rododendri, profumate genziane, anemoni e numerosi fiori alpini.
Per quanto riguarda la fauna, oltre agli ungulati, la zona è popolata in maniera massiccia dalle marmotte, i cui sonori fischi echeggiano in tutta la valle.
La morfologia della Val Viola, orientata a Sud-Ovest, è quella tipica delle vallate alpine oggetto di erosione glaciale: è modellata da grandi ripiani a cui si alternano piccoli salti che immettono nuovamente in conche superiori molto ampie. L’origine della valle, dovuta al lento e inesorabile lavoro dei grandi ghiacciai che vi erano un tempo, è testimoniata anche dalle stratificazioni che si trovano sui suoi costoni e dalla conformazione e forma delle rocce che vi si trovano.
All’inizio della valle, all’incirca all’altezza in cui in essa confluisce la Val Verva, si origina il torrente omonimo che attraversa interamente la Valdidentro per poi immettersi nell’Adda.
Percorso a piedi o in mountain bike
Partendo da Arnoga ci si inoltra quasi subito in un fitto bosco d’abeti che accompagna per i primi due chilometri quasi interamente pianeggianti.
Si incontrano quindi lungo il cammino le baite di Premoglia, e, successivamente le baite di Campo (1938 m.), poste in una ampia radura.
Proseguendo dritti lungo la strada che corre lungo i prati a mezza costa, superato un piccolo torrente in località Stagimel, si rientra nuovamente nel bosco. Presso le baite di Palueta, sulla sinistra, parte il percorso che porta alla Val Verva, mentre, poco innanzi, sulla destra, parte il sentiero che conduce all’Alpe Funera e al Passo della Vallaccia.
IIgnorate queste deviazioni, si prosegue ancora a diritto e, superato l’ampio parcheggio si scavalca un piccolo ponte che permette di oltrepassare un torrente.
Il panorama da qui in poi è molto più ampio in quanto la vallata, molto stretta in principio, si allarga maggiormente. Anche il paesaggio muta: la vegetazione si fa sempre più rada lasciando il posto alla tipica vegetazione dei pascoli alpini.
Continuando lungo la strada, dopo circa poco più di 5 km, all’altezza delle baite di Altumeria (2116 m.), località ove vi è anche un parcheggio, si incrocia la deviazione che permette di raggiungere la Val Cantone di Dosdé.
Proseguendo oltre, tra le pareti del Corno di Dosdè e le dorsali del Pizzo Bianco, si giunge quindi al rifugio Viola (2314 m.), dopo aver oltrepassato dall’alto un caratteristico laghetto alpino.
Il rifugio, in tempo di guerra adibito a caserma di confine, si trova sulle sponde di un altro piccolo laghetto nel quale si rispecchia.
Poco sopra il rifugio si trova il Passo della Val Viola che segna il confine con la Svizzera e mette in comunicazione con la Val Poschiavina.
Varianti di percorso.
Oltre al percorso sopra descritto che permette di attraversare tutta la Val Viola passando per le baite dell'Alpe Campo e di Altumeira e raggiungere il confine con la Svizzera, ci sono molti altri sentieri e vecchie mulattiere su entrambi i versanti della valle: come accennato infatti la Val Viola offre una serie di diramazioni, costituite da mulattiere e sentieri che si inerpicano sui suoi fianchi, che permettono di compiere numerosi altri itinerari.
Uno di questi è quello che passa per la Malga Funera, la Baita del Pastore e, attraversando il Passo della Vallaccia, permette di raggiungere Livigno.
Altro interessante itinerario si snoda nella Val Cantone di Dosdé, incastonata tra il Corno di Dosdé e la Cima Viola, al cui culmine si trova il Passo Dosdé attraverso il quale si può scendere nella Val d'Avedo. Altra possibilità ancora è quella di percorrere la Val Verva, costellata di numerosi piccoli laghetti alpini.
testo da: a: http://www.bormio3.it/val-viola/
5) La valle dei Forni
i percorsi si snodano lungo la Val Cedéc e la Valle dei Forni, poste al centro del gruppo Ortles – Cevedale, valli plasmate dall’azione di imponenti ghiacciai e che offrono all’escursionista di ogni livello numerosi spunti di osservazione floristici, faunistici, paesaggistici e soprattutto geomorfologici. In particolare, seguiremo il sentiero glaciologico basso per arrivare in h.1,30 dal rifugio Forni (m.2.176) al rifugio Branca (m.2.493), avanposto suggestivo sul panorama mozzafiato del ghiacciaio dei Forni, con l'attraversamento dei torrenti in disgelo lungo il torrente Frodolfo. La discesa può essere effettuata tramite una carrareccia sterrata (il sentiero della marmotta) che in h.0,40 ci riporta al punto di partenza. Nota: chi vuole camminare meno può fare il sentiero glaciologico al ritorno, in discesa, e chi invece volesse fare di più non ha che l'imbarazzo della scelta, una volta arrivati ai Forni..
In auto:
da S. Caterina Valfurva si segue
la ripida strada asfaltata (a
pedaggio) che porta al Rifugio
dei Forni a quota 2176 m ed a un
ampio parcheggio. La partenza
del percorso è dal parcheggio
inferiore dei Forni: una volta
aver parcheggiato non dovremo
salire sino al rifugio dei Forni
ma proseguire sino alla fine del
parcheggio da dove inizia un
breve sentiero verso una piccola
diga posta in prossimità del
parcheggio. Dopo circa 100m di
piano svolteremo a sinistra
seguendo un piccolo sentiero
che, in circa 2' di salita, si
ricongiungerà con la strada
sterrata che sale dai rifugi dei
Forni sino al Branca.
http://lombardia.stelviopark.it/wp-content/uploads/2016/06/DD_La_Valle_dei_Forni.pdf
-
sentiero glaciologico basso: Tempo di percorrenza/km: ore 2 / km 5 - Dislivello: m. 312. Difficoltà: E . Il sentiero basso può essere considerato, rispetto al percorso glaciologico alto (più difficoltoso e di lunga percorrenza) una variante alla portata dell’escursionista anche meno esperto. Permette però di osservare da vicino la maestosità e la particolarità del più grande ghiacciaio “vallivo confluente” delle Alpi. Dal Rifugio dei Forni, seguendo la stradella che porta al Branca, si possono osservare nella valle i segni evidenti del modellamento dovuto al ghiaccio – morene, rocce montonate e tutti gli elementi geomorfologici di questo ambiente – accuratamente descritti da piccoli cartelli informativi. Superato il Rifugio Branca il sentiero scende verso il laghetto sottostante e ci si trova davanti il fronte del ghiacciaio. Attraversando l’ampio pianoro fino a pochi decenni fa coperto di ghiaccio si raggiunge di nuovo il Rifugio Forni scendendo sul versante sinistro orografico o, in alternativa, al bivio ci si riporta sulla carrareccia imboccata alla partenza.
-
Il sentiero della marmotta: Percorso: Forni – Rifugio Branca - Tempo di percorrenza/km: ore 1.10’/ km 2,6 Dislivello: 312 m Difficoltà: T . Dal Rifugio dei Forni si imbocca la comoda stradella che percorre la valle con pendenza pressochè regolare ad eccezione dell’ultimo ripido breve tratto. Lungo tutto il percorso è facile l’incontro con le marmotte che popolano numerose la valle ed è possibile ammirare la tipica flora delle praterie alpine. In breve si raggiunge il Rifugio Branca da dove godiamo la vista ravvicinata del fronte del ghiacciaio
Nota: i percorsi possono essere effettuati al contrario, chiudendo un anello.
Dettaglio:
Realizzato in parte nel 1995 per
ricordare il centenario della
fondazione del Comitato
Glaciologico Italiano, il
sentiero si snoda nella Valle
dei Forni, in Valfurva arrivando
al cospetto della vasta fronte
del ghiacciaio.
Qui un ponte tibetano
posizionato sul torrente
Frodolfo farà vivere
un’attraversata emozionante
sospesi sull’acqua impetuosa che
scaturisce dal ghiacciaio.
Alla scoperta del ghiacciaio
omonimo e alla comprensione
degli eventi naturali che hanno
originato la morfologia della
valle. Il percorso permette
inoltre di osservare resti del
primo conflitto mondiale
(1915-1918).
Itinerario:
dalla località i Forni al primo
posteggio sulla destra si scende
brevemente al torrente e si
attraversa il ponte seguendo le
indicazioni “sentiero
glaciologico” e subito dopo si
sale una caratteristica scala in
pietra. Si segue il sentiero che
sale gradualmente a mezzacosta
fino ad arrivare in una zona con
evidenti resti di postazioni
militari.Da qui il sentiero
prosegue a saliscendi fino ad
arrivare ad un ponticello. Si
prosegue sempre a mezzacosta
fino a che il sentiero passa in
una zona particolare con rocce
levigate. Poco dopo il sentiero
scende sul fondovalle andando
così ad attraversare i due
caratteristici ponti tibetani.
Adesso il sentiero scende
gradualmente sulla destra
idrografica arrivando al piccolo
laghetto di Ròsole ed in breve
si arriva al rifugio Branca per
una meritata pausa, si
rientrando ai Forni seguendo la
carrareccia.
Dislivello: 312 m – h. 2.oo al
rifugio Branca – diff.E, 40 min
il rientro ai Forni per la
carrareccia.
Domenica 15 settembre: La galleria del Granduca in val d'Elsa
Domenica 29 settembre: Paesaggio, arte e storia a Fiesole
Domenica 6 ottobre 2019: Castagnata con la Pro Loco Quercianella
Domenica 13 ottobre: ll parco di Poggio Neri
Domenica 27 ottobre - Pellegrinaggi medioevali nel territorio livornese xx Per motivi tecnici viene posticipato al giorno 10.11
Domenica 10 novembre: I percorsi verdi di Castellina M.ma xx Per motivi tecnici viene anticipata al giorno 03.11
Domenica 17 novembre (POMERIGGIO): prospettive e futuro dell'associazione
Domenica 24 novembre - I mulini ad acqua del rio Sanguigna
Venerdi 13 dicembre: Convivium
Domenica 15 dicembre: Trekking urbano a Pistoia
Domenica 12 gennaio: itinerari di CAMAIORE ANTIQUA xx Non effettuata per maltempo nel precedente programma - RIPROPOSIZIONE
Domenica 26 gennaio: Gli arenili tra Donoratico e San Vincenzo xx Non effettuata per maltempo nel precedente programma -
RIPROPOSIZIONE
========================================================================================================




Domenica 15 settembre: La galleria del Granduca in val d'Elsa. Rimandata per maltempo, viene proposta questa escursione, di grande interesse storico e religioso, che ha inizio da Fungaia (siamo in Val d’Elsa) e, con dislivelli di poco conto, transita da S. Colomba e S. Leonardo al Lago, importante eremo medievale. Da qui ci porteremo all'ingresso della famosa Galleria del Granduca, importante scolmatore sotterraneo fatto costruire dal Granduca Leopoldo (a.1.766) per la bonifica del Pian del Lago, ampio tratto di palude che rendeva molto insalubre la zona. L’imponente e grandiosa opera idraulica ha una lunghezza di m.2.173 ed ha come caratteristica principale una “volta a botte” in mattoni e una pavimentazione in pietra serena, con pendenza del 2 per mille. Portare una torcia perché indispensabile nella galleria.
Info: Laura Malevolti 338 9083212
Itinerario: sentiero c.a.i n16 in zona val d'Elsa a Monteriggioni - lunghezza km. 8(12 - percorrenza ca 3 ore
Descrittivo - Il sentiero n° 116 si stacca dal sentiero n° 113 (che da Caldana conduce a S. Colomba) presso una radura con quattro grandi querce, poco sotto il podere Pastine di Sotto. Si segue la carrareccia che sale in breve alla suddetta casa colonica, aggirandola sulla destra. Dopo l’edificio si continua per una stradina di bosco dal fondo assai disconnesso, che procede in lieve salita. Più in alto questa s’immette in una strada bianca che va seguita verso destra, in direzione di Bellaria. Dopo l’ultima casa di Pastine di Sopra (m 350), in prossimità di un bel cipresso solitario emergente da un gruppo di lecci si devia a sinistra, imboccando una mulattiera: questa scende per il lecceto, costeggiata all’inizio da un vecchio muro a secco. Oltrepassata un’abitazione (destra), si giunge all’Eremo di S. Leonardo al Lago (m 292), che va aggirato sulla sinistra, raggiungendo così la parte posteriore del complesso. Qui prende avvio a destra il sentiero n° 117 che porta alla Strada del Ferratore. Il sentiero n° 116 prosegue invece diritto, in direzione Nord-Est, ed esce ben presto sulla strada bianca presso la località Osteriaccia. Qui si deve imboccare un sentiero che ha inizio sull’altro lato della strada, poco a destra dell’edificio. Si passa subito a monte dell’Inghiottitoio del Mulinaccio e, attraversato il bosco di cerri, si esce infine nei campi del Pian del Lago, a breve distanza dall’obelisco denominato “Guglia”, fatto erigere dal Granduca Leopoldo di Lorena. Dietro la stele ha inizio la galleria di bonifica del Pian del Lago, detta “Galleria del Granduca”. Si scende dunque nel canale e, muniti di torcia elettrica e stivali di gomma, si va a percorrere i 2173 metri di galleria (attenzione: dopo periodi molto piovosi la traversata non è effettuabile). All’uscita del tunnel si guada il Torrente Rigo e si sbuca sulla Strada Provinciale del Ferratore (Volte Basse – Pian del Lago). Il tempo di percorrenza di questo itinerario è leggermente più alto della media, dato che per l’attraversamento del Canale del Granduca occorre un’ora abbondante. Volendo tornare a piedi a S. Leonardo al Lago, è consigliabile seguire il sentiero n° 117, che inizia dalla Strada del Ferratore, a breve distanza dal punto in cui termina il sentiero n° 116 (in sostanza, usciti sulla strada bisogna dirigersi verso destra – Nord).
http://www.terresiena.it/it/itinerari-trekking/item/sentiero-del-cai-n-116
Domenica 29 settembre: Paesaggio, arte e storia a Fiesole. Sorta su un colle dominante, la conca fiorentina offre al visitatore sentieri nel verde, bellissimi punti panoramici e la possibilità di ammirare strutture architettoniche di notevole interesse. Questa antica cittadina, fondata dagli etruschi, conserva infatti importanti resti di tale periodo, monumenti, sia di quello romano sia medioevale, come anche chiese, ville e giardini del Rinascimento. La passeggiata proposta avrà caratteristiche sia urbane, nell’antico impianto centrale, che extra urbane, nei dintorni collinari e sarà di facile percorribilità, per un interessante approccio a una zona ricca di stimoli culturali e ambientali che certamente non mancheranno di far nascere in noi il desiderio di ritornare in questo luogo incantevole. Nel pomeriggio saranno proposti due percorsi distinti: uno per il monte Ceceri – dove Leonardo sperimentava le macchine per il volo- e l’altro per la zona archeologica. Info: Luciano Suggi - 0586 406468 (ore serali) o 339 8700530
Dettagli e particolari:
Sorta su un colle dominante, la conca fiorentina offre al visitatore sentieri nel verde, bellissimi punti panoramici e la possibilità di ammirare strutture architettoniche di notevole interesse. Questa antica cittadina, fondata dagli etruschi, conserva infatti importanti resti di tale periodo, monumenti, sia di quello romano che medioevale, come anche chiese, ville e giardini del Rinascimento. La passeggiata proposta avrà caratteristiche sia urbane, nell’antico impianto centrale, che extra urbane, nei dintorni collinari e sarà di facile percorribilità, per un approccio ad una zona ricca di stimoli culturali e ambientali.che certamente farà nascere in noi il desiderio di ritornarci.
la mattina seguiremo il 1°itinerario poi, nel pomeriggio, ci divideremo in due gruppi di cui uno andrà al monte Ceceri e l'altro visiterà il parco archeologico.
intorno a Fiesole, anello breve
1° itinerario ( km 1,5 circa) facile
Piazza Mino_Via S.
Francesco _ Piazzale del
convento di S. Francesco.
Sentiero all’interno del
giardino pubblico. Via del
Cimitero. Via Dupré. Via
delle Mura Etrusche. Piazza
del Mercato. Via Marini.
Piazza Mino.
Da visitare:
Duomo. Costruzione
romanica del secolo XI,
ampliata nel ‘200 e nel
‘300. Ha la facciata e i
fianchi tutti in pietra, di
bella semplicità.
Caratteristico il campanile
del 1213.
Chiesa e convento di san
Francesco. Vi si arriva
percorrendo una strada in
salita che offre un’ampia
veduta su Firenze. Costruita
in stile gotico, ospita al
suo interno, importanti
opere pittoriche del
quattrocento e del
cinquecento toscano. A lato,
piccolo chiostro del 400 e
museo etnografico che
conserva, oltre a pezzi
archeologici etrusco-romani,
anche oggetti raccolti dai
missionari francescani in
Egitto e nell’antica Cina.
MUSEO MISSIONARIO ETNOGRAFICO FRANCESCANO
La nascita del Museo delle Missioni si deve a Padre Ambrogio Ridolfi (1875-1966) che nel 1920 fu destinato al Convento di San Francesco di Fiesole. Egli portò con sé alcuni “cimeli cinesi” inviati verso la fine dell’800 al convento di Santa Margherita a Cortona (Ar) da Padre Agostino Galassi missionario in Cina. Padre Ambrogio, con il benestare dei superiori, scrisse ai confratelli della Provincia Toscana allora missionari di Egitto e nel vicariato di Lao-ho-kow in Cina, perché cooperassero alla realizzazione di un progetto più ampio, allo scopo di sensibilizzare i giovani frati e i fedeli alla conoscenza di terre lontane e alla promozione umana e sociale di quelle popolazioni.
La collezione egizia deve la sua realizzazione alla Missione di Egitto e a Padre Sebastiano Bastiani (1891-1974), il quale aiutato dall’egittologo Ernesto Schiaparelli (1856-1928) fece da tramite per rifornire il Museo di oggetti di inestimabile valore, oltre che rari.
La sezione cinese ebbe come suo principale autore Padre Sebastiano Ceccherelli (1880-1967), missionario per venticinque anni in Cina, e Padre Norberto Pieraccini (1911-1993).
Via San Francesco, 13
Info: ph. 055.59175 | www.fratifiesole.it | fratifiesole@gmail.com
A
sinistra per via Dupré,
costeggiando l’area
archeologica che racchiude
in sé i principali monumenti
dell’età antica: il teatro
romano che conserva la cavea
con tre ordini di seggi e 19
gradini, le rovine delle
terme e quelle di un tempio
etrusco-romano.
Nell’adiacente museo
archeologico sono raccolti
reperti etruschi, romani e
longobardi rinvenute negli
scavi e ricche collezioni
antiquarie tra cui le
ceramiche della collezione
Costantini dal mondo greco
ed etrusco.
A destra per via delle
Mura Etrusche.
Ai primi agglomerati di
capanne disposti sulle due
alture principali, fa
seguito un unico
insediamento ordinato e
caratterizzato dalla
presenza di edifici
monumentali e, almeno a
partire dal IV sec. a. C.,
da una possente cinta
muraria in blocchi di
arenaria di dimensioni
ciclopiche.
Ancora a destra per Piazza del Mercato e per
via Marini, ritornando
così in
piazza Mino.
Area Archeologica: Gli scavi nell'area archeologica di Fiesole comprendono un teatro romano, le terme, un tempio etrusco-romano e un museo archeologico. Si trovano tra via Duprè, via delle Mura Etrusche e via Bandini. Contiene reperti dal III secolo a.C. al II secolo d.C.
Nel 1809, il barone prussiano Friedman Schellersheim fu il primo a far eseguire degli scavi in un podere, detto Buche delle Fate, dove trovò ruderi di epoca romana. Egli fece ricerche fino al 1814, poi i lavori furono sospesi e ripresi successivamente nel 1870. Il Comune nel 1873 acquistò il terreno dove gli scavi continuavano e nel 1878 venne istituito nel palazzo Pretorio un primo museo col materiale venuto alla luce. Il direttore degli scavi nominato dal comune fu il professor Demostene Macciò, che sostenne l'incarico fino al 1910. Nella spianata degli scavi si trovava l'antico foro di Fesulae, nel convalle tra i colli di San Francesco e di Sant'Apollinare.
Museo archeologico di Fiesole : Il museo fu costruito dall'architetto Ezio Cerpi fra il 1912 e il 1914 a forma di tempietto romano, di stile ionico. In esso si trova un frammento della lupa capitolina in bronzo del I secolo a.C., vere di pozzi, stele ed urne cinerarie etrusche (su una di esse è raffigurata a bassorilievo il tema della Cinghiale di Meleagro), buccheri, raccolta di lucerne etrusche in terracotta e in bronzo, amuleti, gioielli, pugnali, statuette, raccolte di monete d'argento e di bronzo del periodo preromano e romano, medievali e moderne, piante della città di Fiesole ed altro materiale archeologico.
Teatro romano di Fiesole : Il Teatro è costruito secondo i modelli greci (cioè sfrutta la naturale pendenza del terreno, scavato per realizzare i gradini della cavea) e venne costruito al tempo di Silla ed abbellito da Claudio e da Settimio Severo. La cavea ha un diametro di 34 m. La gradinata superiore è distrutta, mentre quelle inferiori sono ben conservate. Nel teatro, in basso, vi erano tre ordini di posti distinti e diciannove gradinate divise da cinque scalette (oggi solo dieci); da una parte le gradinate sono scavate nel masso e da un'altra parte, dove si trova anche il pozzo, riposano su volte sostenute da muri concentrici. In cima alla gradinata esistevano le logge dette tribunalia, per i personaggi più eminenti. Il teatro poteva contenere circa tremila persone.
Il frontescena era costituito da un loggiato a due piani andato distrutto, del quale restano solo le fondazioni che mostrano le tre porte riservate agli attori. Due ali coperte (le versurae) inquadravano la scena lateralmente e portavano ad un portico verso oriente dietro la scena (del quale restano nove pilastri) ed ai magazzini verso occidente, usati per i costumi e il materiale scenico. L'orchestra era in origine pavimentata con mosaici policromi ed era conclusa da un proscenio. Alle gradinate, all'orchestra ed alla scena si accedeva dai propilei, che avevano ripiani per i palchi ed erano adorni di colonne scanalate. Il teatro viene tuttora usato nel periodo estivo per le rappresentazioni di opera lirica dell'Estate fiesolana.
Terme : Dietro al teatro vi sono i ruderi delle terme, costruite ai tempi di Silla (I secolo a.C.), restaurate ed ingrandite al tempo di Adriano. Furono "scoperte" nel 1891, quando finalmente si poté dare una funzione alle tre arcate da sempre visibili: esse costituivano la terrazza delle terme verso valle.
Le terme si trovano lungo le mura e sono costituite dai tre classici ambienti del calidarium, tepidarium e frigidarium, più altre vasche e stanze. Una piscina rettangolare e due vasche (una delle quali a immersione) servivano per i bagni pubblici e sul loro fondo furono trovate molte anfore, usate per depurare l'acqua, raccogliendo le impurità che andavano a fondo.
Si trovano i resti di locali per il riscaldamento dell'acqua e la produzione di vapore che, a mezzo di condutture di piombo o di terracotta, si distribuiva nei vari locali. Nel calidarium, caratterizzato dal pavimento in cocciopesto, veniva mandata l'acqua bollente, nel tepidarium (costituito da tre vasche) era raccolta l'acqua tiepida e infine nel frigidarium veniva immessa l'acqua fredda; il frigidarium è suddiviso da una struttura ad archi (ricostruita), una delle quali ha una forma semicircolare e si trova accanto alle latrine. Forse esisteva anche un criptoportico che separava le vasche. Alcune delle strutture sono state ricostruite in seguito agli scavi.
Tempio : Il tempio etrusco-romano venne costruito tra la seconda metà del IV secolo a.C. e il II secolo a.C., sebbene l'area fosse in uso per rituali sacri almeno dal VII secolo a.C., e fu scavato all'inizio del Novecento. Molto probabilmente era l'antico Capitolium fiesolano.
La cella è la parte più antica ed è divisa in tre parti: ciò fa supporre che il tempio fosse dedicato a Giove, Giunone e a Minerva (quest'ultima attribuzione quasi certa come suggerirebbe un bronzetto ellenistico raffigurante un gufo trovato nei paraggi e ora nel museo). Davanti al tempio c'è una piccola ara in pietra arenaria decorata (IV secolo a.C.-III secolo a.C.). In epoca repubblicana il tempio venne ricostruito, innalzato e ingrandito sia sulle ali che sulla parte frontale, in parte riutilizzando le murature dell'edificio precedente. La gradinata, ben conservata, ha sette scalini e giunge allo stilobate su cui sorgevano le colonne del portico, sormontato dal frontone del tempio. La parte più lunga dello stilobate fa supporre che il porticato allacciasse il tempio al Collegium.
A sinistra si vedono le basi di tre colonne rimaste del porticato che circondava la cella. Fra questi ruderi sono state ritrovate monete di bronzo e d'argento (III secolo a.C.-X secolo). In questo luogo inoltre sono stati ritrovati i resti di un sepolcreto barbarico di epoca longobarda (VII-VIII secolo), costruito su un'area della cella e i ruderi di un tempio cristiano, sorto sui resti di quello pagano verso il III secolo.
Altro da visitare:
IL DUOMO
Storia: L'origine dell'edificio risale al 1028, quando il vescovo Jacopo il Bavaro decise di trasferire la cattedrale, che era fino ad allora presso la Badia, entro le mura della città, dedicandola a San Romolo, evangelizzatore di Fiesole. ESTERNO: L'aspetto attuale è quello di una basilica romanica con lo schema a tre navate su colonne di pietra con capitelli figurati e fitomorfi, presbiterio rialzato sulla cripta e tetto a capriate. Esso è frutto di trasformazioni avvenute nel corso del Due-Trecento e di un restauro, condotto negli anni 1878-1883, che ha ricostruito la facciata e ripristinato le forme originarie, cancellando radicalmente le aggiunte posteriori. INTERNO: L'interno è maestoso e severo nella sua semplicità. La navata centrale è adorna soltanto del paliotto dell'altare a commesso marmoreo (1273) e di due affreschi, San Benedetto (1420 circa) e San Sebastiano di Pietro Perugino (inizio Cinquecento), mentre alla parete sinistra è collocata la cattedra lignea di Sant'Andrea Corsini, realizzata nel 1371 da Pietro di Lando.
IL PRESBITERIO: Nel presbiterio si trovano gli affreschi con Storie di San Romolo dipinti nel catino absidale alla fine del Cinquecento dal fiesolano Nicodemo Ferrucci, e all'altar maggiore il trittico tardogotico, commissionato nel 1450, di Bicci di Lorenzo, fiancheggiato agli altari laterali da trittici in stile neogotico dipinti nel 1886.
Sul lato destro del presbiterio si aprono due cappelle.
Cappella Salutati : La cappella sepolcrale del vescovo Leonardo Salutati è il gioiello rinascimentale del Duomo e ospita il monumento funebre del vescovo in forma di sarcofago in marmo finemente scolpito da Mino da Fiesole e lumeggiato d'oro, che reca al di sotto, sopra una mensola, un busto-ritratto particolarmente realistico. Alla parete di fronte è situato un dossale marmoreo con la Madonna in adorazione del Bambino tra San Leonardo e San Remigio, coronato da una bellissima testa del Salvatore. Entrambe le opere sono firmate Opus Mini. In armonia con questi rilievi fu eseguita contemporaneamente da Cosimo Rosselli la decorazione pittorica condotta a tappeto su pareti e soffitto con le raffigurazioni degli Evangelisti e dei Santi Leonardo e Giovanni Battista.
La cappella del Santissimo Sacramento ha una decorazione tipicamente ottocentesca e accoglie le copie delle due facce di un dipinto di scuola del Ghirlandaio con le Storie di San Romolo e San Romolo fra i suoi compagni, conservato nella cripta.
Cappella dei Canonici : Dirigendosi sull'altro lato si lascia a sinistra il monumento al vescovo Corsani, promotore del restauro ottocentesco del Duomo, e si giunge davanti alla cappella dei Canonici, antica sagrestia trecentesca affrescata alla fine del secolo o all'inizio del successivo, che accoglie il dossale marmoreo di Andrea Ferrucci eseguito tra il 1492 e il 1494. Limitrofa a questa è la nuova sagrestia, costruita nel Settecento, in cui sono conservati arredi liturgici di notevole importanza come la mitra del vescovo Salutati e il busto reliquiario di San Romolo del 1584.
Si può ammirare nella controfacciata la gigantesca statua di San Romolo in cattedra di Giovanni della Robbia (1521).
La cripta Scesa la scalinata, si accede alla cripta, sorretta da esili colonnine con capitelli dell'XI secolo forse riutilizzati dalla prima costruzione, con medaglioni tardogotici e neogotici dipinti sulla volta, lasciando sulla sinistra la tavola originale con le Storie e il martirio di San Romolo di scuola ghirlandaiesca. Nella cappella sepolcrale dei vescovi si trova una tavola dugentesca, opera dell'anonimo pittore convenzionalmente chiamato Maestro del Bigallo, con la Madonna in trono col Bambino, l'icona più antica del Duomo, realizzata probabilmente entro il 1230 (1215 - 1220) in concomitanza con il primo ampliamento della chiesa e la costruzione della torre campanaria. Fino al 1790 la tavola, detta la Madonna del Soccorso, si trovava entro un altare sul lato destro della cripta, demolito per far posto al fonte battesimale in granito di Francesco Ferrucci del Tadda.
Una cancellata in ferro battuto, datata 1349 ed eseguita dai senesi Petruccio di Betto e dal figlio Francesco, chiude la parte absidale della cripta, dove sono collocate le reliquie di San Romolo; la cripta fu rinnovata nel 1488 a spese della famiglia Romoli cui si deve la costruzione del nuovo altare marmoreo con la pittura della volta soprastante e la realizzazione delle lunette alle pareti in cui sono dipinte Storie di San Romolo, ormai molto deteriorate per l'umidità, attribuibili ad un pittore della cerchia del Rosselli.
PALAZZO PRETORIO : di origine trecentesca, cela la sua vera età che non traspare dalla sua facciata esterna che si affaccia sulla centrale piazza Mino. La prima impressione è di trovarsi di fronte a una costruzione rinascimentale a causa della loggia coorredata di colonne in pietra serena che vedono una corrispondenza nella terrazza superiore. L'aspetto odierno è dovuto a successivi restauri iniziati fin dal 1436. Così come Fiesole fu comune e successivamente sede di una podesteria, parallelamente si possono ritrovare tracce di questo passato all'interno del palazzo. Nei successivi anni fu adebito a varie funzioni fungendo da scuola, municipio e museo. Sulla facciata sono presenti stemmi che ricordano, non solo i vari podestà che si sono alternati alla guida della città, ma anche il periodo comunale precedente.
La chiesa di Santa Maria Primerana: si trova a Fiesole, alla sommità di piazza Mino da Fiesole, accanto al palazzo Pretorio.
Ricordata nel 966, venne ampliata in età medievale (ne resta il presbiterio gotico) ed ebbe una nuova facciata alla fine del Cinquecento, con paramenti architettonici di gusto manieristico e decorazioni a graffito di Ludovico Buti. Il porticato, su colonne architravate, è del 1801. L'interno è ad aula unica, conclusa da un transetto. Sull'altar maggiore, una tavoletta con la Madonna col Bambino del Maestro di Rovezzano (secolo XIII). Nel transetto, due bassorilievi votivi in marmo di Francesco da Sangallo, uno con l'Autoritratto dell'artista (1542) e l'altro con il Ritratto di Francesco del Fede (1575); e una terracotta invetriata della bottega di Andrea della Robbia (Crocifisso fra la Madonna, San Giovanni, la Maddalena e angeli). Il grande crocifisso ligneo sagomato e dipinto di scuola giottesca è attribuito a Bonaccorso di Cino.
2° itinerario ( km 2,5 circa) nota: nella
prima parte è
prevalentemente salita e
quindi occorre essere
allenati
Piazza Mino da Fiesole. Via
Verdi_Via di Montececeri _
Via degli
Scalpellini. Entrata libera
al Parco Naturale di
Montececeri. Monte
Ceceri _ Piazza Mons. Ferri
_ Via Corsica _Via F. Poeti_
Via dei Medici_ Via
Matteotti_ Via A. Gramsci_
Piazza Mino da Fiesole.
Nota: per abbreviare si può
anche prevedere un a/r con
salita al piazzale di h.1,15
ed il ritorno per la stessa
strada di h.0,45.
Piazza Mino da Fiesole.
Centro della cittadina, si
trova nell’area dell’antico
Foro. Vi sorgono il Duomo e
nel fondo, il palazzo
Pretorio, ora Comunale, del
‘300, adorno di stemmi del
podestà. A destra, c’è
l’antico oratorio di S.
Maria Primerana.
Lasciandosi alla sin. questa
piccola chiesa, si inizia a
salire per via Verdi e si
trova poco dopo sulla
sinistra una bella villa,
chiamata San Michele, con
decorazioni risalenti ai
primi del ‘900 in tipico
stile neogotico, mentre
sulla destra si trovano dei
piccoli giardini pubblici.
La stradina, fra due muri in
pietra, è un esempio tipico
delle strade dei borghi
collinari fiorentini.
Via Verdi, panoramica
e stretta via fra antiche
ma ben conservate
abitazioni.
Via di Montececeri, è
una delle più belle strade
panoramiche di Fiesole, un
continuo susseguirsi di
vedute straordinarie sulla
vallata di Firenze. Ci
avviamo verso il parco per
Via degli Scalpellini. Con
una deviazione a destra per
Via Doccia, si costeggia la
splendida Villa San Michele,
oggi un hotel extralusso e
un tempo convento
francescano di proprietà
della famiglia Davanzati,
con un bellissimo giardino
all’italiana ornato di
sculture e di alberi di
magnolia.
Monte Ceceri
Occupa
una superficie di 44 ettari,
su rilievi collinari.
Famoso fin dal medioevo per
l’attività estrattiva di
pietra serena. Un tempo
luogo di lavoro di tanti
scalpellini. Nell'area si
trovano 19 cave abbandonate
di pietra serena, dismesse
nei primi del '900. (Una
delle cave più suggestive
del parco, per la sua
colonna centrale e la grande
apertura nella montagna, è
cava Braschi).
I segni del lavoro
collegato all’attività
estrattiva, oltre che nelle
cave, si possono cogliere
nei sentieri, nelle strade,
nelle opere di regimazione,
nella struttura in generale
del paese: segni importanti
della vita operaia di
Fiesole. Lo stesso bosco è
opera dell'uomo.
Sulla cima si erge un cippo
commemorativo dedicato
all’ingegno creativo di
Leonardo da Vinci, che
effettuava da qui gli
esperimenti di volo, e al
coraggio di Tommaso Masini,
detto Zoroastro da Peretola,
uno dei "famigli" di
Leonardo che si presterà per
le prove. "Piglierà il primo
volo il grande uccello sopra
del dosso del suo Magno
Cecero" così inizia una
epigrafe di Leonardo da
Vinci che ricorda il primo
volo dell'uomo, riportandoci
molto indietro nel tempo
quando questo monte, privo
di vegetazione, ben si
prestava a tali
esperimenti. Sullo sfondo
ancora Firenze attrae la
nostra attenzione.Se si
volesse fare l'anello lungo
si può proseguire dal
piazzale per andare a Piazza
Mons. Ferri, uscendo dal
parco e quindi andare a sin. per via
Corsica e proseguire per
via F. Poeti
dove,
girando a destra, in via dei
Medici, in prossimità
dell'area verde di Borgunto,
si raggiunge la Fonte
Sotterra, una grotta
artificiale sotterranea, di
possibile origine etrusca,
usata come sorgente d’acqua
fin dal medioevo. Infine si
gira a sin. in via
Matteotti dove sono
visibili i resti di una
necropoli. Sono le uniche
tombe etrusche finora
scoperte a Fiesole.
Costruite in grandi blocchi
di pietra, facevano parte di
una grande necropoli posta
immediatamente fuori le mura
sul lato orientale. A
diritto, per Via Gramsci,
che ci riporta in via
Mino.
La Pro Loco di Quercianella organizza:
Domenica 6 ottobre 2019
La Pro Loco di Quercianella organizza per Domenica 6 ottobre 2019 una giornata dedicata alla raccolta e alla degustazione della castagna. Quest’anno, oltre al tradizionale pranzo e mondinata, ognuno potrà raccogliere e portare a casa le castagne direttamente dalla selva messa a totale nostra disposizione.Il programma della giornata:
Ritrovo dei partecipanti e
partenza in Pullman GT per
Castelnuovo Garfagnana:
tempo libero per la visita della
località e del suo mercato
contadino. Capoluogo della
Garfagnana,
il paese sorge alla confluenza
del fiume Serchio con
il torrente della "Turrite
Secca" ed è storicamente segnato
dalla dominazione estense che ne
fece il capoluogo della
provincia di Garfagnana.
Monumenti d’interesse sono la Rocca
Ariostesca, simbolo
della città che domina la
centrale piazza
Umberto I,
e il Duomo,
eretto nel XVI secolo sui resti
di una preesistente chiesa
romanica. Pranzo
in locale caratteristico.
Subito dopo il pranzo
trasferimento presso
l’Agriturismo dove nelle selve
circostanti ognuno inizierà la
raccolta delle castagne (1 kg. a
famiglia gratis) e grazie ad un
bel falò nel bosco assaggeremo
caldarroste bagnate da un buon
lambrusco. Ulteriori quantità di
castagne raccolte devono essere
pagate in loco. Nel tardo
pomeriggio partenza per il
rientro
Nota: La quota che verrà
richiesta dalla Pro Loco comprenderà: Viaggio
in Pullman Gran Turismo
riservato – pranzo in locale
caratteristico con bevande
comprese. Mondinata e 1 kg. di
castagne a nucleo familiare - La
conferma dovrà pervenire entro
il mese di settembre con il versamento di un
acconto di euro 20,00 a persona
non restituibile, salvo
sostituzione del rinunciatario.
Per informazioni ed iscrizioni: Silvana 335 7833238
Domenica 13 ottobre: ll parco di Poggio Neri. L’escursione di oggi ci porterà nel Parco di Poggio Neri, un'estesa foresta collinare dominata da lecci e castagni che offre molteplici opportunità di svago per chi predilige le attività all'aria aperta. Per promuovere la riscoperta di questi affascinanti luoghi, proprio all'interno del Parco sono stati predisposti percorsi di trekking lungo i quali è possibile sostare, dissetandosi attingendo a vecchie sorgenti ma soprattutto ripercorrere le difficili condizioni di vita degli antichi carbonai, una comunità che basava la propria economia sul carbone e sulla raccolta delle castagne, tramite l'osservazione di una fedele ricostruzione della loro esistenza quotidiana, appositamente realizzata nei pressi di un seccatoio dismesso: il Museo del Bosco. Info: Laura Malevolti 338 9083212
Domenica 27 ottobre - Pellegrinaggi medioevali nel territorio livornese - Nell’area settentrionale delle Colline livornesi sono presenti due complessi storico-religiosi di culto Mariano che hanno caratterizzato dal punto di vista sociale, economico e religioso questa porzione di territorio: il Santuario della Madonna delle Grazie di Montenero (1390) e l’Eremo di Santa Maria alla Sambuca (1367). In questi due luoghi i pellegrini medioevali, di ritorno da Santiago di Compostela o diretti a Roma, arrivano alla ricerca di riparo, ospitalità e cibo e ci sono testimonianze di un percorso che dalla pianura livornese, attraverso la via delle Sorgenti, costeggiava la valle del torrente Ugione per giungere all’Eremo della Sambuca, da dove poi proseguiva verso Roma lungo la Via delle Parrane. La presenza di testimonianze religiose e dello storico uso di strade e sentieri come percorso di umiltà e semplicità ci offre lo spunto per proporre un particolare utilizzo dell’anello di sentieri di questa porzione del Parco che, come il pellegrino di un tempo, noi ripercorreremo. Info: Luciano Suggi - 0586 406468 (ore serali) o 339 8700530 NOTA: POSTICIPATA AL 10.11
Dettaglio: - Nell’area settentrionale delle Colline livornesi sono presenti due complessi storico-religiosi di culto Mariano che hanno caratterizzato dal punto di vista sociale, economico e religioso questa porzione di territorio: il Santuario della Madonna delle Grazie di Montenero (1390) e l’Eremo di Santa Maria alla Sambuca (1367). In questi due luoghi i pellegrini medioevali di ritorno da Santiago di Compostela o diretti a Roma, due delle tre grandi mete spirituali dell’epoca, insieme a Gerusalemme, arrivano alla ricerca di riparo, ospitalità e cibo e ci sono testimonianze di un percorso che dalla pianura livornese, attraverso la via delle Sorgenti, costeggiava la valle del torrente Ugione per giungere all’Eremo della Sambuca, da dove poi proseguiva verso Roma lungo la Via delle Parrane oppure lungo il principale percorso della Via Francigena, verso Volterra e S. Gimignano. I Gesuati gestirono congiuntamente i beni dell’Eremo della Sambuca e del Santuario di Montenero (tra il 1450 e il 1650) ed è quindi probabile che per questo siano aumentati i contatti tra i due luoghi facendo in modo che i devoti che venivano in pellegrinaggio al Santuario proseguissero poi il loro cammino penitenziale o devozionale verso l’Eremo della Sambuca e viceversa. Oggi è storicamente possibile ricostruire un percorso che, partendo dall’Eremo della Sambuca sale a Valle Benedetta, prosegue per un breve tratto verso ovest sulla S.P. 5 di Valle Benedetta fino a Poggio Montioni e, deviando a sinistra verso Campo della Menta e Popogna Nuova, raggiunge la Strada provinciale e Popogna Vecchia per terminare, seguendo l’attuale segnavia 140, a Castellaccio e quindi, per la via del Poggio, arrivare in breve all’Aula Mariana ed al Santuario, dove nel 1500 i fedeli si recavano, dopo la fine della pestilenza della città di Livorno (1479) a rendere grazie alla Madonna di Montenero. La presenza di testimonianze religiose e dello storico uso di strade e sentieri come percorso di umiltà e semplicità offre lo spunto per proporre un particolare utilizzo dell’anello di sentieri di questa porzione del Parco che, come il pellegrino di un tempo noi percorreremo, ritrovando forse un’occasione per rallentare i nostri ritmi quotidiani, ascoltare la voce della natura ed anche ascoltare noi stessi.
Il Percorso del Pellegrino si sviluppa su una parte dei sentieri presenti nella foresta di Montenero, tutti efficacemente e recentemente segnalati con segnaletica a terra dalle associazioni aderenti al Progetto “Occhi sulle Colline”. Il Percorso del Pellegrino è formato da quattro sentieri principali, percorribili ad anello, e due varianti che permettono di “chiuderlo”. L’intero percorso è segnalato con frecce segnavia.
Testo liberamente adattato da: http://www.percorsodelpellegrino.it/pagine/pellegrinaggi.html
Maggiori dettagli sui percorsi a: http://www.percorsodelpellegrino.it/pagine/i_sentieri.html
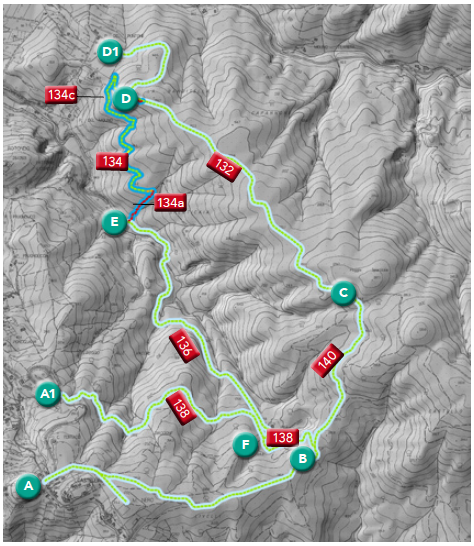 Noi oggi seguiremo un itinerario
breve, utilizzando i sentieri
138 (in discesa per h.0,40 fino
a Pian della Rena dove, a vista
della costruzione, si prosegue
per il sentiero 138, in salita
per h.0,20, fino
all’intersezione col n°140. Qui
si va a sinistra per il sentiero
134 (non segnalato), bellissimo
tratto nella macchia che scende
per h.1.45 ed arriva a un
evidente bivio dove noi,
lasciando il 134, scendiamo per
la bretella di raccordo 134 a,
altri h.0.20. Terminata la
discesa, talora difficoltosa,
siamo sul sentiero 136,
costeggiamo il botro del Molino
nuovo, passando un paio di ponti
in muratura, e proseguiamo in
leggera salita per h.0.45,
tornando quindi a Pian della
Rena dove saliremo nuovamente
per il sentiero 138 e quindi il
140 verso destra per arrivare in
h.0,45 all’asfaltata. Altre
h.0.15 e saremo di nuovo alle
auto. Nota: in prossimità di
questo percorso sono accessibili
sia 1) la fonte del Sasso Rosso
(dall’area di sosta del
Castellaccio si scende per il
primo sentiero a sinistra del
parcheggio – non segnalato- per
m.0,20). 2 la Grotta dei Banditi
(lungo il n°140, poco dopo lo
sbocco del n°138, una deviazione
a destra -non segnalata- che
scende per circa m.0,40.
Noi oggi seguiremo un itinerario
breve, utilizzando i sentieri
138 (in discesa per h.0,40 fino
a Pian della Rena dove, a vista
della costruzione, si prosegue
per il sentiero 138, in salita
per h.0,20, fino
all’intersezione col n°140. Qui
si va a sinistra per il sentiero
134 (non segnalato), bellissimo
tratto nella macchia che scende
per h.1.45 ed arriva a un
evidente bivio dove noi,
lasciando il 134, scendiamo per
la bretella di raccordo 134 a,
altri h.0.20. Terminata la
discesa, talora difficoltosa,
siamo sul sentiero 136,
costeggiamo il botro del Molino
nuovo, passando un paio di ponti
in muratura, e proseguiamo in
leggera salita per h.0.45,
tornando quindi a Pian della
Rena dove saliremo nuovamente
per il sentiero 138 e quindi il
140 verso destra per arrivare in
h.0,45 all’asfaltata. Altre
h.0.15 e saremo di nuovo alle
auto. Nota: in prossimità di
questo percorso sono accessibili
sia 1) la fonte del Sasso Rosso
(dall’area di sosta del
Castellaccio si scende per il
primo sentiero a sinistra del
parcheggio – non segnalato- per
m.0,20). 2 la Grotta dei Banditi
(lungo il n°140, poco dopo lo
sbocco del n°138, una deviazione
a destra -non segnalata- che
scende per circa m.0,40.
Da: http://www.agireverde.it/PARCO%20MONTI%20LIVORNESI.htm
Totale escursione, escluso soste, h.4/4.30 circa.
Domenica 10 novembre: I percorsi verdi di Castellina M.ma
NOTA: per motivi tecnici viene anticipata al giorno 03.11. Castellina Marittima, conosciuta fin dal periodo etrusco per le sue cave di alabastro, è collocata in uno scenario che sintetizza gli aspetti più caratterizzanti del paesaggio toscano, con colline coltivate a olivo, vite e grano, filari di cipressi e una rigogliosa macchia mediterranea, habitat naturale di cinghiali e altri animali selvatici. L’escursione di oggi ci porterà a spasso per questo territorio, nel verde e nella quiete di una zona ancora incontaminata inserita nella “ Strada del Vino delle Colline Pisane”. Info: Laura Malevolti 338 9083212
Domenica 17 novembre (POMERIGGIO): prospettive e futuro dell'associazione
L’associazione, nata da un gruppo di amici che si ritrovano una domenica mattina nel Parco delle colline livornesi nella primavera del 1997, in questi 20 anni di attività si è ben sviluppata dal p.d.v. escursionistico, pure non essendoci un fine di lucro, ma……si sente ancora parte di quel movimento mondiale che vorrebbe una società basata su un’economia equa e un modello di sviluppo sostenibile che rispetti la natura, soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri? E’ ancora quella della Genova del G8 e della marcia Perugia/Assisi, oppure è diventata unicamente un passatempo domenicale, a prescindere da tutto? Di questo, oltre che di prospettive e futuro dell’associazione si parlerà nei locali del Museo, con offerta da parte nostra di “una ricca e gustosa merenda”. Siete tutti invitati. Info e prenotazioni ( per sapere quanta merenda occorre) entro giovedi 14: Rossano Poggi - 0586 375131 (ore serali) o 331 1131900
Domenica 24 novembre - I mulini ad acqua del rio Sanguigna - Sorto sul versante orientale dei monti livornesi Gabbro, ha origini medievali e, benchè mai citato dalle fonti come castello, già nel ‘300 viene definito ‘comune rurale’, probabilmente ereditando l’agglomerato la popolazione dei vicini castelli di Torricchi e Contrino, comunque distrutti già nel corso del basso-medioevo. Con Cosimo I° de Medici la zona fu oggetto, dal 1547 in poi, di ripetuti tentativi di colonizzazione voluti dai Medici allo scopo di accrescere la produzione agricola necessaria allo sviluppo del centro di Livorno, come è testimoniato dai resti di numerosi mulini ad acqua, risalenti allo stesso periodo, che sorgevano lungo l’alta valle del Botro Sanguigna e che facevano parte di un più ampio sistema produttivo creato proprio allo scopo di approvvigionare di grano la nascente e vicina città di Livorno. Info: Luciano Suggi - 0586 406468 (ore serali) o 339 8700530
descrittivo:
Dettaglio: Dal parcheggio del Gabbro saliamo all’asfaltata e prendiamo subito per via della Rosa, di fronte a noi e ben riconoscibile per la presenza di un ambulatorio veterinario. Andiamo avanti per circa 10 minuti, uscendo dal paese e trovando prima un’edicola votiva a sinistra e quindi un bivio che ci indica Colognole andando avanti e Ricaldo invece a destra.Scendiamo per Ricaldo, ora nel bosco, ora uscendo verso i coltivi ed in altri 20 minuti siamo ai lavatoi del Gabbro, di cui si ha notizia fin dal tardo ‘600. Una breve visita e risaliamo quindi per una stradina sterrata (a destra) che ci riporta sull’asfaltata in circa 20 minuti. Prendiamo ancora a destra per altri 10 minuti sulla provinciale ed iniziamo a scendere alla nostra sinistra, attraversando l'asfaltata e dopo circa m.200 (ben evidenti i cartelli che indicano la direzione da seguire, seguendo il sentiero 199). Ci aspetta adesso un saliscendi di circa h.1, per zone boschive, sterrati e canneti e viottoli lastricati di massi, vestigia degli antichi tracciati, finchè, dopo aver guadato il botro Riardo, saremo ad un cancello grigio dove gireremo a destra (a sinistra si andrebbe al ponte romano). Altre h.0,45, andando a diritto per h.0,20, finchè, alla nostra sinistra, troveremo un breve stradello a fondo chiuso ma noi gireremo invece alla prima carrareccia a destra. In altre h.0,30 saremo al botro Sanguigna ed ai suoi mulini e, girando a destra e seguendo il corso d’acqua termineremo la nostra passeggiata, risalendo per circa h.0,20 (unica salita impegnativa) per arrivare al campo sportivo prima e dopo ancora al parcheggio dove avremo lasciato le auto. Trekking di h.3.30/4 + soste, media difficoltà e con piccoli tratti da guadare
Venerdi 13 dicembre: Convivium
Come da tradizione consolidata ci troveremo per la cena degli auguri, scambiandoci opinioni e punti di vista sui diversi momenti associativi trascorsi insieme e, se possibile, per una fotoproiezione di immagini relative alle iniziative sviluppate nel corso dell’anno. La prenotazione va fatta inderogabilmente entro venerdi 06.12. Info e prenotazioni: Rossano Poggi - 0586 375131 (ore serali) o 331 1131900
Domenica 15 dicembre: Trekking urbano a Pistoia Pistoia spesso non viene inserita nei classici itinerari turistici ma è senz’altro una città ricca di fascino e di cose da vedere, un luogo piacevole da scoprire a poco a poco, senza programmi serrati e tuttavia con alcune “fermate” assolutamente imprescindibili come Il Duomo di Pistoia che risale al X secolo ed è intitolato a San Zeno oppure l’antico Ospedale del Ceppo, fondato nel XIII secolo e che ebbe un ruolo fondamentale nel 1349 quando la città fu colpita da un’epidemia di peste nera. Benchè non visitabile al suo interno, sarà tuttavia possibile fare una visita guidata di parte dei suoi sotterranei grazie a “Pistoia Sotterranea”, con 650 metri di sotterranei bonificati attraverso i quali una guida illustrerà ai visitatori secoli di storia di Pistoia e dell’Ospedale. Laura Malevolti 338 9083212
Domenica 12 gennaio: itinerari di CAMAIORE ANTIQUA
Camaiore Antiqua è il nome dei 15 percorsi ad anello che si sviluppano sul territorio di Camaiore: ben 150 km di sentieri e mulattiere, integrati nell’itinerario della “Traversata delle Frazioni Camaioresi”, tracciata dagli Amici della Montagna di Camaiore. Andremo a scoprire la storia e la natura di Camaiore e del suo entroterra, spaziando dalle grotte preistoriche del Tambugione alla Grotta all’Onda, dalle incisioni rupestri di Greppolungo ai resti del castello feudale di Montecastrese come alle pievi romaniche ed alle ville storiche del comprensorio, con panorami mozzafiato sia sul mare che verso le Alpi Apuane. Il percorso prescelto verrà comunicato dal referente in prossimità dell’evento, tenendo conto sia del fattore meteo che della manutenzione dei sentieri. Info: Laura Malevolti 338 9083212
Domenica 26 gennaio: Gli arenili tra Donoratico e San Vincenzo
Il trekking sulla spiaggia tra Donoratico e San Vincenzo si sviluppa su un tracciato diverso dagli altri e di recente progettazione, pianeggiante, con arenili di sabbia dorata e fine che si estendono per chilometri e chilometri e punteggiati da suggestive fortificazioni e vedette di avvistamento, un tempo utilizzate per la difesa della costa dagli assalti dei pirati. Da dire anche, a sottolineare l’ambiente incontaminato, che saremo prossimi all’oasi floro-faunistica del Parco di Rimigliano, dove fiorisce il giglio di mare e le dune sabbiose sono ricoperte di ginepri, di mirto e di lentisco, con boschi di lecci e sugheri e la folta pineta che lambiscono l’arenile. Info: Laura Malevolti 338 9083212
Altre da riproporre:

L’escursione ci porterà dove il torrente Chioma è raggiunto dall’affluente Quarata, per proseguire nell’ampia valle collinare che lo conduce a Quercianella, ampio ed in un letto ben scavato. L’itinerario è naturalistico, poiché passeremo per una delle zone dove iniziò l’esondazione del Chioma, nel settembre ’17 , ma anche storico, poiché da Nibbiaia ripercorreremo i sentieri che portavano alla macchia i partigiani del Decimo Distaccamento Oberdan Chiesa della Terza Brigata Garibaldi e quindi alla così detta “grotta dei banditi”, dove trovavano momentaneo rifugio.
La “grotta dei banditi” è a neanche un paio di chilometri dal Castellaccio ed era il luogo dove si rifugiavano i partigiani del Decimo Distaccamento Oberdan Chiesa della Terza Brigata Garibaldi, insieme ai tanti giovani alla macchia che, dopo l'8 settembre’43, fuggivano dal reclutamento forzato fra i repubblichini e dai rastrellamenti dei tedeschi (ricordiamo che la strage di Sant’Anna di Stazzema avvenne nell’agosto del’44 e quindi che la guerra era tutt’altro che finita). La zona “Quarata” è impervia e boscosa ma, conoscendone i sentieri, non sarà difficile arrivarci a partire da Nibbiaia. L’escursione ha una notevole valenza paesaggistica ed evidentemente anche storica, sviluppandosi per i 2/3 nel folto del sottobosco collinare e per 1/3 su strade vicinali, ad uso dei numerosi poderi della zona. Dettaglio: seguendo il sentiero 00 in discesa (segni bianco/rossi), si arriva al podere del Gorgo dove, per una carrareccia, prenderemo la direzione Quarata per salire verso una casa colonica bianca, in alto sulla collina e a destra. Ci addentreremo quindi nella macchia, arrivando ad uno spiazzo aperto con evidente bivio da dove, in discesa, ci porteremo alle grotte (dei banditi dal tedesco banditen), da dove, visitati questi anfratti naturali, sempre in discesa, chiuderemo il nostro anello in circa h.4.30 di cammino.I mulini lungo il torrente Lòmbrici. Alle pendici delle montagne che circondano Camaiore si trova un luogo incantevole, in una zona ad alto valore paesaggistico e storico la cui natura è incontaminata, con il torrente che crea piscine naturali e cascatelle di rara bellezza. Sulle pareti rocciose laterali esistono poi alcune tra le palestre di roccia più interessanti dell’Italia centrale e lungo la via d’acqua, riccamente verde, sono disseminati numerosi opifici di epoca pre-industriale. Dei 40 mulini, pastifici e frantoi, tutti azionati tramite l’energia idraulica ricavata dalla forza propulsiva del torrente ed uno dei quali troviamo addirittura documentato a Casoli sin dal 1347, rimangono tuttavia ad oggi soltanto dei ruderi, benchè ne sia previsto un recupero strutturale. L’escursione non presenta difficoltà e viene abbinata alla raccolta delle castagne nei boschi sovrastanti che raggiungeremo in auto nel pomeriggio, lasciando tuttavia la possibilità, per chi volesse camminare un po’ di più, di raggiungere il borgo di Metato per il "Sentiero do Saudade" (h.1.30), dedicato ai soldati brasiliani che lo percorsero nel 1944 per scollinare il monte Prana, dove ci ricongiungeremo tutti insieme.
Lasciata l’auto in località Candalla (dove la strada finisce), si attraversa il ponte sul torrente Lombricese e si prosegue lungo il sentiero che costeggia il torrente stesso, e trascurando la deviazione per Casoli a sinistra. Alla destra è ben visibile un’imponente parete di roccia. Trascurare la deviazione a destra (sentiero con balaustra) che conduce al torrente ed alla vicina palestra di roccia. Si incontrano i primi ruderi (ex pastificio) e si prosegue ancora per una decina di minuti lungo la traccia, fino a giungere ad una biforcazione in prossimità di due grossi massi. Pochi metri oltre i massi, un guado facilmente superabile porta ad altri ruderi di vecchi mulini. Se si volesse proseguire verso Metato o verso Casoli, entrambi luoghi caratteristici meritevoli di essere visitati, basta salire a sinistra e superare una grossa pietra sul sentiero per arrivare allo stradello che porta a sinistra a Casoli (h.0,15) ed a destra a Metato (h.1,30)..Per Candalla si chiuderà poi l'anello, in discesa, seguendo le indicazioni nella piazzetta del paese.
Domenica di marzo: l’area boschiva del Cisternino di Pian di Rota ed "il risveglio muscolare"
Spesso
andiamo in cerca di aree verdi lontano dalla città quando invece le abbiamo e
belle proprio fuori porta, nella zona del Cisternino di Pian di Rota ad esempio.
A partire dai Bagnetti, una delle ultime costruzioni di
Pasquale Poccianti,
costruiti tra il
1843 ed il
1844 nella
campagna intorno alla città per rappresentare il nuovo centro di attrazione dei
villeggianti dell'epoca, stante la presenza di alcune polle d'acqua solfurea
idonee per lo sfruttamento termale, seguiremo il corso del rio Puzzolente nel
suo andare a nord verso il torrente Ugione, per sentieri recentemente riadattati
all’attività dei taglialegna e, seguendo campi incolti prima e tracciati nella
macchia poi, dove il leccio si alterna al Cerro e alla Rovella, descriveremo un
anello di circa h.3/3.30. L’escursione è quasi una passeggiata, con percorso
pianeggiante e nel verde, appena macchiato da ginestroni e cisto bianco che
cominciano a fiorire proprio in questo inizio di primavera e, se non
disturberemo troppo con il nostro chiacchiericcio l’avifauna locale, sarà bello
sentirsi accompagnati ora dai verso dell’Upupa, ora dal grido d’allarme della
ghiandaia che segnalerà la nostra presenza, come anche dal volo della poiana che
ci scruterà dal cielo. Nel corso dell'escursione un esperto introdurrà i
partecipanti alle metodiche del "risveglio muscolare", esercizi di preparazione
e completamento dell'attività motoria Percorso: dai Bagnetti prendiamo a sinistra del ponte e
devieremo per la salitella che troveremo alla nostra sinistra. Prima il bosco,
poi una radura ed ancora il bosco e saremo in vista degli archi dell’acquedotto
dove noi prenderemo a destra, lungo i campi e costeggiando una distesa di grano
selvatico. Andiamo adesso sempre a diritto per entrare in un bosco più fitto di
lecci e querciformi, trovando un bivio che dovremo prendere a sinistra
perché a
destra andremmo al monte La Poggia. Il sentiero diviene adesso più largo e battuto e ci
riporta alla radura di prima, da dove in poco tempo si ritorna, non prima però di aver
seguito un percorso nella macchia molto frequentato dai numerosi cinghiali che
vivono in queste selve.
I Bagni nell’Acqua… Puzzolente ………..
"Lasciammo a destra la strada del Limone e da mano sinistra è una pozza o Lagunetta formata da una sorgente di Acqua Sulfurea fredda, la quale a cagione del gran fetore, viene in Livorno chiamata l'Acqua Puzzolente […] L'acqua assaggiata non ha sapore, né acido di alcunasorta in se, ma puzza di Uova sode. Ella fa bene per i Mali cutanei". Così scrisse Giovanni Targioni Tozzetti nelle sue "Relazioni di alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana" del 1786.Per sfruttare le proprietà dell’acqua solforosa i proprietari della tenuta Limone affidarono all'architetto Poccianti la realizzazione dei bagni della Puzzolente, iniziati nel 1843 e inaugurati nel 1844. L’edificio ha pianta rettangolare con due emicicli che contenevano ognuno otto bagnetti. A poca distanza dietro le terme vi è un'altra costruzione a forma di tempietto rotondo dove sono riunite e allacciate tutte le polle. Qui la pompa aspirante raccoglieva l'acqua che veniva riscaldata e diramata nelle diverse cabine. A quell'epoca Livorno, con le sue 12 sorgenti, era un famoso centro termale. Anche la fonte Puzzolente ebbe successo, infatti nell'anno 1876 usufruirono di tali impianti circa 9.720 persone e furono praticati giornalmente oltre 90 bagni. “Molto potremmo dire sopra felici risultati ottenuti dall'uso di quest'acqua e si potrebbero ancora allegare numerosi attestati di persone ammalate che ricuperarono la salute, o trovarono nell'acqua puzzolente alleviamento alle loro sofferenze” (G.Orosi, 1845). Col volgere dei tempi però, con la scoperta di nuove acque simili, con le comodità sempre maggiori che nuovi stabilimenti offrivano ai frequentatori, dopo un lento e graduale decadimento, i bagni della Puzzolente furono chiusi al pubblico nell'anno 1897 ed adibiti ad uso di magazzini e di cantina di vino e le acque furono abbandonate per i fossi adiacenti. Da - http://www.webalice.it/diego.guerri/EeP/guida_boschi_rid.p
altra proposta analoga:
l’area boschiva del Cisternino di Pian di Rota ed "il risveglio muscolare" - Spesso andiamo in cerca di aree verdi lontano dalla città quando invece le abbiamo e belle proprio fuori porta, nella zona del Cisternino di Pian di Rota ad esempio. A partire dai Bagnetti, una delle ultime costruzioni di Pasquale Poccianti, costruiti tra il 1843 ed il 1844 nella campagna intorno alla città per rappresentare il nuovo centro di attrazione dei villeggianti dell'epoca, stante la presenza di alcune polle d'acqua solfurea idonee per lo sfruttamento termale, seguiremo il corso del rio Puzzolente nel suo andare a nord verso il torrente Ugione, per sentieri recentemente riadattati all’attività dei taglialegna e, seguendo campi incolti prima e tracciati nella macchia poi, dove il leccio si alterna al Cerro e alla Rovella, descriveremo un anello di circa h.3/3.30. L’escursione è quasi una passeggiata, con percorso pianeggiante e nel verde, appena macchiato da ginestroni e cisto bianco che cominciano a fiorire proprio in questo inizio di primavera e, se non disturberemo troppo con il nostro chiacchiericcio l’avifauna locale, sarà bello sentirsi accompagnati ora dai verso dell’Upupa, ora dal grido d’allarme della ghiandaia che segnalerà la nostra presenza, come anche dal volo della poiana che ci scruterà dal cielo. Nel corso dell'escursione un esperto introdurrà i partecipanti alle metodiche del "risveglio muscolare", esercizi di preparazione e completamento dell'attività motoria, adesso che questo inizio di primavera comincia ad indurci di nuovo al movimento.
L’Acquedotto del Limone, andando verso il monte La Poggia (colline livornesi)

descrittivo -
All’altezza del ponte in cemento, dopo i vecchi bagni della Puzzolente si va a destra e si procede a diritto per uno stradello che collega tra di loro i diversi poderi e orti della zona e lo si segue per circa h.0,45. Arrivati ad un bivio, lasciamo questa carrareccia e, dove vediamo una sbarra bianco/verde che ci segnala che siamo nel Parco, giriamo ed entriamo nel bosco. Risaliremo adesso il rio dell’acqua puzzolente per circa h.1, dovendolo guadare di traverso per alcune volte. L’ultimo tratto di questo itinerario è in leggera salita per altri h.0,15 (unico tratto con una pendenza noiosa) e ci vede sbucare sotto il monte La Poggia, proprio sotto la zona della cava del Canaccini. A questo punto prendiamo lo stradello asfaltato alla nostra destra e in discesa per circa h.0,20, finchè troveremo un bivio che scende a destra (a sinistra vedremo un viale alberato a cipressi, che sale), prima per h.0.30 di stradello sassoso e dopo, entrando nel bosco per altre h.0.20, uscendone infine sulla sinistra trovando una rete divisoria lunghissima che seguiremo, non lasciando il bosco finchè non arriveremo alla zona degli oliveti. Scendiamo a diritto tra gli olivi, leggermente sulla destra ed eccoci nuovamente alla fonte della Puzzolente in altri h.0,45 (volendo possiamo anche restare a contatto della rete divisoria ed andare a trovare lo stradello che porta alla fattoria didattica del limone) dove prenderemo a destra per tornare alle auto. Totale circa h.4 a/r (escluse soste) – dislivello ca mt.300
L’acquedotto del Limone e l’approvvigionamento idrico di Livorno
L’acqua di questo acquedotto, proveniente da sorgenti della zona (ancora oggi utilizzate ad uso agricolo locale), non serviva soltanto per la sopravvivenza delle popolazioni residenti, ma anche per il rifornimento di navi ormeggiate presso il vicino porto (porto pisano) e per il retroterra produttivo della zona, certamente fiorente vista l’attività del porto nelle varie epoche. Il termine Limone, con cui si definisce quest’area, non è da ricondursi a coltivazioni dell’omonimo agrume; essendo più probabile invece che derivi dal termine latino limus = fango, viste le caratteristiche del terreno che si presenta particolarmente fangoso.
Edificato seguendo un preesistente acquedotto romano che testimonianze archeologiche permettono di datare in un periodo compreso fra il I sec. a.C. ed il IV sec. d.C, con un approvvigionamento stimato per circa 8.000 persone, l’acquedotto di Limone venne approvato nel 1601 da Ferdinando I dei Medici, onde sopperire alla continua mancanza d’acqua potabile in cui si trovava Livorno e divenne la maggiore fonte di approvvigionamento idrico della città fino alla fine dell’Ottocento.
Da
dire che durante il Medioevo la cittadina di Livorno ebbe un forte incremento
demografico con un costante aumento del fabbisogno idrico giornaliero,
soddisfatto tramite la raccolta dell’acqua piovana in grandi cisterne e col
prelievo da pozzi posti nelle vicinanze degli abitati. Nel 1421 a Livorno si
contavano circa 1.200 abitanti e l’acqua potabile veniva cercata in fonti sempre
più lontane ( gli incaricati che si procuravano e smerciavano quest’acqua erano
detti acquaioli). Con la costruzione della Fortezza Vecchia (a.1530 circa) poi
ed il conseguente ampliamento dell’abitato di Livorno, la popolazione salì fino
a circa 1800 persone e quindi aumentò ulteriormente la necessità di acqua per
cui, sotto il governo di Francesco I de’ Medici, fù indispensabile pensare ad un
grande acquedotto che poi fu il Granduca Ferdinando I a realizzare e che entrò
in attività nel 1611, con il nome di Acquedotto di Limone o delle Vigne (
sorgenti ubicate sul Monte la Poggia). Questo permise l’ampliamento di Livorno e
quindi della sua demografia fino al 1645, quando si raggiunsero gli 8.000
abitanti. Un grande acquedotto si era reso indispensabile anche perchè agli
inizi del 1600, con i lavori necessari per la costruzione dei fossi, furono
interrotte numerose falde freatiche locali con in più la salinizzazione di
numerosi pozzi all’interno della città. Per sopperire a questo grave problema ci
si rivolse a sorgenti sempre più lontane dalla città, in particolare a quelle di
Limone, finchè nel 1732, anche l’acqua proveniente da quest’area non si rivelò
insufficiente per una popolazione che ormai contava 24.000 persone e che
raddoppiò entro il 1789. Fù allora che il sovrano Ferdinando III approvò il
progetto dell’Acquedotto di Colognole (1792) che entrò in funzione nel 1816 per
essere infine sostituito agli inizi del ‘900 con quello di Filettole che, con
dovuti ammodernamenti, approvvigiona ancora oggi la città.
approfondimenti:
http://www.archart.it/livorno-sorgenti-di-limone.html archeologia della costruzione
http://www.lalivornina.it/DESCRIZIONI%20PERSONAGGI%20FAMOSI/FERDINANDO%20I.htm Livorno ai tempi di Ferdinando I
http://wsimag.com/it/economia-e-politica/17471-emergenza-idrica-a-livorno emergenza idrica cittadina nel 1600
da Montemarcello a Tellaro (anello)
Dalla cima del promontorio del Caprione, immerso nella vegetazione mediterranea, lascia senza fiato il panorama del golfo di La Spezia a ovest e della fertile piana del fiume Magra, a est. Apprezzata dai Romani, che vi fondarono l'insediamento di Luni, l'area fluviale alterna coltivazioni e zone umide, ove nidificano uccelli acquatici, a settori assai compromessi. Il parco, nato dalla fusione del precedente parco fluviale e dell'area protetta di Montemarcello, rappresenta quindi un esperimento (riuscito!) di riqualificazione di zone degradate, tant’è che la porzione di Parco in cui andremo è veramente bella. Dal borgo di Montemarcello, con le sue viuzze strette che s'intersecano ad angolo retto, ricordano un "castrum" romano, saliremo verso l’orto botanico, splendidamente collocato sulla sommità di Monte Murlo, e sosteremo a Tellaro, piccolo borgo marinaro abbarbicato sopra una penisoletta rocciosa digradante ed ultimo abitato della riva orientale del Golfo dei Poeti. Il ritorno sarà per un sentiero a mezza costa, solo recentemente riaperto, attraverso tratti di macchia mediterranea che si alternano alla folta lecceta. Trekking di media difficoltà ma abbastanza lungo, con tratti segnalati come esposti in cui fare attenzione e salite/discese su terreni sconnessi (in particolare per Tellaro da Zanego). Tempo occorrente circa 5/5,30 ore.
Descrittivo: Una volta giunti a Montemarcello si parcheggia e si entra nel paese attraverso l'antica porta (scegliendo il parcheggio che incontriamo seguendo l'indicazione stradale a destra. A sinistra ne troveremmo un altro che per adesso trascuriamo). Proseguiamo a destra della chiesa parrocchiale dove si scende lungo una scalinata, al termine della quale si attraversa la strada asfaltata, percorrendo circa 100 metri in una stradina tra le case. Attraversata che avremo la strada e trovato un altro parcheggio, quello di cui si diceva prima e che però ci priverebbe della visita al borgo ed anche ai punti panoramici su punta Corvo, si scenderà l’asfaltata in direzione Lerici per 5 minuti, trovando un sentiero segnato ( a destra) che seguiremo fino a Tellaro (n°433).Nota - da adesso seguire sempre il n°433.
Saliamo a destra e ci inoltriamo per 30 minuti in una folta macchia a leccio, uscendone per ritrovare l’asfaltata e, dopo 5 minuti e sempre alla nostra destra, troviamo la continuazione del sentiero 433 per Zanego/Lerici, salendo per altri 15 minuti, in un bosco a pini d'Aleppo e lecci. Altro attraversamento dell’asfaltata ed altri 15 minuti, di salitella col selciato in pietra e due muri a secco che lo delimitano, ed arriviamo ad un punto panoramico, con apertura sul golfo dei poeti, la Palmaria e Porto Venere (siamo ad un bivio col sentiero 437, per l’orto botanico). Noi andiamo a diritto ed in altri 15 minuti siamo a Zanego, nella zona dei coltivi e degli orti e poi tra le case della piccola frazione.
Siamo adesso nuovamente sull’asfaltata che attraversiamo, col ristorante Pescarino davanti a noi, dove, seguendo i segni bianco/rossi tracciati sul muro ( alla nostra destra) scendiamo per 20 minuti il sentiero, tra le abitazioni, arrivando alla segnalazione per Tellaro, davanti a noi ed in discesa ed Ameglia, in discesa ma alla nostra destra. Fin qui sono passate circa h.1.45/2.
Scendiamo per Tellaro, facendo attenzione al fondo sconnesso ed a alcuni punti franati e non troppo larghi. Altri 60 minuti e, passato il bivio per Portesone e Lerici, infine arrivati a Tellaro (borgo incantevole!)in altri 10 minuti, torniamo indietro per il sentiero 444, recentemente riaperto dal CAI di Sarzana e segnalato come con tratti potenzialmente pericolosi e da percorrere con molta attenzione, ed in altre h.1,45 a mezza costa torniamo a Montemarcello e volendo a punta Corvo (bellissimo promontorio ma cui si arriva dopo una scalinata con ben 700 gradini!). Trekking di media difficoltà ma abbastanza lungo, con tratti segnalati come esposti ed in cui fare attenzione. Salite/discese su terreni sconnessi (in particolare per Tellaro da Zanego). Tempo occorrente circa 5/5,30 ore.

Alle pendici del monte Pisano c’è un’area posta ai margini dell’ex lago di Bientina, oggi prosciugato per interventi di bonifica intorno all’anno 1850, con flora e fauna tipici delle aree palustri, oggi sempre più rarefatte e soggette ad azioni di degrado, che vale la pena di conoscere ed apprezzare: il bosco Tanali.
La zona, con prati umidi periodicamente allagati, pagliereti,
boschi umidi ad ontano nero,
canneti e piccoli specchi
d’acqua, offre ambienti
importanti per la vita di
molte specie, sia botaniche
che animali, tipo l’avifauna
migratrice oppure i suoi
antagonisti rapaci (la
poiana, l’albanella o anche
il
falco
di palude, sebbene più
raro).
 L’escursione, semplice ma suggestiva, ci condurrà gradatamente
verso la parte più interna
dell’area, attraversando in
sequenza le comunità
vegetazionali principali
(bosco mesofilo, bosco
igrofilo, canneto/cariceto)
terminando, con
l’attraversamento di un
pontile di legno, in un
capanno per l’avvistamento
degli uccelli.
L’escursione, semplice ma suggestiva, ci condurrà gradatamente
verso la parte più interna
dell’area, attraversando in
sequenza le comunità
vegetazionali principali
(bosco mesofilo, bosco
igrofilo, canneto/cariceto)
terminando, con
l’attraversamento di un
pontile di legno, in un
capanno per l’avvistamento
degli uccelli.
Nota storica:
Il lago di Bientina o di
Sesto (Lacus Sexti) fino
alla prima metà
dell’ottocento costituiva il
lago più grande della
Toscana. Nel 1852 il
Granduca Leopoldo II di
Lorena, approvò il progetto
di bonifica di Alessandro
Manetti con il quale fu
realizzata la deviazione del
Canale Imperiale sotto
l’alveo dell’Arno grazie a
un condotto
 Dal sito della regione
toscana
Dal sito della regione
toscana
Riserva Regionale: BOSCO DI TANALI (PI)
Atto istitutivo: Delibera della Giunta Provinciale di Pisa n. 77 del 12/04/2010
Estensione: 175 ettari
Descrizione:
Situata ai margini dell'ex
alveo del Lago di Bientina,
occupa un'area di 175
ettari, ricca di fauna e di
flora. Agli inizi del secolo
scorso il territorio, antico
lembo  Tale bacino,
con il trascorrere del
tempo, ha contribuito alla
creazione e al mantenimento
di un ambiente umido di
grande interesse
naturalistico. L'area
presenta attualmente una
grande varietà di ambienti
che, sotto l'aspetto vegetazionale, si possono
distinguere in quattro
differenti habitat.
L’'associazione vegetale più
importante è il bosco
igrofilo caratterizzato,
nelle specie arboree, dalla
prevalenza di ontano nero e,
nella flora tipica dei suoli
inondati, dalla presenza
della più grande felce
italiana e di varie liane
rampicanti. Nei terreni dove
l'allagamento è ridotto si
estende il bosco mesofilo,
caratterizzato nella sua
specie vegetale da ontano
nero, pioppo bianco, farnia,
sambuco e salicone. La parte
più orientale del bacino di
colmata è occupato da una
vegetazione uniforme a
cannella palustre. Il
canneto è estremamente
importante per la
nidificazione di molte
specie ornitiche, mentre
nelle parti più depresse del
canneto stesso vegetano i
grandi carici, una specie
palustre in via di
estinzione. All'interno del
cariceto è stata rinvenuta
la primulacea Hottonia
palustris, pianta rarissima
in tutta l'Italia
peninsulare e probabile
unico esemplare superstite
nel Padule di Bientina. Le
raccolte di acqua sottoposte
ad essiccamento estivo
vedono lo sviluppo di
vegetazioni di prato umido
che annoverano specie molto
rare come la Ladwigia
palustris. Le piante
idrofite, necessitando della
presenza d'acqua per
l'intero ciclo vitale,
vivono confinate in alcuni
canali e fossi; tra di esse
meritano menzione il morso
di rana, la ninfea bianca,
la rarissima erba scopina e
l'erba vescica, pianta
carnivora il cui nome
volgare è attribuibile alla
presenza di piccole
vescicole sulle foglie atte
alla cattura di piccoli
invertebrati acquatici. La
ricchezza degli ambienti
vegetazionali dell'area, la
cui variabilità è
incrementata dal periodico
allagamento di alcune zone,
che determina un’ulteriore
diversificazione stagionale,
favorisce la presenza di
numerose ed interessanti
specie animali. Le specie
vertebrate presenti sono
strettamente condizionate
dalla ricchezza di acqua;
tuttavia non manca una fauna
meno legata a questo
particolare ecosistema.
Tale bacino,
con il trascorrere del
tempo, ha contribuito alla
creazione e al mantenimento
di un ambiente umido di
grande interesse
naturalistico. L'area
presenta attualmente una
grande varietà di ambienti
che, sotto l'aspetto vegetazionale, si possono
distinguere in quattro
differenti habitat.
L’'associazione vegetale più
importante è il bosco
igrofilo caratterizzato,
nelle specie arboree, dalla
prevalenza di ontano nero e,
nella flora tipica dei suoli
inondati, dalla presenza
della più grande felce
italiana e di varie liane
rampicanti. Nei terreni dove
l'allagamento è ridotto si
estende il bosco mesofilo,
caratterizzato nella sua
specie vegetale da ontano
nero, pioppo bianco, farnia,
sambuco e salicone. La parte
più orientale del bacino di
colmata è occupato da una
vegetazione uniforme a
cannella palustre. Il
canneto è estremamente
importante per la
nidificazione di molte
specie ornitiche, mentre
nelle parti più depresse del
canneto stesso vegetano i
grandi carici, una specie
palustre in via di
estinzione. All'interno del
cariceto è stata rinvenuta
la primulacea Hottonia
palustris, pianta rarissima
in tutta l'Italia
peninsulare e probabile
unico esemplare superstite
nel Padule di Bientina. Le
raccolte di acqua sottoposte
ad essiccamento estivo
vedono lo sviluppo di
vegetazioni di prato umido
che annoverano specie molto
rare come la Ladwigia
palustris. Le piante
idrofite, necessitando della
presenza d'acqua per
l'intero ciclo vitale,
vivono confinate in alcuni
canali e fossi; tra di esse
meritano menzione il morso
di rana, la ninfea bianca,
la rarissima erba scopina e
l'erba vescica, pianta
carnivora il cui nome
volgare è attribuibile alla
presenza di piccole
vescicole sulle foglie atte
alla cattura di piccoli
invertebrati acquatici. La
ricchezza degli ambienti
vegetazionali dell'area, la
cui variabilità è
incrementata dal periodico
allagamento di alcune zone,
che determina un’ulteriore
diversificazione stagionale,
favorisce la presenza di
numerose ed interessanti
specie animali. Le specie
vertebrate presenti sono
strettamente condizionate
dalla ricchezza di acqua;
tuttavia non manca una fauna
meno legata a questo
particolare ecosistema.
Negli ambienti palustri sono presenti specie nidificanti quali il pendolino, la cannaiola, il cannareccione, il bengalino comune e la gallinella d'acqua. Durante le stagioni invernali è presente il migliarino di padule in migrazione e l'usignolo di fiume che è nidificante. Tra gli ardeidi è stata rilevata la presenza dell'airone cenerino, soprattutto in autunno e inverno, della garzetta durante il periodo primaverile e dell'airone guardabuoi. In estate sono avvistabili l'airone rosso, la garza ciuffetto e la nitticora. Tra gli anseriformi sono stati osservati il germano reale, l'alzavola (nella stagione invernale) e la marzaiola. I rapaci avvistabili con più frequenza sono la poiana (tutto l'anno), il nibbio bruno (durante le stagioni migratorie), il falco di padule e la albarella reale (in inverno). I falconiformi sono rappresentati dal gheppio e dallo smeriglio; gli strigiformi da civetta, barbagianni, allocco e assiolo, presente durante la stagione riproduttiva. Il bosco è visitato regolarmente dal picchio verde e dal picchio rosso maggiore. La presenza d'acqua limitata al periodo fra l'autunno e la primavera costituisce l'habitat ideale per le specie di anfibi che trovano nel vicino bosco un rifugio ottimale per trascorrere gli stati di ibernazione ed estivazione. Le specie di anfibi avvistate sono cinque: il tritone punteggiato, il rospo, la raganella, la rana agile e il complesso delle rane verdi. I mammiferi presenti a Tanali sono il cinghiale, l'istrice, la volpe, la talpa e il riccio. All'interno della riserva sono presenti due strutture che fungono da osservatori, fruibili su richiesta.
Indirizzo: Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia Settore Tutela della Natura e del Mare Indirizzo sede centrale: Via di Novoli 26 - 50127 Firenze
Info dettagliate sul web a:
http://www.centrornitologicotoscano.org/site/pub/Pagina1.asp?IdPaginaTestuale=tanali
http://www.centrornitologicotoscano.org/site/pub/Index.asp
http://www.zoneumidetoscane.it/it/le-aree/bosco-di-tanali/lambiente
https://www.comune.bientina.pi.it/it/Informazioni/Oasi.html
https://www.comune.bientina.pi.it/it/Informazioni/Oasi.html
http://www.legambientevaldera.it/bosco_tanali_9.html
Come arrivarci? Fornacette, Bientina e quindi frazione Caccialupi (direzione Lucca) poi, trovato un distributore Total si parcheggia e si torna indietro a piedi per m.50 e si trova l’indicazione del bosco.
ll Padule di Fucecchio
Il Padule di Fucecchio ha un’estensione di circa 1800 ettari, divisi fra la Provincia di Pistoia e la Provincia di Firenze; se pur ampiamente ridotto rispetto all'antico lago-padule che un tempo occupava gran parte della Valdinievole meridionale, rappresenta tuttora la più grande palude interna italiana. La zona naturalisticamente più interessante è situata prevalentemente nei Comuni di Larciano, Ponte Buggianese e Fucecchio. Da un punto di vista geografico, il Padule è un bacino di forma pressappoco triangolare situato nella Valdinievole, a sud dell’Appennino Pistoiese, fra il Montalbano e le Colline delle Cerbaie. Il principale apporto idrico deriva da corsi d’acqua provenienti dalle pendici preappenniniche. L’unico emissario del Padule, il canale Usciana, scorre più o meno parallelamente all’Arno per 18 chilometri e vi sfocia in prossimità di Montecalvoli (PI). Il valore di quest’area è incrementato dalla sua contiguità con altre zone di grande pregio ambientale: il Montalbano, le Colline delle Cerbaie ed il Laghetto di Sibolla, collegato al Padule tramite il Fosso Sibolla. La Riserva Naturale del Padule di Fucecchio è dotata di strutture per la visita che comprendono anche tre osservatori faunistici, uno dei quali realizzato tramite la riconversione di uno dei caratteristici casotti del Padule.
1) Riserva Naturale del Padule di Fucecchio - Area Le Morette (itinerario mattutino)
L' escursione di oggi ci porterà
nella Riserva Naturale del
Padule di Fucecchio ed in
particolare nell'area de Le
Morette, raggiunta dopo una
breve sosta al Centro Visite di
Castelmartini per prendere
visione dell'area prima della
nostra passeggiata
naturalistica.
Il sentiero è
pianeggiante e consente di
ammirare paesaggi suggestivi
fino ad arrivare all'antico
Porto de Le Morette.
L'itinerario ci porterà nel
cuore della palude a raggiungere
il Casotto del Biagiotti, da
molti anni adibito ad
osservatorio faunistico
dell'area protetta, con
un’ottima visuale sugli specchi
d’acqua della Riserva Naturale
e, se la stagione sarà stata
piovosa, sulle
numerose specie di uccelli acquatici presenti: gli aironi europei, che nidificano in grandi colonie sugli alberi e nel canneto, gli Svassi maggiori nelle acque più profonde e gli eleganti Cavalieri d'Italia sulle rive degli argini. Arrivati all'area Righetti (più protetta) torneremo indietro per portarci poi a Monsummano Alto ed alla Rocca. Nota: portare un binocolo perchè ovviamente le nidificazioni sono lontane dalla presenza umana.
note più approfondite in: http://www.zoneumidetoscane.it/it/le-aree/padule-di-fucecchio/lambiente.
2)
Visita alla rocca fortificata di
Monsummano Alto
(visita pomeridiana)
Il colle di Monsummano
costituiva un luogo viario
strategico, in posizione
dominante sul Padule di
Fucecchio e sulla Valdinievole,
e per questo fu fortificato
almeno dall'XI secolo con un
sistema difensivo accresciuto ed
ampliato nel corso del
tempo.Dell'antico castello si
conservano oggi i resti della
cerchia ellittica delle mura,
che lo cingevano per un
perimetro di circa due
chilometri e due delle tre porte
di accesso: la porta di "Nostra
Donna" e quella detta "del
Mercato" verso il colle di
Montevettolini.
Delle numerose torri di cui era
munito il castello resta,
all'estremità occidentale della
cinta muraria, una robusta e
imponente torre pentagonale,
databile nella sua forma attuale
agli inizi del XIV secolo.
L'edificio meglio conservato del
borgo è la Chiesa di San Nicolao,
prospiciente l'antica platea
communis, fondata nell'XI secolo
e compresa nel plebato di Neure
(o deMontecatino), entro la
diocesi medievale di Lucca. Di
fianco alla chiesa è presente
una terrazza panoramica naturale
con l'antica chiesa di San
Sebastiano, di fronte alla quale
recenti scavi hanno portato alla
luce le fondamenta di due
edifici, dove sono stati
rinvenuti frammenti di ceramica
di varie epoche. Seminascosti
dalla boscaglia che circonda il
nucleo centrale del castello si
conservano ad ovest i resti di
un convento e nella zona
orientale, nei pressi della
torre, i ruderi dell'antico
Spedale di San Bartolomeo. Dalla
cima del Colle si ha una visuale
unica sul Padule di Fucecchio,
sui castelli della Valdinievole
e sul Monte Pisano; nelle
giornate più limpide lo sguardo
arriva fino alle
colline livornesi, alle balze di
Volterra e alle torri di San
Gimignano.
 2019
2019 Il camaiorese è una zona ricca
di charme e tradizione che si estende dalle vette delle Alpi Apuane fino al mar
Ligure, nel cuore della Versilia. Idealmente si può parlare di quattro grandi
aree: le colline delle Seimiglia, il capoluogo con la sua valle, la piana di
Capezzano ed infine il litorale di Lido di Camaiore e ciascuna di esse ha
tipicità particolari, dalle pendici dei monti ricoperti da boschi che, man mano
che si sale, divengono pascolo alpino, al piano che divide la costa dalle
colline ad ovest o anche alle piccole oasi, con le caratteristiche originali del
territorio paludoso tipico delle pianure costiere mediterranee. La possibilità
esplorativa quindi è molto ampia ma il percorso definitivo sarà tuttavia
comunicato in seguito, molto dipendendo dalle informazioni che ci perverranno
sulla manutenzione di alcuni importanti sentieri, ad oggi ancora da rivisitare
da parte delle cooperative incaricate di controllarne l’agibilità.
Il camaiorese è una zona ricca
di charme e tradizione che si estende dalle vette delle Alpi Apuane fino al mar
Ligure, nel cuore della Versilia. Idealmente si può parlare di quattro grandi
aree: le colline delle Seimiglia, il capoluogo con la sua valle, la piana di
Capezzano ed infine il litorale di Lido di Camaiore e ciascuna di esse ha
tipicità particolari, dalle pendici dei monti ricoperti da boschi che, man mano
che si sale, divengono pascolo alpino, al piano che divide la costa dalle
colline ad ovest o anche alle piccole oasi, con le caratteristiche originali del
territorio paludoso tipico delle pianure costiere mediterranee. La possibilità
esplorativa quindi è molto ampia ma il percorso definitivo sarà tuttavia
comunicato in seguito, molto dipendendo dalle informazioni che ci perverranno
sulla manutenzione di alcuni importanti sentieri, ad oggi ancora da rivisitare
da parte delle cooperative incaricate di controllarne l’agibilità.







 In Val di Cecina, nella parte meridionale della
provincia di Pisa ed a 15 minuti dalla costa tirrenica, felicemente posizionato
per le terre e la campagna, andremo
In Val di Cecina, nella parte meridionale della
provincia di Pisa ed a 15 minuti dalla costa tirrenica, felicemente posizionato
per le terre e la campagna, andremo 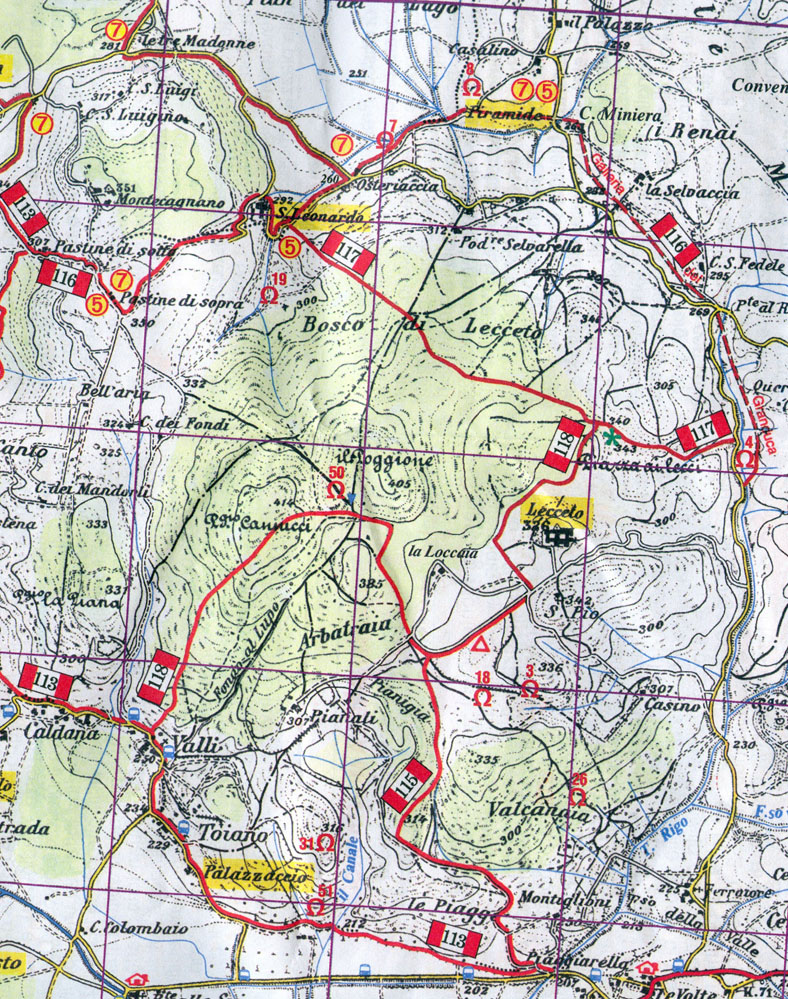

 le sue origini
siano più recenti, verosimilmente tardo
settecentesche, costruito
per rendere raggiungibile una fornace di mattoni oltre il botro Riardo, anche durante
eventuali periodo di piena. L’escursione
inizierà dal paese del Gabbro per raggiungere i vecchi lavatoi, un itinerario
che veniva seguito dalle donne del Gabbro per andare ad attingere l’acqua ed a
lavare i panni dalla seconda metà del 1600 fino alla seconda del 1900.
Saremo parzialmente sul “sentiero del mille” (tracciato altomedioevale che
collegava i borghi collinari a Vada e quindi al mare, anche se la costa era
tuttavia raggiungibile ben prima, prendendo per la via vecchia della Marina
le sue origini
siano più recenti, verosimilmente tardo
settecentesche, costruito
per rendere raggiungibile una fornace di mattoni oltre il botro Riardo, anche durante
eventuali periodo di piena. L’escursione
inizierà dal paese del Gabbro per raggiungere i vecchi lavatoi, un itinerario
che veniva seguito dalle donne del Gabbro per andare ad attingere l’acqua ed a
lavare i panni dalla seconda metà del 1600 fino alla seconda del 1900.
Saremo parzialmente sul “sentiero del mille” (tracciato altomedioevale che
collegava i borghi collinari a Vada e quindi al mare, anche se la costa era
tuttavia raggiungibile ben prima, prendendo per la via vecchia della Marina
 del m.Pelato), per boschi e viottoli di campagna che si alternano piacevolmente, in
un trekking di circa h.4/4.30, escluse le soste.
del m.Pelato), per boschi e viottoli di campagna che si alternano piacevolmente, in
un trekking di circa h.4/4.30, escluse le soste. alla
fonte è possibile scorgere una edicola votiva originaria del 600, che custodisce
un quadro della Madonna, ed alcuni cunicoli nei quali i Gabbrigiani si
nascondevano per sfuggire ai bombardamenti dell’ultima guerra mondiale. Si ha
notizia dei lavatoi fin dal 1682, quando vengono stanziati dalla Comunità del
Gabbro: "25 scudi per fare un arco e muro attorno alla Fonte del Ricaldo, per
far venire l'acqua a doccio, fare un abbeveratoio per le bestie.Il rifornimento
di acqua potabile avveniva presso le due fonti distanti un
chilometro dal paese sulla parte destra della strada che porta a Castelnuovo
della
alla
fonte è possibile scorgere una edicola votiva originaria del 600, che custodisce
un quadro della Madonna, ed alcuni cunicoli nei quali i Gabbrigiani si
nascondevano per sfuggire ai bombardamenti dell’ultima guerra mondiale. Si ha
notizia dei lavatoi fin dal 1682, quando vengono stanziati dalla Comunità del
Gabbro: "25 scudi per fare un arco e muro attorno alla Fonte del Ricaldo, per
far venire l'acqua a doccio, fare un abbeveratoio per le bestie.Il rifornimento
di acqua potabile avveniva presso le due fonti distanti un
chilometro dal paese sulla parte destra della strada che porta a Castelnuovo
della
 Misericordia. Veniva anche attinta a una fonte situata nella località
Riardo, anche questa distante oltre un chilometro dal paese, lungo una strada
secondaria che porta verso la località di Staggiano. Dopo il 1945 la fonte fu
chiusa e l'acqua incanalata, a mezzo di un piccolo acquedotto, fu fatta affluire
alla Fornace Serredi per le necessità della lavorazione. L'acqua veniva
trasportata giornalmente alle abitazioni dalle donne che portavano sulla testa
brocche o canestre piene di fiaschi e da ragazzi con carrettino, con
corbellini anche questi pieni di fiaschi. La lontananza delle fonti causava
fatica e perdita di tempo specialmente nell'estate quando si doveva fare la fila
perchè il getto dell'acqua diminuiva. Le donne spesso si recavano, portando
sempre grosse canestre in testa, a lavare i panni ai due lavatoi pubblici, cioè
a quello di Rialdo e a quello che si trova dalla parte opposta, sulla via che
dal Gabbro porta a Castelnuovo della Misericordia. Due fonti di incerta
potabilità, una chiamata fonte di Giomo sulla via Taversa Livornese per
Castelnuovo poco prima della località Stregonie e l'altra situata nelle
vicinanze, fornivano acqua, per far fronte alle diverse necessità degli
agricoltori e dei possidenti, i quali riempivano damigiane e botticelle che
trasportavano con carri trainati da buoi o con barrocci trainati da cavalli o di
ciuchi. Dopo il 1945 il comune di Rosignano Marittimo, dietro le insistenti
richieste dei paesani, deliberò di fare l'acquedotto per portare l'acqua
potabile in paese. Fu allora incanalata l'acqua delle due fonti e, utilizzate
altre sorgenti a mezza costa della collina di Poggio d'Arco, fu creato un
deposito sul Poggio Pelato. Col passar del tempo le fonti del paese furono
integrate da altre direttamente installate nelle case avendo così gli utenti
l'acqua sempre a disposizione senza fatica, con vantaggi igienici e senza
perdita di tempo. Purtroppo quando il Comune, per approvvigionare l'acqua
potabile al paese di Nibbiaia, decise di alimentare l'acquedotto con altra acqua
presa lungo il fiume Sanguigna, in località Bucafonda, la situazione peggiorò
sia come qualità sia come quantità. testo da -
Misericordia. Veniva anche attinta a una fonte situata nella località
Riardo, anche questa distante oltre un chilometro dal paese, lungo una strada
secondaria che porta verso la località di Staggiano. Dopo il 1945 la fonte fu
chiusa e l'acqua incanalata, a mezzo di un piccolo acquedotto, fu fatta affluire
alla Fornace Serredi per le necessità della lavorazione. L'acqua veniva
trasportata giornalmente alle abitazioni dalle donne che portavano sulla testa
brocche o canestre piene di fiaschi e da ragazzi con carrettino, con
corbellini anche questi pieni di fiaschi. La lontananza delle fonti causava
fatica e perdita di tempo specialmente nell'estate quando si doveva fare la fila
perchè il getto dell'acqua diminuiva. Le donne spesso si recavano, portando
sempre grosse canestre in testa, a lavare i panni ai due lavatoi pubblici, cioè
a quello di Rialdo e a quello che si trova dalla parte opposta, sulla via che
dal Gabbro porta a Castelnuovo della Misericordia. Due fonti di incerta
potabilità, una chiamata fonte di Giomo sulla via Taversa Livornese per
Castelnuovo poco prima della località Stregonie e l'altra situata nelle
vicinanze, fornivano acqua, per far fronte alle diverse necessità degli
agricoltori e dei possidenti, i quali riempivano damigiane e botticelle che
trasportavano con carri trainati da buoi o con barrocci trainati da cavalli o di
ciuchi. Dopo il 1945 il comune di Rosignano Marittimo, dietro le insistenti
richieste dei paesani, deliberò di fare l'acquedotto per portare l'acqua
potabile in paese. Fu allora incanalata l'acqua delle due fonti e, utilizzate
altre sorgenti a mezza costa della collina di Poggio d'Arco, fu creato un
deposito sul Poggio Pelato. Col passar del tempo le fonti del paese furono
integrate da altre direttamente installate nelle case avendo così gli utenti
l'acqua sempre a disposizione senza fatica, con vantaggi igienici e senza
perdita di tempo. Purtroppo quando il Comune, per approvvigionare l'acqua
potabile al paese di Nibbiaia, decise di alimentare l'acquedotto con altra acqua
presa lungo il fiume Sanguigna, in località Bucafonda, la situazione peggiorò
sia come qualità sia come quantità. testo da -